Matthias Grünewald (1480–1528) / Nikolaus Hagenauer (1445–1538), Retable d'Issenheim, circa 1512-1516, huile sur bois, 269 x 307, Unterlinden Museum, Colmar.
N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l’i ne passera de la Loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l’un de ces moindres préceptes, sera tenu pour moindre dans le Royaume des cieux ; au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le Royaume de cieux " (Mt 5, 17-19).
Aussi bien l’Église a-t-elle déclaré au Concile Vatican II : " Ce qui a été commis durant la passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors, ni aux Juifsde notre temps. (...) Les Juifs ne doivent pas être présentés comme réprouvés par Dieu, ni maudits comme si cela découlait de la Sainte Écriture " (NA 4).
Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute, ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés. Puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à Notre-SeigneurJésus-Christ le supplice de la croix, à coup sûr ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal " crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu’il est en eux, le Fils de Dieu par leurs péchés et le couvrent de confusion " (He 6, 6). Et il faut le reconnaître, notre crime à nous dans ce cas est plus grand que celui des Juifs. Car eux, au témoignagede l’apôtre, " s’ils avaient connu le Roi de gloire, ils ne l’auraient jamais crucifié " (1 Co 2, 8). Nous, au contraire, nous faisons profession de Le connaître. Et lorsque nous Le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur Lui nos mains meurtrières (Catech. R. 1, 5, 11).
Et les démons, ce ne sont pas eux qui L’ont crucifié ; c’est toi qui avec eux L’as crucifié et Le crucifies encore, en te délectant dans les vices et les péchés (S. François d’Assise, admon. 5, 3).
En dehors de la Croix il n’y a pas d’autre échelle par où monter au ciel (Ste. Rose de Lima, vita).
Dieu [le Fils] n’a pas empêché la mort de séparer l’âme du corps, selon l’ordre nécessaire à la nature, mais il les a de nouveau réunis l’un à l’autre par la Résurrection, afin d’être lui-même dans sa personne le point de rencontre de la mort et de la vie en arrêtant en lui la décomposition de la nature produite par la mort et en devenant lui-même principe de réunion pour les parties séparées (S. Grégoire de Nysse, or. catech. 16 : PG 45, 52B).
Du fait qu’à la mort du Christ l’âme a été séparée de la chair, la personne unique ne s’est pas trouvée divisée en deux personnes ; car le corps et l’âme du Christ ont existé au même titre dès le début dans la personne du Verbe ; et dans la mort, quoique séparés l’un de l’autre, ils sont restés chacun avec la même et unique personne du Verbe (S. JeanDamascène, f. o. 3, 27 : PG 94, 1098A).
La
Crucifixion du Christ, Évangiles de Rabula, 586, 33, 5 x 25,5,
Florence, Bibliothèque Médicéo-Laurentine.
Venerdì Santo - Passione del Signore
Il Venerdi Santo e il
giorno della Croce. In tutta la vicenda umana e storica di Gesù, la « Passione
» designa da sempre l’insieme degli avvenimenti dolorosi che lo colpirono fino
alla morte in croce.
Quante e quante volte i
nostri occhi si sono posati su un Crocifisso o una semplice croce, in questo mondo
distratto, superattivo, superficiale?
Quante volte entrando in
una chiesa o passando davanti a delle edicole religiose agli angoli delle
strade, sui sentieri di campagna o di montagna, o mettendola al collo sia per
devozione, sia per moda, i nostri occhi hanno visto la Croce; quante volte sin
da bambini ci siamo segnati con il segno della Croce, recitando una preghiera o
guardando il Crocifisso appeso alla parete della nostra stanza da letto,
iniziando e terminando così la nostra giornata.
La Croce simbolo del
cristianesimo, presente nella nostra vita sin dalla nascita, nei segni del rito
del Battesimo, nell’assoluzione nel Sacramento della Penitenza, nelle
benedizioni ricevute e date in ogni nostro atto devozionale e sacramentale;
fino all’ultimo segno tracciato dal sacerdote nel Sacramento degli Infermi,
nella croce astile che precede il funerale e nella croce di marmo o altro
materiale, poggiata sulla tomba.
Così presente nella
nostra vita e pur tante volte ignorata e guardata senza che ci dica niente, con
occhio distratto e abituato; eppure la Croce è il supremo simbolo della
sofferenza e della morte di Gesù, vero Dio e vero uomo, che con il Suo
sacrificio ci ha riscattato dalla morte del peccato, indicandoci la vera Vita
che passa attraverso la sofferenza.
Gesù stesso con le Sue
parabole insegnò che il seme va sotterrato, marcisce e muore, per dare nuova
vita alla pianta che da lui nascerà.
In tutta la vicenda umana
e storica di Gesù, la “Passione” culminata nel Venerdì Santo, designa da sempre
l’insieme degli avvenimenti dolorosi che lo colpirono fino alla morte in croce.
E questo insieme di atti progressivi e dolorosi prese il nome di “Via Crucis”
(pratica extraliturgica, introdotta in Europa dal domenicano beato Alvaro,
(†1402), e dopo di lui dai Frati Minori Francescani); che la Chiesa Cattolica,
ricorda in ogni suo tempio con le 14 ‘Stazioni’; quadretti attaccati alle
pareti, oppure lungo i crinali delle colline dove sorgono Santuari, meta di
pellegrinaggi; con edicole, gruppi statuari o cappelle, che invitano alla
meditazione e penitenza; in ognuna di queste ‘Stazioni’ sono raffigurati con
varie espressioni artistiche, momenti della dolorosa “Via Crucis” e Passione di
Gesù; espressione di alta simbologia ed arte, sono ad esempio i Sacri Monti
come quelli di Varallo e di Varese, e i celebri Calvari bretoni.
La “Passione” di Gesù
cominciò dopo l’Ultima Cena tenuta con gli Apostoli, dove Egli diede
all’umanità il dono più grande che si potesse: sé stesso nel Sacramento
dell’Eucaristia, inoltre l’istituzione del Sacerdozio cristiano e la grande
lezione di umiltà e di amore verso il prossimo con la lavanda dei piedi dei
Dodici Apostoli.
I Vangeli raccontano gli
avvenimenti in modo abbastanza preciso e concorde; nella primavera dell’anno
30, Gesù discese con i suoi discepoli dalla Galilea a Gerusalemme, in occasione
della Pasqua ebraica, l’annuale “memoriale” della prodigiosa liberazione del
popolo ebreo dall’Egitto.
Qui tenne l’Ultima Cena,
dove di fatto fu sostituito il vecchio “memoriale” con il nuovo, da rinnovare
nel tempo fino al suo ritorno: “Questo è il mio corpo, che è dato per voi”;
“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi”;
“Fate questo in memoria di me!”.
Nella “redenzione dal peccato”
si deve ricercare in buona parte, il senso della ‘Passione’ di Cristo e di
questo trattano i racconti evangelici, nel susseguirsi degli avvenimenti che
seguirono l’Ultima Cena; è bene ricordare che lo stesso Gesù preannunziò ciò
che sarebbe accaduto ai suoi discepoli per ben tre volte, preparandoli al suo
destino di sofferenze e di gloria; in particolare la terza volta (Luca 18,
31-33).
Ma il suo sacrificio, è
presentato nei Vangeli anche come l’attuazione della parola dei profeti,
contenuta nelle Scritture e si delinea una grande verità, consegnandosi mite e
benevole nelle mani di uomini che faranno di lui quello che vorranno,
l’”Agnello di Dio” ha preso su di sé e ha ‘tolto’ il peccato del mondo
(Giovanni 1,29).
Per questo si nota che
nel racconto evangelico della Passione, ogni atto è presentato come malvagio,
ingiusto e crudele; anche tutti coloro che intervengono nei confronti di Gesù
sono cattivi o meglio peccatori, come una sequenza impressionante dei peccati
degli uomini contro di Lui.
È necessario che il male
ed il peccato si scateni contro Gesù, portandolo fino alla morte e dando la
sensazione di aver vinto il Bene; finché con la Sua Resurrezione alla fine si
vedrà che la vittoria finale sul male, è la sua.
La ‘Passione’ si svolge con
una sequenza di immagini drammatiche, prima di tutto il tradimento di Giuda,
che lo vende e lo denuncia con un bacio nel giardino posto al di là del
torrente Cedron, dove si era ritirato a pregare con i suoi discepoli, e dove
Gesù, aveva avuto la visione angosciante della prossima fine, sudando sangue e
al punto di chiedere al Padre di far passare, se era possibile, questo calice
amaro di sofferenza, ma nel contempo accettò di fare la Sua volontà.
Segue l’arresto notturno
da parte dei soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei;
Gesù subisce l’interrogatorio di Anna, ex sommo sacerdote molto potente e
suocero del sommo sacerdote in carica Caifa; poi il giudizio del Sinedrio
giudaico capeggiato da Caifa, che formula ad ogni costo un’accusa che consenta
la sua condanna a morte, che però per la legge vigente a Gerusalemme, non
poteva essere attuata dalle autorità ebraiche.
Nel contempo si concreta
il triplice rinnegamento del suo primo discepolo Pietro; poi Gesù viene
condotto dal governatore romano Ponzio Pilato, accusato di essersi proclamato
re dei Giudei, commettendo quindi un delitto di lesa maestà verso l’imperatore
romano.
Nel confronto con Pilato,
Gesù afferma la sua Regalità; nonostante che non si ravvisa in lui colpa alcuna,
l’attaccamento al potere, la colpevole viltà del governatore, non fanno
prendere una decisione a Pilato, che secondo il Vangelo di Luca (23,6) non
volendo pronunciarsi, lo manda da re Erode, presente in quei giorni a
Gerusalemme; il quale dopo un’inutile interrogatorio e istigato dai sommi
sacerdoti e scribi, lo schernisce insultandolo, poi rivestito di una splendida
veste lo rimanda da Pilato.
Ancora una volta Pilato
titubante chiede al popolo che colpa ha quest’uomo, perché lui non ne trova;
alle grida di condanna lo fa flagellare, pensando che così si calmassero, ma
questi gridarono sempre più forte di crocifiggerlo; allora Pilato secondo le consuetudini
locali, potendo liberare un prigioniero in occasione della Pasqua, chiese al
popolo se intendevano scegliere fra Gesù e un ribelle prigioniero di nome
Barabba, che aveva molti morti sulla coscienza, ma anche in questa scelta il
popolo si espresse gridando a favore di Barabba.
Non potendo fare altro,
il governatore simbolicamente si lavò le mani e condannò a morte Gesù, tramite
la crocifissione, pena capitale praticata in quell’epoca e lo consegnò ai
soldati.
I soldati con feroce
astuzia, posero sul capo di Gesù, schernendolo, una corona di spine pungenti e
caricarono sulle sue spalle, già straziate da una lacerante flagellazione, il
“patibulum”, avviandosi verso la collina del Golgota o Calvario, luogo
dell’esecuzione.
La “Via Crucis” di Gesù
presenta alcuni incontri non tutti riportati concordemente dai quattro
evangelisti, come l’incontro con Simone di Cirene, obbligato dai soldati a
portare la croce di Gesù o a condividerne il peso; l’incontro con le donne di
Gerusalemme alle quali dice con toni apocalittici di piangere su loro stesse;
l’incontro con la Veronica, le cadute sull’erta salita.
Arrivati sulla cima del
calvario, viene dai soldati spogliato delle sue vesti, che vennero tirate a
sorte fra gli stessi soldati, poi crocifisso con chiodi alla croce, tortura
orribile e atroce, che conduce Gesù alla morte dopo qualche ora, sempre fra
insulti e offese, alla fine invece di spezzargli le gambe per accelerarne la
morte per soffocamento, essendo già morto, la lancia di un centurione gli
perforerà il costato per accertarsene.
C’è ancora tutta una
serie di episodi che si verificano prima e dopo la sua morte, come il suicidio
di Giuda, lo scambio di parole con i due ladroni, crocifissi anche loro in
quell’occasione, lo squarcio del Velo del Tempio di Gerusalemme, il terremoto,
lo sconvolgimento degli elementi atmosferici, la presenza ai piedi della Croce
di Maria sua madre, di Maria di Magdala (Maddalena), di Maria di Cleofa, madre
di Giacomo il Minore e Giuseppe, di Salome madre dei figli di Zebedeo e da
Giovanni il più giovane degli apostoli; l’affidamento reciproco fra Maria e
Giovanni; le sue ultime parole prima di morire.
La ‘Passione’ si
conclude, dopo la deposizione affrettata per l’approssimarsi della festività
del sabato, con la sepoltura del suo corpo mortale in una tomba data da
Giuseppe d’Arimatea, anche lui diventato suo discepolo, avvolto in un candido
lenzuolo e cosparso degli oli e aromi usuali, poi la tomba scavata nella
roccia, venne chiusa da una grossa pietra.
In questo contesto finale
s’inserisce l’esistenza e la venerazione per la Sacra Sindone, conservata nel
Duomo di Torino, prova tangibile dei patimenti e del metodo crudele subito da
Gesù per la crocifissione.
Dato il poco spazio
disponibile, si è dovuto necessariamente essere veloci nel descrivere
praticamente la ‘Passione di Nostro Signore’, ma questo storico evento lo si
può meditare ampliamente, partecipando ai riti della Settimana Santa, che da
millenni la Chiesa cattolica e le altre Chiese Cristiane celebrano.
Aggiungiamo solo che Gesù
ha voluto con la sofferenza e la sua morte, prendere su di sé le sofferenze e i
dolori di ogni genere dell’umanità, quasi un “chiodo scaccia chiodo”; indicando
nel contempo che la sofferenza è un male necessario, perché iscritto nella
storia di ogni singolo uomo, come lo è la morte del corpo, come conseguenza del
peccato, ma essa può essere trasformata in una luce di speranza, di
compartecipazione con le sofferenze degli altri nostri fratelli, che
condividono con noi, ognuno nella sua breve o lunga vita terrena, il cammino
verso la patria celeste.
Questo concetto e
valorizzazione del dolore fu nei millenni cristiani, ben compreso ed assimilato
da tante anime mistiche, al punto di non desiderare altro che condividere i
dolori della ‘Passione’; ottenendo da Cristo di portare nel loro corpo i segni
visibili e tormentati di tanto dolore; come pure per tanti ci fu il sacrificio
della loro vita, seguendo l’esempio del Redentore, per l’affermazione della
loro fede in Lui e nei suoi insegnamenti.
Ecco allora la schiera
immensa dei martiri che a partire sin dai primi giorni dopo la morte di Gesù e
fino ai nostri giorni, patirono e morirono violentemente, con metodi anche
forse più strazianti della crocifissione, come quello di essere dilaniati vivi
dalle belve feroci; bruciati vivi sui roghi; fatti a pezzi dai selvaggi nelle
Missioni; scorticati vivi, ecc.
Poi riferendoci a quando
prima accennato ai segni della ‘Passione’ sul proprio corpo, solo per citarne
qualcuno: Le Stimmate di s. Francesco di Assisi, di s. Pio da Pietrelcina, la
spina in fronte di s. Rita da Cascia, ecc.
La triste e dolorosa
vicenda della ‘Passione’, ha ispirato da sempre la pietà popolare a partecipare
ai riti del Venerdì Santo, con manifestazioni di grande suggestione e
penitenza, con le processioni dei ‘Misteri’, grandi e piccole raffigurazioni,
con statue per lo più di cartapesta, dei vari episodi della ‘Via Crucis’, in
particolare l’incontro di Gesù che trasporta la croce con sua madre e le pie donne;
oppure con Gesù morto, condotto al sepolcro, seguito dall’effige della Vergine
Addolorata.
In tutte le chiese, a
partire dal Colosseo con il papa, si svolgono le ‘Vie Crucis’, anche per le
strade dei Paesi e nei rioni delle città; in alcuni casi per secolare
tradizione esse sono svolte da fedeli con i costumi dell’epoca e giungono fino
ad una finta crocifissione; in altri casi da secoli si svolgono cortei
penitenziali di Confraternite con persone incappucciate o no, che si flagellano
o si pungono con oggetti acuminati e così insanguinati proseguono nella
processione penitenziale, come nella celebre penitenza di Guardia
Sanframondi.
Ci vorrebbe un libro per
descriverle tutte, ma non si può dimenticare di citare i riti barocchi del
Venerdì Santo di Siviglia.
Alla ‘Passione’ di Gesù è
associata l’immagine della Vergine Addolorata, che i più grandi artisti hanno
rappresentato insieme alla Crocifissione, ai piedi della Croce, o con Cristo
adagiato fra le sue braccia dopo la deposizione, come la celebre ‘Pietà’ di
Michelangelo, il ‘Compianto sul Cristo morto’ di Giotto, la ‘Crocifissione’ di
Masaccio, per citarne alcuni.
Il soggetto della
‘Passione’, ha continuato ad essere rappresentato anche con le moderne
tecnologie, le quali utilizzando attori capaci, scenografie naturali e
drammaticità delle espressioni dolorose; ha portato ad un più vasto pubblico
nazionale ed internazionale l’intera vicenda terrena di Gesù.
È il caso soprattutto del
cinema, con tanti filmati di indubbio valore emotivo, come “Il Vangelo secondo
Matteo” di Pier Paolo Pasolini; il “Gesù di Nazareth” di Franco Zeffirelli, la
serie di quelli storici e colossali, come “Il Re dei re”, “La tunica”, ecc.
fino all’ultimo grandioso per la sua drammaticità “La Passione di Cristo” di
Mel Gibson.
Inoltre la televisione
presente ormai in ogni casa, ha riproposto ad un pubblico ancor più vasto le
produzioni televisive ed i tanti films con questo soggetto, che per questioni
economiche e per la crisi delle sale cinematografiche, non sarebbero stati più
visti.
Il Venerdì Santo è il
giorno della Croce, di questo simbolo che è di guida ai cristiani e nel
contempo tiene lontani altri da questa religione, che per tanti versi ha al suo
centro il dolore e la sofferenza, seppure accettata e trasfigurata; e si sa che
a nessuno piace soffrire e tutti vorrebbero tendere alla felicità senza prima soffrire.
A conclusione si
riportano i soggetti delle XIV Stazioni della Via Crucis:
I = Il processo e la
condanna;
II = Il carico sulle
spalle della croce;
III = La prima
caduta;
IV = L’incontro con la
Madre;
V = L’aiuto del
Cireneo;
VI = L’incontro con la
Veronica;
VII = Seconda
caduta;
VIII = L’incontro con le
donne di Gerusalemme;
IX = Terza caduta;
X = Gesù denudato e posto
sulla croce;
XI = La
crocifissione;
XII = La morte in
Croce;
XIII = La
deposizione;
XIV = La sepoltura nella
tomba.
Autore: Antonio
Borrelli
SOURCE : http://www.santiebeati.it/dettaglio/20258
Jean Fouquet, Pietà dite de Nouans,
vers 1465, Huile sur bois (noyer), 168 x 259, église paroissiale
Saint-Martin, Nouans-les-Fontaines, département de l'Indre-et-Loire
Michel-Ange Pietà, 1498-1499, basilique Saint-Pierre du Vatican à Rome, représentant le thème biblique de la « Vierge Marie douloureuse » (Mater
dolorosa en latin ou Pietà), tenant sur ses genoux le corps du Christ descendu de la Croix avant sa Mise au tombeau, sa Résurrection et son Ascension.
Caravage. La Mise au tombeau, 1602-1604,Musées du Vatican, Rome.
Domenico Beccafumi, Descente du Christ aux
Enfers. Pinacothèque nationale de Sienne.
Sabato Santo
Nel Sabato Santo
predomina il silenzio, il raccoglimento, la meditazione, per Gesù che giace nel
sepolcro ; poi verrrà la gioia della sera con la Veglia Pasquale e con la
Resurrezione di Cristo, Figlio di Dio.
Nella Settimana Santa
della Liturgia cristiana, che va dalla Domenica delle Palme alla Domenica di
Pasqua, vi sono tre giorni che primeggiano per la loro solennità ed unicità, ed
è il “Triduo Pasquale”, nel quale si commemora la crocifissione, sepoltura e
Resurrezione di Gesù Cristo ed incomincia con la Messa vespertina del Giovedì
Santo, prosegue con i riti del Venerdì Santo; al suo centro c’è la Veglia
pasquale e si chiude ai Vespri della Domenica di Pasqua.
Se nel Giovedì Santo
predomina la solennità dell’istituzione dell’Eucaristia, dell’istituzione del
Sacerdozio e della Chiesa di Cristo; se nel Venerdì Santo predomina la
mestizia, il dolore e la penitenza, nel ricordare la Passione e morte di Gesù,
con la sua sepoltura; nel Sabato Santo invece predomina il silenzio, il
raccoglimento, la meditazione, per Gesù che giace nel sepolcro; poi verrà la
gioia della Domenica di Pasqua con la sua Resurrezione, ma nel sabato incombe
il silenzio del riposo della morte.
Con la nostra
meditazione, andiamo col pensiero, alla disperazione e disorientamento degli
Apostoli e degli amici di Gesù, che dopo averlo seguito nei suoi itinerari in
Galilea, assistito ai suoi prodigi, ascoltato i suoi insegnamenti, così pieni
di speranza e innovativi per quell’epoca, l’avevano visto poi morire così
tragicamente, senza che qualcosa o qualcuno, tanto meno Lui stesso, abbia
bloccato questo ingiusto e assurdo evento.
Tutto prenderà poi
un’altra luce, il peso che opprime il loro animo si trasformerà in gioia e
sollievo, alla notizia della Sua Resurrezione, ma il Sabato, cioè il giorno
dopo la morte, che per gli Ebrei era il giorno sacro e del più assoluto riposo,
resterà cupo e pieno di sgomento per loro, che ignoravano ciò che sarebbe avvenuto
dopo.
Ma nella liturgia, non
sempre è stato così, a partire dal IV secolo in alcuni luoghi, in questo giorno
i candidati al Battesimo (Catecumeni), facevano la loro pubblica professione di
fede, prima di venire ammessi nella Chiesa, rito che avveniva poi nella Veglia
di Pasqua.
Verso il XVI secolo, si
cominciò con un’anticipazione della Vigilia alla mattina del Sabato Santo,
forse perché non era consigliabile stare di notte fuori casa, ad ogni modo
questa anticipazione al mattino del Sabato, è durata fino agli ultimi anni
Cinquanta del XX secolo; ricordo personalmente che la “Gloria” si “scioglieva”
verso le 10-11 del mattino del sabato, con il suono delle campane, appunto
“sciolte” dai legami messi la sera del Giovedì Santo.
Poi con la riforma
liturgica Conciliare, tutto è ritornato come alle origini e il Sabato ha
ripreso il significato del giorno della meditazione e penitenza; l’oscurità
nelle chiese è totale, non vi sono celebrazioni liturgiche, né Sante Messe; è
l’unico giorno dell’anno che non si può ricevere la S. Comunione, tranne nel
caso di Viatico per gli ammalati gravi.
Tutto è silenzio
nell’attesa dell’evento della Resurrezione. Quanto tempo restò sepolto nel
sepolcro Gesù? Furono tre giorni non interi, dalla sera del Venerdì fino
all’alba del giorno dopo la festa del Sabato ebraico, che oggi è la Domenica di
Pasqua, ma che per gli Ebrei era il primo giorno della settimana; in tutto durò
circa 40 ore.
Bisogna dire che con la
liturgia odierna, la “Veglia Pasquale” è prevista in buona parte delle nostre
chiese e cattedrali, con inizio verso le 22,30-23 del sabato; ma la “Veglia”,
madre di tutte le Veglie celebrate dalla Liturgia cristiana, pur iniziando
nell’ultima ora del sabato, di fatto appartiene alla Liturgia solenne della Pasqua.
Durante la “Veglia” viene
benedetto il fuoco, il ‘cero pasquale’, l’acqua battesimale; cercando di far
coincidere il canto del ‘Gloria’, con il suono delle campane a festa, verso
mezzanotte. In altre zone la “Veglia” inizia verso mezzanotte e quindi la
liturgia eucaristica prosegue nelle prime ore notturne.
La cerimonia della
“Veglia” è riportata nella scheda del sito alla voce “Pasqua di Resurrezione”
(ID 20260).
Autore: Antonio
Borrelli







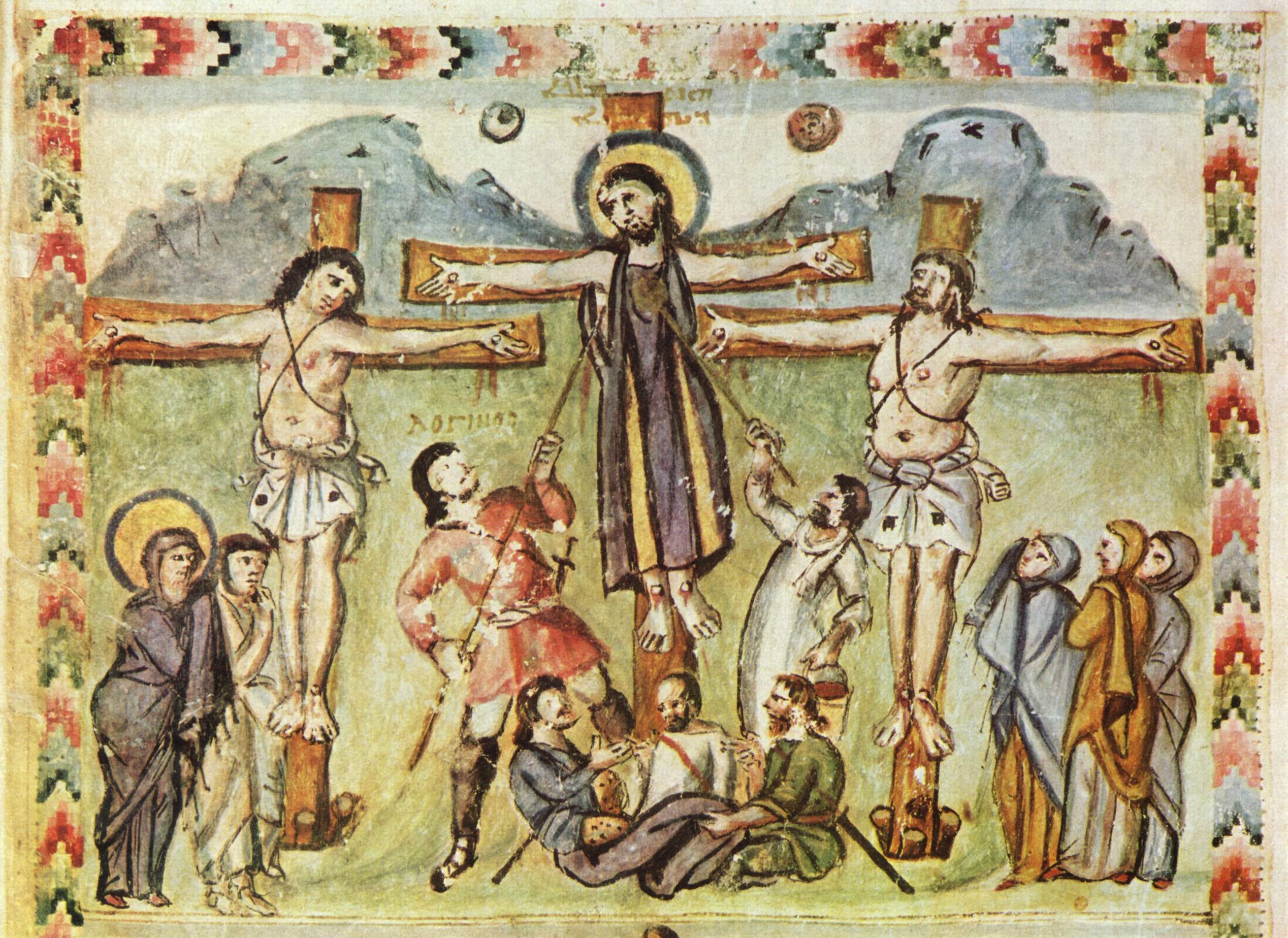


.jpg)


