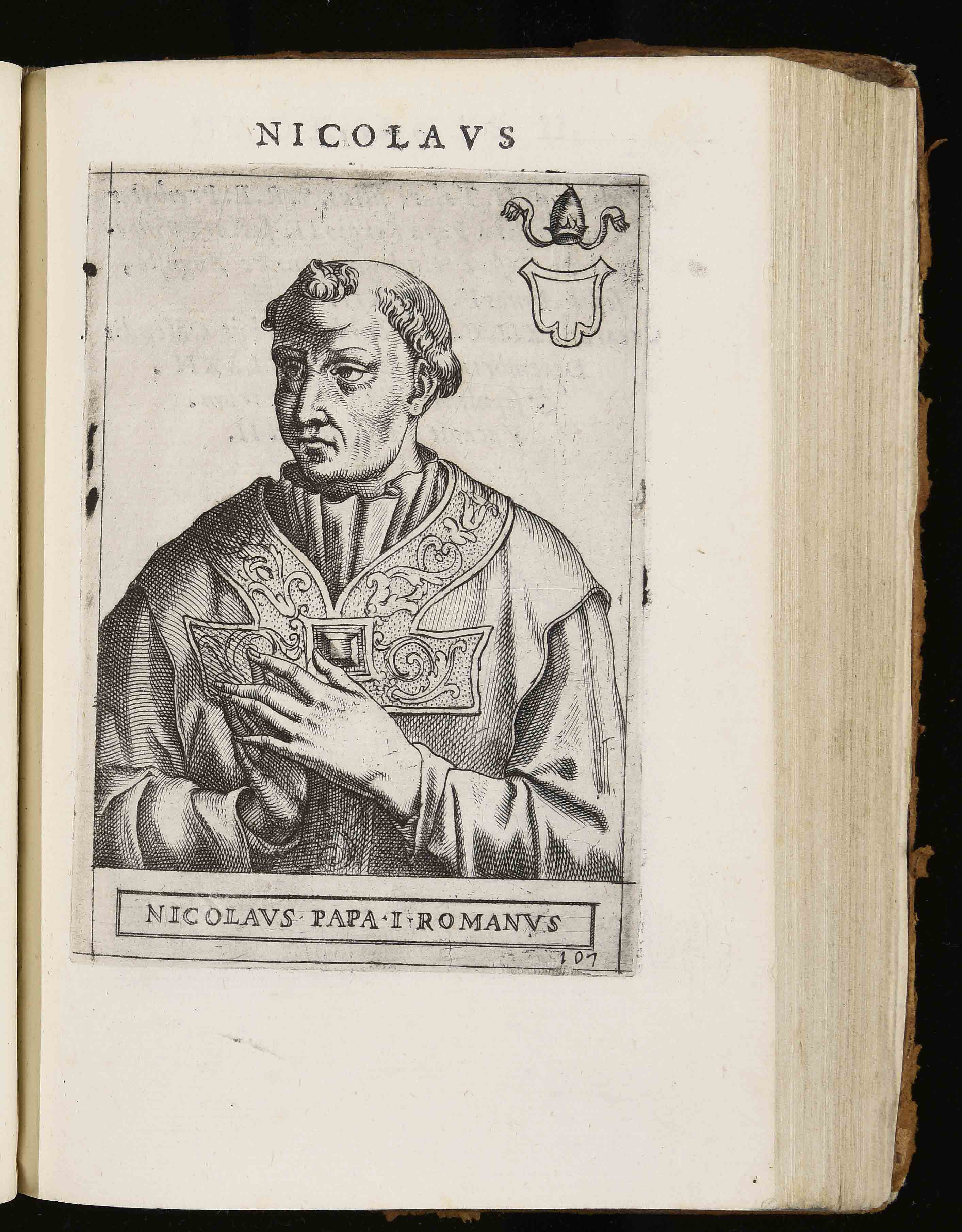Illustration
extraite de The Lives and Times of the
Popes (1842) du Chevalier Artaud de Montor (1772–1849), New
York: The Catholic Publication Society of America, 1911
Saint Nicolas Ier le Grand
Pape (105 ème) de 858 à 867 (+ 867)
Pape d'une brillante personnalité, il sauvegarda la liberté de l'Eglise face à deux empereurs: Michel en Orient et Lothaire en Occident. Il connut bien des difficultés avec le patriarche de Constantinople, Photius. Il fut aussi un pape missionnaire. C'est lui qui envoie saint Anschaire de Corbie, monastère en Picardie, évangéliser la Scandinavie et d'autres saints moines convertir les païens bulgares.
À Rome, près de saint Pierre, en 867, saint Nicolas Ier, pape, qui montra une
vigueur apostolique pour affermir l’autorité du pontife romain dans toute
l’Église de Dieu.
Martyrologe romain
SOURCE : http://nominis.cef.fr/contenus/saint/93/Saint-Nicolas-Ier-le-Grand.html
13 novembre
Saint Nicolas 1er, le
Grand
Fils du régionnaire Théodore,
un très important fonctionnaire de la ville, Nicolas naquit à Rome au début du
IX° siècle. Nanti d'une solide culture, Nicolas, pieux, intelligent,
vertueux et travailleur, entra dans les ordres et fit toute sa carrière dans la
Curie, au patriarcharum du Latran. Sous-diacre de Serge II
(844-847), diacre attaché à Léon IV (847-855), il fut un si proche
conseiller de Benoît III (855-858) qu’il assura le gouvernement de
l'Eglise lorsque l’infortuné pontife, à peine élu et non encore couronné, fut
arrêté par les missi de l’empereur Louis II qui lui préférait
Anastase (21 septembre 855). Le clergé romain, barricadé dans la basilique
des Quatre-Saints-Couronnés, résista et les missi s’inclinèrent.
Benoît III ne tint le Saint-Siège que deux ans et demi et mourut le 10 mars 858
Avec l’approbation de
l’Empereur, présent à Rome, Nicolas, après à peine quinze jours de vacance du
Siège, fut élu, quasi à l'unanimité, à la succession de Benoît III ; présenté
par l'empereur Louis II, acclamé par le peuple, soutenu par le clergé vertueux,
le pape Nicolas I° fut sacré à Saint-Pierre de Rome le 24 avril 858.
Après Grégoire le Grand
(590-604) et avant Grégoire VII (1073-1085), Nicolas I° fut le premier
grand pape médiéval, alliant la piété, l'autorité, l'activité, la charité
et l'intelligence. Ayant su s'entourer de personnages efficaces et cultivés, il
s'appuya fermement sur tout ce que l'Eglise connaissait de textes législatifs
et administratifs. Il sut aussi s’attacher les ennemis de ses prédécesseurs et
choisit des conseillers dans l’entourage de Louis II, au point qu’Anastase le
Bibliothécaire que Benoît III avait fait abbé de Sainte-Marie-du-Trantévère,
devint un des plus brillants rédacteurs de la chancellerie pontificale et le
biographe de Nicolas I°. Profitant du mouvement de l'époque, il se mit
au-dessus des empereurs en leur refusant d'intervenir dans les affaires de
l'Eglise et se posa comme dernier recours pour toutes les affaires. Son
autorité fut telle qu’il put s’imposer aux monarques carolingiens : Charles le
Chauve recourut à lui lorsque son frère, Louis le Germanique, malgré la foi
jurée, envahit la France (858), et, quatre ans plus tard, lorsque ses deux
fils, Charles et Louis, se révoltèrent contre lui en Aquitaine ; quand le roi
de Lotharingie, Lothaire II, avec l’appui de ses évêques, voulut divorcer,
Nicolas fulmina l’excommunication et le roi eut beau l’assiéger au Vatican, le
pape l’emporta. Nicolas le Grand affirmait sa primauté pontificale sur toutes
les églises d’Occident dont il était le patriarche : il intervint pour défendre
ou pour soumettre les archevêques métropolitains en Bretagne, en Touraine, en
Champagne, à Ravenne, à Vienne ... Gêné par l'insubordination de quelques
grands évêques, en particulier par Hincmar de Reims, alors le plus puissant
évêque d'Occident, et par le patriarche Jean de Ravenne, le Pape les fait
plier. Si quelqu’un brave les dogmes, les ordres, les interdictions, les
sanctions ou les décrets promulgués sainement par le chef du siège apostolique, lit-on
dans l’ultime canon du concile romain qu’il avait rassemblé en 863, qu’il
s’agisse de la foi catholique, de la discipline ecclésiastique, de la
réprimande des fidèles, du châtiment des scélérats, des interdictions
concernant les maux imminents ou futurs, qu’il soit anathème.
Le peuple romain l’aima
en raison de ses grandes charités, au point de professer qu’il n’y eut
dans toute la ville un seul pauvre qui ne vécût des bienfaits du saint pontife.
Il venait juste de monter sur le trône de Pierre, lorsque, le 30 octobre 860,
le Tibre déborda, le Pape organisa les secours aux sinistrés qu’il accueillit
dans l’hospice de Sainte-Marie. Durant tout son pontificat, il fut
attentif aux aveugles et aux infirmes. Il entreprit efficacement la défense de
la ville contre les Sarrasins et, à cet effet, construisit la place forte
d’Ostie où il entretint une garnison considérable. Il condamnait toute guerre
qui ne fût pas proprement défensive et proscrivit comme un crime la torture des
voleurs et des brigands.
En Orient où Nicolas I°
entendait aussi s’imposer, son règne entier fut empoisonné par le patriarche
Photius de Constantinople. Au printemps 860, on apprit la démission et le
remplacement du patriarche Ignace de Constantinople dont le pape était
officiellement averti par la profession de foi orthodoxe envoyée par son
successeur. Le fait était si surprenant que le Pape, profitant de ce que
l’Empereur demandait qu’il lui envoyât deux représentants au concile qui devait
régler une fois pour toutes l’affaire des images, députa deux légats (Radoald,
évêque de Porto, et Zacharie, évêque d’Anagni) avec mission d’enquêter sur
place à propos de la démission d’Ignace (septembre 860). Les deux légats furent
achetés par l'empereur Michel qui, en fait, avait déposé le Patriarche et
l’avait fait enfermer sur l’île de Thérébinthe (été 858) pour le remplacer
par Photius, savant laïc à sa solde et président de la chancellerie impériale,
qui, en six jours avait reçu tous les ordres et fut sacré à Noël par l’évêque
Grégoire Asbestas, évêque de Syracuse, qu’Ignace avait anathémisé et
déposé ; malgré ses promesses formelles, Photius avait réuni un synode
pour déposer Ignace (859). Le synode réuni le 6 avril 861, avec l’accord des
légats, déposa Ignace et reconnut Photius ; Nicolas I° désavouant ses
légats fit savoir à l’Empereur et au prétendu patriarche, en rappelant la
primauté romaine, qu’il considérait toujours Ignace comme patriarche de
Constantinople. Ignace envoya au Pape un Libellus (fin 862) et le
synode romain d’avril 863 déclara l’irrégularité de l’élection et de l’ordination
de Photius qu’il priva de toute dignité ecclésiastique. Il s'ensuivit
d’interminables négociations, ourlées de correspondances violentes, tandis que
Rome était opposée à Constantinople à propos de la juridiction sur la Bulgarie
dont le roi Boris venait de recevoir le baptême (864). Le Pape ne voulut céder
sur rien mais proposa de faire entendre Ignace et Photius devant un synode
romain (28 septembre 865). Cependant, à propos de la Bulgarie, le
pseudo-patriarche Photius ameutait par une encyclique les églises d'Orient
contre l'Eglise d'Occident et ses pratiques, fournissant ainsi tout ce qui fera
désormais l’arsenal critique orthodoxe contre les catholiques romains :
jeûne du samedi, permission des laitages dans la semaine qui précède le carême,
célibat des prêtres, réitération de la confirmation conférée par de simples
prêtres et surtout le Filioque. Au mois d’août 867, il réunit à
Constantinople un concile prétendument œcuménique qui, en septembre, excommunia
et déposa Nicolas I°, lequel ne le sut jamais, puisqu’il mourut le 13 novembre
867, non sans avoir rallié contre Photius les théologiens latins. L'Empereur
Michel avait été assassiné par Basile (24 septembre 867) qui força Photius à la
démission, rappela Ignace (23 novembre 867) et renoua avec Rome alors sous le
pontificat d’Hadrien II.
Nicolas I°, malade
depuis plusieurs années, mourut à Rome, après neuf ans et sept mois de
pontificat, le 13 novembre 867 et fut enterré à Saint-Pierre du
Vatican. Son principal collaborateur Anastase resta à la bibliothèque du
Vatican d'où il ne manqua pas de conserver tout ce qui avait trait au Pape de
sa jeunesse.
La ferveur populaire le
plaça au nombre des saints mais il faut attendre la fin du Moyen-Age pour que
l'Eglise le fasse officiellement en l'associant à la fête de Saint Nicolas
(6 décembre). Il fut fêté à partir de 1850 au 5 novembre et, à partir
de 1883, au 13 novembre.
SOURCE : http://missel.free.fr/Sanctoral/11/13.php
Saint Nicolas (Niccolò) Ier, le Grand
Pape (105e) de 858 à 867
Nicolas, fils d’un très
important fonctionnaire de la ville, naît à Rome au début du IXe siècle. Nanti
d'une solide culture, pieux, intelligent, vertueux et travailleur, entra dans
les ordres et fit toute sa carrière dans la Curie, au patriarcharum du
Latran.
Sous-diacre de Serge II (844-847), diacre attaché à Léon IV
(847-855), il fut un si proche conseiller de Benoît III (855-858) qu’il
assura le gouvernement de l'Église lorsque l’infortuné pontife, à peine élu et
non encore couronné, fut arrêté par les missi de l’empereur Louis II qui lui
préférait Anastase (21 septembre 855). Le clergé romain, barricadé dans la
basilique des Quatre-Saints-Couronnés, résista et les missi s’inclinèrent.
Benoît III ne tint le Saint-Siège que deux ans et demi et mourut le 10 mars 858.
Avec l’approbation de
l’Empereur, présent à Rome, Nicolas, après à peine quinze jours de vacance du
Siège, fut élu, quasi à l'unanimité, à la succession de Benoît III ; présenté
par l'empereur Louis II, acclamé par le peuple, soutenu par le clergé vertueux,
le pape Nicolas I fut sacré à Saint-Pierre de Rome le 24 avril 858.
Après Grégoire le Grand
(590-604) et avant Grégoire VII (1073-1085), Nicolas Ier fut le
premier grand pape médiéval, alliant la piété, l'autorité, l'activité, la
charité et l'intelligence. Ayant su s'entourer de personnages efficaces et
cultivés, il s'appuya fermement sur tout ce que l'Église connaissait de textes
législatifs et administratifs. Il sut aussi s’attacher les ennemis de ses
prédécesseurs et choisit des conseillers dans l’entourage de Louis II, au point
qu’Anastase le Bibliothécaire, que Benoît III avait fait abbé de
Sainte-Marie-du-Transtevere, devint un des plus brillants rédacteurs de la
chancellerie pontificale et le biographe de Nicolas Ier. Profitant du mouvement
de l'époque, il se mit au-dessus des empereurs en leur refusant d'intervenir
dans les affaires de l'Église et se posa comme dernier recours pour toutes les
affaires.
Nicolas le Grand affirmait sa primauté pontificale sur toutes les églises
d’Occident dont il était le patriarche : il intervint pour défendre ou pour
soumettre les archevêques métropolitains en Bretagne, en Touraine, en
Champagne, à Ravenne, à Vienne. Gêné par l'insubordination de quelques grands
évêques, en particulier par Hincmar de Reims, alors le plus puissant évêque
d'Occident, et par le patriarche Jean de Ravenne, le Pape les fait plier.
Le peuple romain l’aima
en raison de ses grandes charités, au point de professer qu’il n’y eut dans
toute la ville un seul pauvre qui ne vécût des bienfaits du saint pontife. Il
venait juste de monter sur le trône de Pierre, lorsque, le 30 octobre 860, le Tibre
déborda, le Pape organisa les secours aux sinistrés qu’il accueillit dans
l’hospice de Sainte-Marie. Durant tout son pontificat, il fut attentif aux
aveugles et aux infirmes. Il entreprit efficacement la défense de la ville
contre les Sarrasins et, à cet effet, construisit la place forte d’Ostie où il
entretint une garnison considérable. Il condamnait toute guerre qui ne fût pas
proprement défensive et proscrivit comme un crime la torture des voleurs et des
brigands.
En Orient, où Nicolas Ier
entendait aussi s’imposer, son règne entier fut empoisonné par le patriarche
Photius de Constantinople. Photius avait réuni un synode pour déposer Ignace
(859). Le synode réuni le 6 avril 861, avec l’accord des légats, déposa Ignace
et reconnut Photius ; Nicolas Ier désavouant ses légats fit savoir à
l’Empereur et au prétendu patriarche, en rappelant la primauté romaine, qu’il
considérait toujours Ignace comme patriarche de Constantinople. Ignace envoya
au Pape un Libellus (fin 862) et le synode romain d’avril 863 déclara
l’irrégularité de l’élection et de l’ordination de Photius qu’il priva de toute
dignité ecclésiastique. Il s'ensuivit d’interminables négociations, ourlées de
correspondances violentes, tandis que Rome était opposée à Constantinople à
propos de la juridiction sur la Bulgarie dont le roi Boris venait de recevoir
le baptême (864). Le Pape ne voulut céder sur rien mais proposa de faire
entendre Ignace et Photius devant un synode romain (28 septembre 865).
Cependant, à propos de la Bulgarie, le pseudo-patriarche Photius ameutait par
une encyclique les églises d'Orient contre l'Église d'Occident et ses
pratiques. Au mois d’août 867, il réunit à Constantinople un concile
prétendument œcuménique qui, en septembre, excommunia et déposa Nicolas Ier, lequel
ne le sut jamais, puisqu’il mourut le 13 novembre 867, non sans avoir rallié
contre Photius les théologiens latins. L'Empereur Michel avait été assassiné
par Basile (24 septembre 867) qui força Photius à la démission, rappela Ignace
(23 novembre 867) et renoua avec Rome alors sous le pontificat d’Adrien II.
Nicolas Ier, malade
depuis plusieurs années, mourut à Rome, après neuf ans et sept mois de
pontificat, le 13 novembre 867 et fut enterré à Saint-Pierre du Vatican.
La ferveur populaire le plaça au nombre des saints mais il faut attendre la fin
du Moyen-Age pour que l'Église le fasse officiellement en l'associant à la fête
de Saint Nicolas (6 décembre).
Il fut fêté à partir de
1850 au 5 novembre et, à partir de 1883, au 13 novembre.
SOURCE : https://levangileauquotidien.org/FR/display-saint/c7575d27-96c4-43b3-b7ff-f11c63dd39f5
Saint Nicolas Iᵉʳ, Pape
Réformateur et Défenseur de l’Église
Pape et confesseur
Date : 867
Fête : 13 novembre
Pape : saint Nicolas Iᵉʳ
Nicolas Iᵉʳ était romain
de naissance, son père se nommait Théodore. Après la mort de Benoît III
(855-858), il fut élu avec une unanimité de suffrages admirable par le clergé ;
on le tira par force de la basilique du prince des Apôtres, on l’entraîna dans
l’église patriarcale de Latran, et on le proclama Pontife romain, l’an 858. Il
avait pratiqué la piété et toutes les vertus dès son bas âge.
Serge II le fit
sous-diacre de l’Église romaine ; Léon IV le créa diacre ; enfin, il fut d’un
grand secours à Benoît III dans le gouvernement de l’Église universelle. Il
existe un grand nombre de lettres écrites par lui, dans lesquelles il redresse
ceux qui s’égarent, rabaisse les superbes, et relève les opprimés, évêques,
rois, empereurs, il contint tout le monde dans le devoir. Il brisa la
résistance opiniâtre de Jean, archevêque de Ravenne ; il reprit fortement
Hincmar, archevêque de Reims, de l’injuste déposition de Rhotad, évêque de
Soissons, cassa la sentence qu’il avait portée avec le concile de Senlis, et
réintégra l’évêque dans sa dignité et dans son siège. Il fit revenir à la
raison, par une menace d’anathème, le roi Lothaire qui avait répudié sa
légitime épouse Teutberge, pour épouser Waldrade, sa concubine. Il réprouva
l’élection de Photius qui était laïque, et rétablit sur son siège le patriarche
Ignace. II défendit si bien les droits de l’Église romaine, que ses lettres
sont regardées comme autant d’ouvrages avancés qui protègent le Siège
apostolique.
Il ne borna pas ses soins
aux affaires intérieures de l’Église, il s’occupa de la conversion des
infidèles ; il amena à Jésus-Christ et rattacha à l’Église romaine la nation
très-nombreuse des Bulgares, malgré les grincements de dents d’un empereur
schismatique. En même temps, il était très assidu à ses devoirs particuliers de
piété ; il se fit donner les noms de tous les indigents afin de pouvoir les
mieux secourir. II répara et orna les églises de Rome, en particulier la
basilique de Latran. Enfin, il passa de la terre au ciel au commencement de la
dixième année de son pontificat (13 novembre 867), et fut enseveli au Vatican.
Combien le pécheur est à
plaindre ! Quel bonheur que sa conversion ! 1° Autant le péché
dégrade la nature humaine devenue esclave du vice, autant une sincère
conversion fait éclater le pouvoir qu’à la grâce de la rétablir dans l’état
dont elle était déchue. 2° Pour comprendre jusqu’à quel point l’image
de Dieu est défigurée dans l’homme par le péché, il surfit de considérer le
désordre qui règne dans ses facultés spirituelles, son entendement et sa
volonté, qui, dans la création, portaient l’empreinte de la ressemblance
divine. 3° L’homme n’a pas seulement à se plaindre de la révolte des
animaux et des autres créatures, ainsi que de celle de son corps, qui est lié
en proie à la maladie et à la mort : tout en lui n’est que ténèbres, à la
faveur desquelles les passions rebelles s’efforcent d’usurper l’empire sur la
raison et sur la vertu.
Oraison
Ô saint Nicolas Iᵉʳ, toi
qui as guidé l’Église avec force et compassion, intercède pour nous afin que
nous restions fermes dans la foi et la charité.
Vie du Pape Saint Nicolas
1er
article ajouté le
13/11/2023 dans la catégorie : Vie
des Saints
Pape Nicolas Ier,
également connu sous le nom de saint Nicolas le Grand, a marqué l'histoire de
l'Église catholique au IXe siècle. Né à Rome vers 800, il devint pape en 858,
succédant au pape Benoît III. Sa vie fut façonnée par des défis théologiques et
politiques cruciaux qui firent de son pontificat une période charnière.
Nicolas Ier naquit dans
une époque de bouleversements politiques et ecclésiastiques. Son élection au
poste de pape en 858 survint dans un contexte où les relations entre l'Église
et l'Empire étaient souvent tendues. Dès le début de son pontificat, il fut
confronté à des enjeux majeurs, notamment la question de l'autorité papale et
les tensions avec l'Empire carolingien dirigé par l'empereur Louis II.
L'une des contributions
les plus significatives de Nicolas Ier à l'histoire de l'Église fut son rôle
dans la défense de l'autorité papale. Il affirma que le pape avait une autorité
suprême sur toutes les questions religieuses et pouvait intervenir dans les
affaires des évêques locaux. Cette position affirmée avec vigueur contribua à
renforcer le pouvoir du Saint-Siège au cours des siècles suivants.
Un autre défi majeur de
son pontificat fut la querelle photienne. Nicolas Ier s'opposa au patriarche de
Constantinople, Photius, en raison de conflits théologiques et politiques. La
querelle aboutit à un schisme entre l'Église d'Orient et d'Occident, marquant
une division persistante dans le christianisme.
Nicolas Ier était
également profondément engagé dans des questions pastorales et spirituelles. Il
encouragea la vie monastique, promut la célébration des sacrements et s'efforça
de maintenir la discipline ecclésiastique. Sa passion pour la foi catholique
orthodoxe et son zèle pour la préservation des traditions ecclésiastiques
laissent un héritage durable dans l'Église.
Son pontificat fut
également marqué par des défis internes, notamment des conflits avec des
évêques dissidents et des prêtres. Cependant, Nicolas Ier se montra inflexible
dans la défense de la foi catholique, ce qui renforça la cohésion de l'Église.
Nicolas Ier décéda le 13
novembre 867, laissant derrière lui un héritage important dans l'histoire de
l'Église. Bien qu'il n'ait pas été officiellement canonisé, il est souvent
honoré en tant que saint en raison de sa vie exemplaire et de son rôle crucial
dans le renforcement de l'autorité papale. Les théologiens et les historiens
reconnaissent généralement l'importance de son pontificat dans le développement
de la papauté et dans la préservation de la foi catholique.
Nicolas Ier le Grand,
pape
Nicolas, fils du régionnaire Théodore, un très important fonctionnaire de la ville, naît à Rome vers 800/820.
Nanti d'une solide culture, Nicolas, pieux, intelligent, vertueux et travailleur, entre dans les ordres et fait toute sa carrière dans la Curie, au patriarcharum du Latran.
Sous-diacre de Serge II (844-847), puis diacre attaché à Léon IV (847-855), il est un proche conseiller de Benoît III (855-858).
A la mort de Benoît III (17 avril 858), il est élu pape, avec l’approbation de l’empereur Louis II présent à Rome ; il est sacré le 24 avril 858.
Nicolas est un des hommes les plus remarquables de son temps ; il montre une grande fermeté dans tous les actes de son pontificat ; il s’attache à maintenir dans leur intégrité les principes du christianisme et se fait aimer à Rome par ses vertus, notamment par son inépuisable charité.
Il tient tête à Lothaire II qui le protège néanmoins ; il consacre la majeure partie de son pontificat à empêcher le divorce demandé par Lothaire II, roi de Lorraine, qui songe à se remarier (le roi cherche à obtenir son divorce d’avec la reine stérile Theutberge pour épouser sa concubine Waldrade dont il a un fils, Hugues), cassant les sentences des conciles nationaux favorables au roi et excommuniant les évêques qui apportent leur soutien à ce dernier.
Il envoie saint Anschaire de Corbie évangéliser la Scandinavie.
Il s’appuie sur les fausses décrétales pour soumettre les ecclésiastiques francs à Rome.
Il fait respecter le droit des évêques à faire appel au Vatican face à l’autorité de leurs supérieurs.
Il soutient Rothade, évêque de Soissons, contre Hincmar, archevêque de Reims.
Il interdit aux princes bretons de transformer Dol en archevêché, rappelle aux métropolites son autorité sur eux et affirme sa primauté sur l'archevêque de Ravenne.
Il ajoute à Sainte-Marie-in-Cosmedin, un oratoire en l'honneur de son saint patron : Nicolas.
Il meurt à Rome le 13 novembre 867.
Saint Nicolas Ier dit le Grand est fêté le 13 novembre. Son zèle et sa fermeté
à défendre l’autorité du Saint-Siège lui ont valu une place dans le martyrologe
romain ; selon sa propre expression "les canons ont voulu que de toutes
les parties du monde on appelât à l’autorité du souverain pontife, dont il
n’est point permis d’appeler". Il s'est dit le "représentant de Dieu sur
terre".
Au XIe siècle, dans sa Chronique de l'année 868, Réginon de Prüm écrit à
son sujet : « Depuis le bienheureux Grégoire,
il n’y eut pas sur le trône de saint Pierre de pontife comparable à Nicolas
Ier. Il a dompté des rois et des tyrans ; il a gouverné le monde en maître ; il
était doux et plein de mansuétude envers les évêques et les prêtres qui avaient
de la piété ; mais, envers ceux qui manquaient de vertu et de conscience, il
était terrible ».
"Pape d'une brillante personnalité, il sauvegarda la liberté de l'Eglise
face à deux empereurs : Michel en Orient et Lothaire en Occident. Il connut
bien des difficultés avec le patriarche de Constantinople, Photius.
Il fut aussi un pape missionnaire. C'est lui qui envoie saint Anschaire de
Corbie, monastère en Picardie, évangéliser la Scandinavie et d'autres saints moines
convertir les païens bulgares." 2
858. 24 avril, sacre du
pape. Le pape demande à Ignace et à Photios de venir à Rome ; Photios refuse
; le pape annule l’élection de Photios au patriarcat de Constantinople où il
est remplacé par Ignace. 11 mai, à Dunhuang en Chine, impression, par Wan Jie,
du premier livre : une édition xylographique (procédé de gravure sur bois)
du Sutra de diamant, le plus ancien livre-rouleau imprimé conservé. En
août, Louis le Germanique, à l'appel des grands du royaume de Francie
occidentale, rassemble ses forces à Worms, traverse la Lotharingie par le Col
de Saverne et Bar-le-Duc et entre en Neustrie. 1er septembre, les leudes
révoltés de Neustrie rejoignent Louis le Germanique à Ponthion et lui prêtent
serment ; de là, ils se rendent à Sens, où archevêque Ganelon a pris le parti
de Louis, puis entrent en Orléanais, peut-être pour faire leur jonction avec
les Aquitains et les Bretons révoltés. 12 novembre, les armées de Charles le
Chauve et de Louis le Germanique, depuis trois jours en présence à Brienne,
sont prêtes à se livrer bataille, lorsque Charles abandonne ses soldats, dont
il se méfie, et s'enfuit en Bourgogne auprès du comte Conrad d'Auxerre. 25
novembre, synode de Quierzy : les évêques de Francie occidentale envoient une
lettre de reproche à Louis le Germanique. 7 décembre, Louis le Germanique est à
Attigny où il signe un diplôme comme roi de Francie occidentale, après avoir
déposé son frère Charles le Chauve : ce dernier n'est sauvé que par l'intervention
du clergé dirigé par Hincmar de Reims ; Louis doit se retirer en janvier
suivant. Hincmar de Reims tente vainement de christianiser les guildes
(tailleurs de pierres, verriers, négociants), qui se réunissent en conjurations
lors de la fête du dieu païen Yule (26 décembre) dans de gigantesques banquets.
859-862. Les Vikings, venus d’Espagne et du Portugal, ravagent la côte
marocaine, gagnent la Toscane, détruisent Pise et remontent jusqu’au Rhône à
Valence où ils sont arrêtés.
859. Girard de Vienne fonde le monastère de Vézelay. 11 mars, décapitation
d'Euloge, évêque de Cordoue, arrêté parce qu’il prône la résistance contre
l’arabisation de la société et a recueilli une jeune musulmane devenue
chrétienne, Léocricia ou Lucrèce, laquelle sera exécutée le 15 (Martyrologe).
28 mai, synode de Metz convoqué par Hincmar en présence de Lothaire II et de
Charles le Chauve : une délégation de neuf évêques est envoyé à Louis le
Germanique pour qu'il reconnaisse ses torts dans l'invasion de la Neustrie en
858. En juillet, échec de l'entrevue d'Andernach entre Charles le Chauve et
Louis le Germanique. En septembre, Charles le Chauve est sur la Loire. 13
octobre, Charles le Chauve est à Tusey, près de Toul. Hiver très rude, probablement
le plus froid du IXe siècle.
Vers 860. Le Varègue Riourik fonde Novgorod. Fin de la rédaction du Martyrologe du
moine Usuard.
860. 9 janvier et mi-Février, conciles d'Aix-la-Chapelle : Theutberge, épouse
de Lothaire II, est accusé d'inceste et enfermée dans un couvent ; elle
s'échappe et se réfugie auprès de son frère Hucbert ; début de la crise du
divorce de Lothaire II (Lothaire II, n'ayant pas d'héritier de sa femme
Theutberge, cherche à divorcer pour épouser sa maîtresse Waldrade qui lui a
donné un fils) ; ce divorce provoque l'opposition de l'archevêque de Reims
Hincmar et du pape. Poussée arabe contre l'empire byzantin en Anatolie appuyée
par les pauliciens de
Karbeas (fin en 863). En avril, les Vikings de la Somme, commandés par Weeland,
acceptent 3 000 livres d'argent pour attaquer ceux de la Seine ; ils accordent
un délai à Charles le Chauve puis passent en Angleterre avec des otages. Avril
à mai, les Vikings de Hasteinn et Björn Côte de fer, après avoir hiverné en
Camargue, vont à Arles et Nîmes, remontent le Rhône et sont refoulés à Romans
par Girart de Roussillon, comte de Vienne pendant l'été ou au début de
l'automne ; ils se rendent en Italie où ils pillent Pise et d'autres villes.
1er juin, une bande de Danois, qui ont débarqué sur l'Yser, attaquent les
monastères de Saint-Omer et de Saint-Bertin le jour de Pentecôte désertés par
les moines, puis ravagent le Ternois. 1er au 7 juin, Conférence de Coblence :
paix entre Charles le Chauve, Lothaire II et Louis le Germanique. 18 juin,
commandés par Askold et Dir, les Slaves de Kiev et les Varègues (200 bateaux)
organisent une expédition maritime contre Constantinople ; en l'absence de
l'empereur Michel III, la ville est facilement assiégée, mais une forte tempête
éloigne les envahisseurs qui subissent une grave défaite sur terre ; les
Byzantins attribuent cette circonstance fortuite à l'intercession de la Vierge
et l'épisode sera commémoré sous le nom de fête du Pokrov (Voile). 30 octobre,
crue du Tibre : Nicolas organise les secours aux sinistrés qu’il accueille dans
l’hospice de Sainte-Marie.
861. En janvier, les Vikings dévastent Paris et l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés ; ils pillent Melun. 25 mai, au concile de
Constantinople, le patriarche de Constantinople Ignace est déposé
et Photios confirmé. En juin, plaid de Compiègne : Charles le
Chauve confie au duc Robert le Fort la mission de défendre la région
entre Seine et Loire (Marche de Neustrie). 25 juin,
ouverture du concile de Pîtres (Eure).
862. Riourik fonde le premier Etat russe. Baudoin, comte de Flandres,
enlève et épouse la fille de Charles II le Chauve : le scandale remonte en vain
jusqu’au pape.
Vers 863. Sur les conseils de Photios, l’empereur envoie Cyrille et
Méthode chez les Khazars (tribu turque convertie au judaïsme)
: ils évangélisent la Dalmatie, la Hongrie et la Bulgarie ; Cyrille traduit la
Bible en slavon et invente l’alphabet glagolitique ; l’alphabet
glagolitique ne ressemble à aucun alphabet connu ; l’alphabet dit cyrillique,
plus proche du grec par la forme des lettres, ne tarde pas à supplanter le
précédent et reste seul en usage.
863. 24 janvier, mort de Charles, roi de Provence et fils de Lothaire : son
royaume est partagé entre ses frères Lothaire II et Louis II. Au concile de
Rome, au début de l'année, quelques iconoclastes abjurent
leur erreur, et disent anathème à leurs chefs, nommément à Théodore, surnommé
Crithin ; un anathème solennel, contre les iconoclastes, contre leur faux
concile et contre leurs chefs, est lu ; le patriarche de Constantinople,
Photios, est excommunié et déposé ; le dernier canon stipule : "Si
quelqu’un brave les dogmes, les ordres, les interdictions, les sanctions ou les
décrets promulgués sainement par le chef du siège apostolique, qu’il s’agisse
de la foi catholique, de la discipline ecclésiastique, de la réprimande des
fidèles, du châtiment des scélérats, des interdictions concernant les maux
imminents ou futurs, qu’il soit anathème" 1. Mi-juin, le concile de
Metz accepte le divorce de Lothaire II ; le pape Nicolas Ier cassera les
décisions prises à Metz dès le début de l'année suivante et excommuniera les
évêques. 3 septembre, la campagne de l'émir de Mélitène jusqu'à Amisos est
arrêtée par la victoire byzantine de Petronas à la bataille de Poson, sur le
fleuve Halys, en Anatolie ; le chef des Pauliciens Karbeas
est tué et remplacé par son neveu et gendre Chrysocheir (main d'or) ; Petronas
remporte une seconde victoire sur l'émir d'Arminiya au col de Haloras (Olor).
En octobre, les Vikings de Maurus, s'installent à l'embouchure de la Charente ;
ils pillent Saintes, Angoulême, Poitiers (décembre), Ligugé et vont peut-être
jusqu'à Limoges et Clermont (864) ; le 4 octobre, dans les environs de Saintes,
Turpion, comte d'Angoulême voyant l'inaction de Landry, comte de Saintonge,
défie le chef normand Maurus ; les deux adversaires se précipitent l'un sur
l'autre avec leurs chevaux et se transpercent mutuellement avec leurs lances ;
les Normands, vainqueurs mais intimidés par la mort de leur chef, regagnent
leurs navires avec leur butin après avoir pillé Saintes.
864. Au début de l'année, baptême de Boris Ier, roi des Bulgares (en 870,
il passera au rite grec). Photios tente de convertir les Russes. En février,
l'empereur Louis II assiège Rome pour obliger Nicolas Ier à reconnaître le
divorce de son frère Lothaire : le pape fuit, mais Louis tombe malade, ce qu'il
prend pour un signe de Dieu, alors il se réconcilie avec le pape. 20 juin,
concile de Pîtres en Normandie auquel souscrit Rotland l'archevêque d'Arles. 25
juin, l'Édit de Pîtres déclare Pépin le Jeune, roi d'Aquitaine, déchu de ses
États et décide une refonte des monnaies et la fortification des ponts contre
les Normands, en particulier le pont de Pîtres ; la diète de Pîtres impose au
roi Salomon de Bretagne le paiement d'un tribut à Charles le Chauve. En août,
entrevue de Tulln (Autriche) entre Louis le Germanique et le tsar bulgare Boris
Ier ; les armées franques interviennent en Grande-Moravie conjointement avec
les Bulgares ; assiégé au château de Devin, le prince Ratislav doit reconnaitre
la suzeraineté franque et contraindre le clergé à renoncer à la liturgie en
langue slave instituée par Cyrille et Méthode ; l'empereur Michel III mène des
opérations navales et terrestres contre les Bulgares et contraint Boris Ier à
se soumettre et à renoncer à son alliance avec Louis II le Germanique. 19
octobre, à Cordoue (Andalousie), Laura ou Laurence, veuve devenue
moniale, est martyrisée avec d’autres chrétiennes qui refusent de se convertir
à l’islam (Martyrologe).
865. 29 septembre, mort de Charles, roi d’Aquitaine, fils de Charles le Chauve.
866. Mort de Lothaire le Boiteux (abbé de Saint-Germain d'Auxerre et fils de
Charles II le Chauve). Robert le Fort, arrière-grand-père d'Hugues Capet, meurt
en combattant les Normands. Le pape interdit la torture. L’archevêque Hincmar
de Reims affirme les droits des églises métropolitaines contre
l’autorité papale. Concile de Soissons auquel souscrit Jean Ier l'évêque de
Cambrai et d’Arras. 29 septembre, un accident de chasse cause la mort de
Charles l'Enfant, fils de Charles le Chauve.
867. Concile de Troyes auquel souscrit Jean (Ier) l'évêque de Cambrai et
d’Arras. Dans son Encyclique aux Patriarches orientaux, le patriarche de
Constantinople, Photios, dénonce l’hérésie latine (le filioque).
En août, un synode, réuni par Photios (déposé par Nicolas en 863), dépose le
pape ; Nicolas meurt le 13 novembre sans rien connaître de cette initiative et
du schisme qui s’ensuit entre les Eglises d’Orient et d’Occident. 24
septembre, l'empereur Michel est assassiné par Basile qui force Photius à la
démission, rappelle Ignace (le 23 novembre) et renoue avec Rome alors sous le
pontificat de Adrien
II (toutefois l’empereur Basile Ier rappellera Photios en 877).
Notes
1 http://missel.free.fr/Sanctoral/11/13.php
2 http://nominis.cef.fr/contenus/saint/93/Saint-Nicolas-Ier-le-Grand.html
Sources
SOURCE : http://compilhistoire.pagesperso-orange.fr/NicolasIer.htm
Cromolitografia
in L. Tripepi, Ritratti e biografie dei romani pontefici: da S. Pietro a Leone
13, Roma, Vaglimigli Davide, 1879. bibliothèque
municipale de Trento
Also
known as
Nicholas the Great
Profile
Son of the Theodore, who
held the title Defensor. An excellent student,
known for his piety and eloquence. Ordained as a sub-deacon by Pope Sergius
II, and then a deacon by Pope Leo IV.
Elected pope after
the disintegration of the empire of Charlemagne when Christianity was
threatened by apathy and indifference, and churchmen were becoming worldly.
Nicholas became a vigorous, politically active pope who
strengthened the Holy See. He arbitrated temporal and religious disputes, often
setting important precedents, such as upholding the right of a bishop to
appeal to Rome against his archbishop.
Worked to prevent the proposed divorce of Lothair of Lotharingia, who wished
to re-marry.
Even when Holy Roman Emperor Louis II occupied Rome,
Nicholas refused to yield, and finally forced Lothair to reinstate his wife.
Challenged the right of Photius to occupy the see of Constantinople,
and tried to get Saint Ignatius
of Constantinople re-instated. Worked with Boris I to introduce Roman
ecclesiastical jurisdiction in Bulgaria,
which had recently been converted by
the Byzantines.
Born
Papal Ascension
elected and enthroned
on 24
April 858
13
November 867 at Rome, Italy of
natural causes
Additional
Information
Book
of Saints, by the Monks of
Ramsgate
Roman
Martyrology, 1914 edition
Saints
of the Day, by Katherine Rabenstein
—
books
Our Sunday Visitor’s Encyclopedia of Saints
other
sites in english
video
sitios
en español
Martirologio Romano, 2001 edición
sites
en français
Abbé
Christian-Philippe Chanut
siti
in italiani
strony
w jezyku polskim
Confernece
of the Polish Episcopate
MLA
Citation
“Pope Saint Nicholas
I“. CatholicSaints.Info. 27 September 2022. Web. 3 February 2025.
<https://catholicsaints.info/pope-saint-nicholas-i/>
SOURCE : https://catholicsaints.info/pope-saint-nicholas-i/
Book of
Saints – Nicholas – 13 November
Article
(Saint) Pope (November
13) (9th
century) One of the most remarkable men of his age. He ably governed
the Church during
nine dark years of the ninth
century. Many of his letters are extant and testify to his learning and
holiness. Missionaries sent
by him effected the conversion of
the Bulgarians.
He died A.D. 867.
MLA
Citation
Monks of Ramsgate.
“Nicholas”. Book of Saints, 1921. CatholicSaints.Info.
25 March 2016. Web. 3 February 2025.
<https://catholicsaints.info/book-of-saints-nicholas-13-november/>
SOURCE : https://catholicsaints.info/book-of-saints-nicholas-13-november/
New
Catholic Dictionary – Pope Saint Nicholas I
Derivation
Greek: victor of the
people
Profile
Reigned from 858 to 867.
Born in 825 in Rome, Italy; died there. Elected after the disintegration of the
empire of Charlemagne,
he found Christianity threatened
by laxity in the observance of moral and civil law. To uphold Divine and Church
law against princes and worldly bishops,
he protected the minor clergy and suffragan bishops against
their exactions. He upheld the right of appealing to Rome, against the
decisions of Archbishop Hincmar
of Rheims; defended the integrity of the marriage bond against Lothair II; and
supported Ignatius, Patriarch of Constantinople against, the intruder,
Photius. Feast,
Roman Calendar, 13
November.
MLA
Citation
“Pope Saint Nicholas
I”. New Catholic Dictionary. CatholicSaints.Info.
12 August 2018. Web. 3 February 2025.
<https://catholicsaints.info/new-catholic-dictionary-pope-saint-nicholas-i/>
SOURCE : https://catholicsaints.info/new-catholic-dictionary-pope-saint-nicholas-i/
Nicholas I, Pope (RM)
Born in Rome between
819-822; died there in 867. Born into a distinguished Roman family, Nicholas
served in the Curia under Pope Sergius II, became a deacon under Pope Leo IV,
and was a trusted adviser to Pope Benedict III. Nicholas was elected bishop of
Rome on April 22, 858, while still a deacon, and occupied the see with
distinguished courage and energy for nine troubled years. Among the matters
with which he had to deal was the long dispute about the patriarchal see of
Constantinople, the turbulence of Archbishop John of Ravenna and the ambition
of Hincmar of Rheims, in addition to the matrimonial troubles of several
important persons. He insisted on the sanctity and indissolubility of marriage,
despite the threat of the invasion of Rome, when he denounced the bigamous
marriage of the emperor's nephew, King Lothair II of Lorraine. This
precipitated a struggle during which Nicholas deposed two German archbishops
and Lothair's army threatened Rome.
He also insisted on the
freedom to marry when he forced King Charles the Bald of Burgundy to accept the
marriage of his daughter Judith to Baldwin of Flanders without the king's
consent and compelled the Frankish bishops to withdraw the excommunication they
had imposed on her for marrying without her father's consent.
In 861 Nicholas compelled
Archbishop Hincmar of Rheims to accept papal appellate jurisdiction in
important cases when he obliged Hincmar to restore Bishop Rothad of Soissons,
whom he had deposed.
Twice he excommunicated
recalcitrant and powerful Archbishop John of Ravenna, who counted on imperial
support, for infringing on the rights of the Holy See and for abuses of his
office, and made him submit to papal authority.
Nicholas was also
involved in controversy with Constantinople throughout his pontificate over the
illegal deposition of Ignatius and the appointment of Photius as patriarch of
Constantinople by Emperor Michael III. Nicholas excommunicated Michael in 863;
the matter was not finally resolved until newly crowned Emperor Basil I
expelled Photius, who had declared the pope deposed, on the day Nicholas died.
Faced by disorder or
scandal, Nicholas could not rest until he had dealt with it; but he sometimes
invoked the aid of persons considerably less moderate and reasonable than
himself.
He encouraged missionary
activities, sending Saint Anskar as papal missionary to Scandinavia and
bringing about the conversion of Bulgaria with missionaries he sent there. A letter
(Responsa Nicolai ad consulta Bulgarum) he sent to the newly baptized Khan
Boris of the Bulgars has been characterized as 'a masterpiece of pastoral
wisdom and one of the finest documents of the history of the papacy.' The
letter summarizes Christian faith and discipline.
A champion of papal
primacy and the ascendancy of the Church over emperors, kings, and other
secular authorities in matters concerning the Church, he was responsible for
restoring the papacy to the highest prestige.
Nicholas's generosity
made him beloved by the people and his defense of justice and virtue earned the
respect of his contemporaries generally. He was famous for the reforms he
instituted among the clergy and laity, was a patron of the arts and learning,
and was a man of the highest personal integrity. Saint Nicholas is one of the
three popes to whom the epithet 'the Great' is given (Saint Leo I and Saint
Gregory I being the other two) (Attwater, Benedictines, Delaney).
SOURCE : http://www.saintpatrickdc.org/ss/1113.shtml
Pope St. Nicholas I
Born at Rome, date unknown;
died 13 November, 867.
One of the great popes of
the Middle
Ages, who exerted decisive influence upon the historical development of
the papacy and
its position among the Christian nations of Western Europe.
He was of a
distinguished family,
being the son of the Defensor Theodore, and received an excellent
training. Already distinguished for his piety,
benevolence, ability, knowledge,
and eloquence, he entered, at an early age, the service of the Church,
was made subdeacon by Pope
Sergius II (844-47), and deacon by Leo
IV (847-55). After Benedict's death
(7 April, 858) the Emperor Louis II, who was in the
neighbourhood of Rome,
came into the city to exert his influence upon the election.
On 24 April Nicholas was elected
pope, and on the same day was consecrated and enthroned in St.
Peter's in the presence of the emperor. Three days after, he gave a
farewell banquet to the emperor, and afterward, accompanied by the Roman nobility,
visited him in his camp before the city, on which occasion the emperor came to
meet the pope and
led his horse for some distance.
Christianity in Western Europe was
then in a most melancholy condition. The empire of Charlemagne had
fallen to pieces, Christian territory
was threatened both from the north and the east, and Christendom seemed
on the brink of anarchy. Christian morality was despised;
many bishops were
worldly and unworthy of their office. There was danger of
a universal decline of the higher civilization. Pope
Nicholas appeared as a conscientious representative of the Roman Primacy in
the Church.
He was filled with a high conception of his mission for the vindication
of Christian morality,
the defence of God's
law against powerful bishops.
Archbishop John of Ravenna oppressed
the inhabitants of the papal
territory, treated his suffragan bishops with violence,
made unjust demands
upon them for money, and illegally imprisoned priests.
He also forged documents
to support his claims against the Roman
See and maltreated the papal
legates. As the warnings of the pope were
without result, and the archbishop ignored
a thrice-repeated summons to appear before the papal
tribunal, he was excommunicated.
Having first visited the Emperor Louis at Pavia,
the archbishop repaired,
with two imperial delegates, to Rome,
where Nicholas cited him before the Roman synod assembled
in the autumn of 860. Upon this John fled from Rome.
Going in person to Ravenna,
the pope then
investigated and equitably regulated everything. Again appealing to
the emperor, the archbishop was
recommended by him to submit to the pope,
which he did at the Roman Synod of
November, 861. Later on, however, he entered into a pact with the excommunicated Archbishops of Trier and Cologne,
was himself again excommunicated,
and once more forced to make his submission to the pope.
Another conflict arose
between Nicholas and Archbishop
Hincmar of Reims: this concerned the prerogatives of the papacy.
Bishop Rothad of Soissons had appealed to
the pope against
the decision of the Synod of Soissons,
of 861, which had deposed him; Hincmar opposed
the appeal to
the pope,
but eventually had to acknowledge the right of
the papacy to
take cognizance of important legal causes (causæ
majores) and pass independent judgment upon them. A further dispute
broke out between Hincmar and
the pope as
to the elevation of the cleric Wulfad to
the archiepiscopal
See of Bourges, but here, again, Hincmar finally
submitted to the decrees of
the Apostolic
See, and the Frankish synods passed
corresponding ordinances.
Nicholas showed the
same zeal in
other efforts to maintain ecclesiastical
discipline, especially as to the marriage laws.
Ingiltrud, wife of Count Boso, had left her husband for a
paramour; Nicholas commanded the bishops in
the dominions of Charles the Bold to excommunicate her
unless she returned to her husband. As she paid no attention to the summons to
appear before the Synod of Milan in
860, she was put under the ban. The pope was
also involved in a desperate struggle with Lothair II of Lorraine over
the inviolability of marriage. Lothair
had abandoned his lawful wife Theutberga to marry Waldrada.
At the Synod of Aachen,
28 April, 862, the bishops of Lorraine,
unmindful of their duty,
approved of this illicit union. At the Synod of Metz,
June, 863, the papal
legates, bribed by the king, assented to the Aachen decision,
and condemned the absent Theutberga. Upon this the pope brought
the matter before his own tribunal.
The two archbishops, Günther
of Cologne and Thietgaud of Trier,
who had come to Rome as
delegates, were summoned before the Lateran Synod of
October, 863, when the pope condemned
and deposed them
as well as John of Ravenna and Hagano
of Bergamo.
The Emperor Louis II took up the cause of the deposed bishops,
while King Lothair advanced upon Rome with
an army and laid siege to the city, so that the pope was
confined for two days in St.
Peter's without food. Yet Nicholas did not waver in his
determination; the emperor, after being reconciled with the pope,
withdrew from Rome and
commanded the Archbishops of Trier and Cologne to
return to their homes. Nicholas never ceased from his efforts to
bring about a reconciliation between Lothair and his lawful wife, but
without effect. Another matrimonial case in
which Nicholas interposed was that of Judith, daughter
of Charles the Bold, who had married Baldwin, Count
of Flanders,
without her father's consent. Frankish bishops had excommunicated Judith,
and Hincmar
of Reims had taken sides against her, but Nicholas urged
leniency, in order to protect freedom of marriage. In many other ecclesiastical matters,
also, he issued letters and decisions, and he took active measures
against bishops who
were neglectful of their duties.
In
the matter of the emperor and the patriarchs of Constantinople Nicholas showed
himself the Divinely appointed ruler of the Church.
In violation of ecclesiastical law,
the Patriarch Ignatius was deposed in
857 and Photius illegally
raised to the patriarchal see. In a letter addressed (8 May, 862) to
the patriarchs of
the East, Nicholas called upon them and all their bishops to
refuse recognition to Photius,
and at a Roman synod held
in April, 863, he excommunicated Photius.
He also encouraged the missionary activity of the Church.
He sanctioned the union of the Sees of Bremen and Hamburg,
and confirmed to St.
Anschar, Archbishop of Bremen,
and his successors the office of papal
legate to the Danes, Swedes,
and Slavs. Bulgaria having
been converted by Greek missionaries, its
ruler, Prince Boris, in August, 863, sent an embassy to the pope with
one hundred and six questions on the teaching and discipline
of the Church. Nicholas answered these inquiries exhaustively in
the celebrated "Responsa Nicolai ad consulta Bulgarorum" (Mansi,
"Coll. Conc.", XV, 401 sqq.). The letter shows how keen was his
desire to foster the principles of an earnest Christian life in
this newly-converted people. At the same time he sent an embassy
to Prince Boris, charged to use their personal efforts to attain
the pope's object. Nevertheless,
Boris finally joined the Eastern
Church.
At Rome, Nicholas rebuilt
and endowed several churches, and constantly sought to
encourage religious
life. His own personal life was guided by a spirit of
earnest Christian asceticism and
profound piety.
He was very highly esteemed by the citizens of Rome,
as he was by his contemporaries generally (cf. Regino,
"Chronicon", ad an. 868, in "Mon. Germ. Hist."
Script.", I, 579), and after death was regarded as a saint. A much
discussed question and one that is important in judging the position
taken by this pope is,
whether he made use of the forged pseudo-Isidorian
papal decretals. After exhaustive investigation, Schrörs has
decided that the pope was
neither acquainted with the pseudo-Isidorian
collection in its entire extent, nor did he make use of
its individual parts; that he had perhaps a general knowledge of
the false
decretals, but did not base his view of the law upon
them, and that he owed his knowledge of
them solely to documents which came to him from the Frankish Empire [Schrörs,
"Papst Nikolaus I. und Pseudo-Isidor" in "Historisches
Jahrbuch", XXV (1904), 1 sqq.; Idem, "Die pseudoisidorische 'Exceptio
spolii' bei Papst Nikolaus I" in "Historisches Jahrbuch", XXVI
(1905), 275 sqq.].
Kirsch, Johann
Peter. "Pope St. Nicholas I." The Catholic
Encyclopedia. Vol. 11. New York: Robert Appleton
Company, 1911. 13 Nov.
2016 <http://www.newadvent.org/cathen/11054a.htm>.
Transcription. This
article was transcribed for New Advent by Chris Hidley.
Ecclesiastical approbation. Nihil
Obstat. February 1, 1911. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John
Cardinal Farley, Archbishop of New York.
Copyright © 2023 by Kevin Knight.
Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.
SOURCE : http://www.newadvent.org/cathen/11054a.htm
Nicholas I
858-867
Saint Nicholas I,
surnamed the Great, deserved the title by his virtues, comparable to those of
Saint Gregory and Saint Leo. He was a Roman, and son of Theodore of the Conti
family. He was made cardinal-deacon by Leo
IV. Notwithstanding the resistance which he manifested, he was elected and
consecrated pope on the 24th of April, 858, in presence of Louis II, who held
the new pope's stirrup as he mounted his horse to go to take the possession. He
was the first pope crowned with the papal tiara. The coronation took place at
Saint John Lateran, but the custom had prevailed that the pope should be
crowned at Saint Peter's, and that he should go to Saint John Lateran to take
possession. A few days after those ceremonies, Louis II left Rome for a
neighboring place called Tor di Quinto. The pope, accompanied by all the Roman
nobles, paid a visit to the prince at that place. On the arrival of the
pontiff, Louis dismounted from his own horse, took the pope's bridle, and
conducted His Holiness to Tor di Quinto, where a magnificent banquet was
prepared. The same honors were paid by Louis II to Nicholas when he returned to
Rome.
The pope at this time commenced that series of great achievements by which his
name and pontificate were made illustrious.
With admirable constancy he defended Ignatius, Patriarch of Constantinople,
whom Bardanes, uncle of the Emperor Michael, and governing in his name, had
deposed on a charge of high treason. Bardanes had named, in place of the
deposed Ignatius, the eunuch Photius, a man of corrupt morals, whom Nicholas
deemed it his duty to excommunicate in a council in the year 863.
In 866 Nicholas required of Lothaire that he should take back his wife, Queen
Tielberge, and dismiss his concubine Waldrade. But subsequently Lothaire took
back the concubine, abandoning and ill-treating his lawful wife. In one of the
seven councils which he celebrated at Rome, Nicholas extinguished the reviving
sect of the Theopaschites. He says himself in the seventh of his letters,
published by Labbe, that they maintained that Jesus Christ, on the cross,
suffered in his divinity.
The Bulgarians were converted in 861. Nicholas sent to them, in 866, his
legates, among whom was distinguished Formosus, Bishop of Porto, who became
pope in 891. For their instruction he gave them one hundred and six replies to
as many questions asked by Michael, king of the Bulgarians.
On the subject of the divorce of Lothaire, Fleury notices a letter which
Nicholas wrote to Adventius, Bishop of Mainz, in which the pope seems to
authorize bishops to disobey princes whom they do not consider legitimate.
"You say that you are subject to the prince because the apostle says:
'Obey the king, as being set over you.' You are right; but be sure that these
kings and princes are genuine. See whether they act uprightly, govern their
subjects well, for what is he good for who is bad in himself? See whether they
are princes justly; otherwise we must rather hold them as tyrants than kings,
and resist, rather than by obeying them place ourselves under the necessity of
favoring their vices. Be subject to the king as being above all by his virtues,
not by his vices, and obey him for God's sake, as the apostle says, and not
against God."
Fleury adds: "Pope Nicholas forgot that the king, or rather emperor, whom
Saint Peter ordered Christians to obey, was Nero; and that he says immediately
after, 'Slaves, obey your masters, not only those who are good, but the froward
also.' Moreover, the pope makes bishops judges whether princes are legitimate
or tyrants; and not only bishops but all their subjects, for the reason he
cites in general." Fleury frequently censures Nicholas.
Nicholas governed the Church nine years, six months, and twenty days.
In various ordinations he created sixty-five bishops, seven priests, and four
deacons. The eighth general council, assembled in Constantinople in 870, calls
Nicholas the new Elias, the new Phineas (Phineas, son of Eleazar and grandson
of Aaron, was the third high priest of the Jews), new Daniel, and new Martin.
Anastasius, in the preface to that same council, calls Nicholas a
"heavenly man" and an "earthly angel." He showed great munificence
in the restoration of the churches of Rome. All authors agree that he was
enthusiastically beloved by the poor, because he had said that there should not
be one of them in Rome that had not shared in his bounty. Nicholas was also
respected on account of the just severity with which he enforced ecclesiastical
discipline. He died on the 13th of November, 867, and was interred before the
doors of Saint Peter.
This biographical data is from "The Lives and Times of the Popes" by
The Chevalier Artaud De Montor. Published by The Catholic Publication Society
of New York in ten volumes in 1911. The pictures, included in the volumes, were
reproduced from " Effigies Pontificum Romanorum Dominici Basae."
SOURCE : https://www.saint-mike.org/library/papal_library/nicholasi/biography.html
The Legacy of Pope St.
Nicholas the Great
The titanic papacy of
Pope St. John Paul II saw a renewed discussion of the few “Great” popes in
history. With the addition of the Polish pontiff to the list, many
historians now number three “Great” popes. They have forgotten a pope so
grand, so profound, that in his lifetime he dealt with direct challenges to his
papal authority, meeting each with mettle rivalling most of his papal peers.
He was Pope St. Nicholas the Great, a pope who in both thought and deed
transformed the papacy of his day and the Church as a whole.
Pope St. Nicholas lived
in the mid-800s, a time of great upheaval in the Church. In the centuries
between the death of the last “Great” pope, Pope St. Gregory I (d. 604),
Christendom faced an onslaught at the hands of militant Muslims and faced the
rising tide of Viking invaders. In Constantinople, political intrigue
shifted the Byzantine Empire’s throne between families. In Europe,
barbarian tribes accepted the Faith, though more often than not with
problematic pagan practices intermixed. In a word, it was a time of
discord. Times of discord are perfect stages for great men; it was the
perfect time for a man like Pope Nicholas I.
A Pastoral Pope
In Nicholas we see a pope
with a strong papalogy, or theology of the papacy. His papalogy sounds
typical today, but in Nicholas’s day, his view of the papacy stood out among
the popes: all doctrinal questions or issues should be brought to the Holy See
for clarification; all secular leaders should see in the pope their judge and
guide; all bishops must be approved by the pope, for he is the prince of the
Apostles. As Nicholas himself said, “The Pope shall judge everyone and be
judged by none.” Such a strong view of the papacy manifested itself
throughout Nicholas’ reign, leading to some of the most dramatic moments in
Church History.
There was the intriguing
incident with the Bulgarians, who had converted in large numbers but still
needed strong catechesis. Unsure of how to live as Christians (the
Bulgarians were stuck in the middle of a dispute over whether they were Latin
or Byzantine Christians), the Bulgarian king Boris wrote to Pope Nicholas with
115 questions, many of which come across as strange today (the Bulgarians, for
example, wanted to know if men or women should wear pants, a question which
Nicholas wasn’t sure how to answer). Other popes in the Church’s history
might address the major questions, or have one of their bishops answer them;
Pope Nicholas took the time to answer every single question, even the most
bizarre ones. By addressing these questions, Nicholas not only brought
the Bulgarians closer to Christ, but he also exemplified how a teacher of the
Faith must educate and inspire, even in strange circumstances.
Defender of Marriage
Another dramatic moment
was when Pope Nicholas defended the marriage of Lothair II (brother of Holy
Roman Emperor Louis II) and Theutberga. The marriage had been an arranged
one, and the displeased Lothair rejected his young wife for his mistress
Waldrada. Seeking to divorce his queen, Lothair turned to the bishops in
the Holy Roman Empire, and after a trial where Theutberga was forced to say she
had incestuous relations prior to marriage, the bishops voted in favor of
Lothair’s proposal. He sent away his wife and wed his mistress.
Theutberga appealed to Nicholas, who sent legates to a synod in Metz in 863
(the year after Lothair’s second marriage). The legates were bribed into
accepting Lothair’s position, infuriating Nicholas.
The pope called the
archbishops who had run the synod to Rome; there he deposed them and suspended
their faculties as priests. The archbishops returned home furious (they
would later refer to Nicholas as “the lord Nicholas who is called pope, who
pretends to be an apostle among the apostles and who poses as emperor of the
world”) and Holy Roman Emperor Louis II sent an invading force to Rome to put
the pope in his place. Pilgrims and processions fled as the Frankish army
tore through the city, vandalizing in the ensuing chaos. Yet despite this
threat on his life, Nicholas refused to recant his position and give in to the
demands of Louis and Lothair. “The Holy See does not change its mind,”
Nicholas said; “Let these men carry their shame.” His tenacity worked;
Lothair took Theutberga back as his wife (though the whole affair repeated
itself a few years later under the reign of Pope Hadrian II) and the invaders
returned home. In a time where clerics again debate the Church’s teaching
on marriage, it is wise to reflect on what men like Nicholas did to defend the
sanctity of marriage, even risking their very lives.
Firmness in Politics
The last moment we’ll
examine is Nicholas’s struggle with Patriarch Photius of Constantinople.
Photius was one of the most well educated men of his age. He seemed the
perfect choice to become Patriarch of Constantinople. Unfortunately,
Photius was not yet a cleric when this idea came into the head of the Byzantine
Emperor Michael “the Drunkard” (side note: we should really bring back “the”
based nicknames). Also, perhaps even more unfortunately, the see of
Constantinople was already occupied by one Ignatius, who had been on Michael’s
bad side ever since Ignatius reprimanded Michael’s uncle Bardas for his illicit
relations with his daughter-in-law. Michael exiled Ignatius and had
Photius elevated in his place. Ignatius wrote to Pope Nicholas, and Pope
Nicholas sided with Ignatius (not surprising). Despite behind-the-scenes
intrigues in Constantinople (which included, among other things, bribing the
papal legates sent to investigate the situation), Nicholas remained firm.
In 863, Nicholas held a synod in Rome which discussed the situation; from this
synod’s discussion, Nicholas decided to depose Photius, excommunicate him,
reinstate Ignatius, and depose the legates who had been bribed in
Constantinople.
He sent letters informing
Photius and Emperor Michael of his decision. Emperor Michael threatened
to invade Rome; Nicholas responded by writing a lengthy letter summarizing the
authority the pope had in these affairs. Photius responded in 867 by
“excommunicating” Nicholas and all who supported him (since bishops can only
excommunicate while in union with the Holy See, a bishop can’t really
excommunicate the pope). Despite all of this, Nicholas remained firm.
The sort of political
intrigue that caused the schism led to its resolution. Basil the
Macedonian, Emperor Michael’s second-in-command, and murdered Michael in his
sleep on September 24, 867. Basil then became emperor, exiled Photius,
and re-installed Ignatius as patriarch. We don’t know if Nicholas heard
of the exploits of Basil and the sudden, bloody resolution to the schism; he
died on November 13. Doubtless he wouldn’t have approved of the methods
to resolve the schism, but he may have been pleased that the Church was once
again united.
There are many other stories
from Pope St. Nicholas I’s reign, and each of the above stories could be
expanded into their own reflections. Yet we see in these three stories
the key aspects of a pope’s mission. We see in the story of the
Bulgarians Nicholas’s zeal for teaching the truths of the Faith. We see
in the stand-off with Lothair Nicholas’s strengths against the corruption of
secular leaders. We see in the Photian Schism Nicholas’s strengths as the
Church’s shepherd. Catholics throughout the world should learn more about
this great hero of the Faith, this great pope. He may be frequently
forgotten, but his Greatness cannot be denied. He deserves to be listed
with his great saintly papal companions: Leo, Gregory, and John Paul II.
Matthew B. Rose received
his BA (History and English) and MA (Systematic Theology) from Christendom
College. He teaches Theology and History at Bishop Denis J. O'Connell High
School in Arlington, VA. Matthew also runs Quidquid Est, Est!, a Catholic Q
& A blog, and has contributed to various online publications. He lives with
his wife and two sons in Falls Church, VA.
SOURCE : http://catholicexchange.com/the-legacy-of-pope-st-nicholas-the-great
(27) 25. NICCOLÒ (ca. 800/827-867)
Birth.
Ca. 800/827, Rome. He did not belong to the aristocracy, like his two immediate
predecessors, but was not of modest origin. Son of Teodoro, regionario, a
notary or one of the defensores, who administered the assets of one of the
seven regions of the Church in the city. He is also listed as Nicola.
Education.
He received a traditional education in literature and sacred matters, similar
to that given to his predecessor Adrian I, Leo III and Sergius II, at home or
at the Lateran palace.
Early
life. He entered the clergy under Pope Sergius II and was assigned to the
offices of the Lateran palace, where he was made subdeacon by that pope; and
then deacon by Pope Leo IV.
Cardinalate.
First documented as deacon cardinalis of the Holy Roman Church in
the Roman Council of
853, which ended with the deposition and excommunication of Anastasio,
cardinal priest of S. Marcello (who a little later became Antipope Anastasius
III, and was later librarian of the Holy Roman Church). He had the distinction
of reading the first ammonitio of the pope in that council. He became
Pope Benedict III's principal adviser and had an executive role; the pope, to
have him at his side, moved away from the habit of giving precedence to the
pope's own kin; Cardinal Niccolò, with other deacons, was among those at the
burial of Pope Benedict in St. Peter's on April 7, 858, as the application of a
rule established by the pope himself, who had directed that each member of the
Roman clergy should be accompanied by the burial group of his "colleagues",
which together would recommend to God the soul of the deceased.
Papacy. Elected pope by
the unanimous decision of the Roman clergy, the nobles (the Senate), and the
people, in the presence of Emperor Louis II, thus complying with what the Constitutio
Romana of 824 had stipulated. Consecrated pope on Sunday April 24, 858.
Took the name Nicholas I. On April 26, the new pope received the emperor, had
dinner with him and admitted him to his spiritual paternity; then Emperor Louis
II left the city to go to Tor di Quinto (S. Leucius, at the fifth mile of the
Via Flaminia), where the pope joined him. Twice, when he received him and when
he left, the emperor subdued himself to the officium stratoris, leading
the horse of the pope by the reins, thus renewing the act of Pepin to Pope
Stephen II in Ponthion on January 6, 754, a practice, also provided for in
the Constitutum Constantini (§ 16), which was seen as a rite of
acceptance of vassalage. In the two floods of the Tiber river in October and
December 860, the pope assisted the citizens of Rome affected by the disasters.
In his first Roman synod in February 861, Pope Nicholas I, reaffirmed the
timeliness of the Lateran Synod's
decree of 769, which reserved the election of a pontiff to the clergy and
the eligibility for the office to only the members of the clergy of Rome; thus,
the pope offered his successors a weapon of defense against the
"secular" interference in general and especially against interpreting
the Constitutio Romana too rigidly. Starting during the Roman synod
of autumn 863, Pope Nicholas took at his service Anastasio, particularly but
not exclusively for the conduct of relations with the East, which requires
knowledge of greek; Anastasio did not simply dictated the correspondence, but
also gave voice to the ideas of the pope with his translations of hagiographic
texts (like that of the life of St. John the Almoner and also the dedication of
the translation of the life of St. Basil the subdeacon Urso, physician of
Nicholas); the pair formed by the pope and his secretary was cemented so
quickly that sometimes the biographers of Anastasio saw in him the key man of
his pontificate: the inspiration of political ideas and ecclesiological essential;
it can certainly be attributed to Anastasio the strength and clarity of
expression that characterized all the letters of the pope. Pope Nicholas I
vigorously asserted the supremacy of the Holy See in the East. He revived the
papal jurisdiction over IIlyricum, Byzantine southern Italy and Sicily (which
in 732-733 had been transferred by Pope Leo III to the jurisdiction of the
patriarch of Constantinople), and when Patriarch Ignatius of Constantinople was
forced to abdicate in late 858, and was replaced by the Photius, a layman, the
pontiff protested to Emperor Michael III and sent Bishops Radoaldo of Porto and
Zaccaria of Anagni as legates Constantinople, asking them to explore the
respective legitimacy of Ignatius and Photius, refusing in the meantime to recognize
either one as patriarch. When the legates sent a report that favored Patriarch
Photius, the pope disavowed them, and after being informed by the followers of
Patriarch Ignatius, Pope Nicholas deposed and excommunicated Photius at a synod
held in the Lateran palace in August 863. When Emperor Michael III strongly
protested, the pope sent him, on September 28, 865, a stinging rebuke,
defending his own actions and expounding at length the inalienable rights of
the Holy See. Meanwhile, the relations between the Western and the Eastern
Churches were even more tested when Pope Nicholas I responded to a request from
King Boris I of Bulgaria and sent missionary bishops (among them Bishop Formoso
of Porto, future pope) to that kingdom and gave detailed advice to the monarch,
often in anti-Byzantine tone, on moral and canonical issues, in Responsiones
ad consulta Bulgarorum. To the request from the king to name Formoso archbishop
of Bulgaria, the pope responded negatively because Formoso was already bishop
of Porto and, according to the canons then in force, it was prohibited for a
bishop to move from one see to another. Since Bulgaria was mostly under the
spiritual jurisdiction of Constantinople and had recently been evangelized by
Byzantine missionaries, Patriarch Photius was angry at the pope's actions.
After denouncing the Latin intervention to the patriarchs of the east,
Patriarch Photius celebrated a synod in Constantinople in August-September 867,
which excommunicated and deposed Pope Nicholas I. By the time the news arrived
in Rome, the pope had already died but the sentence he had pronounced on the
patriarch and the one that the patriarch had pronounced on him fatefully
contributed to the final separation of East and West. When Archbishop Giovanni
VIII of Ravenna sought to become independent from Rome and exercised excessive
power in his diocese, he was vigorously quelled by the firmness of Pope
Nicholas I. After having in vain asked the archbishop several times to appear
before a Roman synod to respond primarily for the despotic rule exerted on the
populations of the Exarchate and Pentapolis, oppressed by unjust and burdensome
taxes, and for the despotic treatment to which he submitted his suffragans,
preventing them from communicating directly with Rome, and finally for
usurpation of property of the Apostolic See, the pope not only excommunicated
him on February 24, 861, but also went to Ravenna in the following summer, to
personally organize things, to reorder the administration of the diocese and to
do justice, thus forcing the submission of the archbishop on November 18, who
was left with nothing but to accept all the conditions imposed by the pope.
Pope Nicholas I acted similarly concerning Archbishop Hincmar of Reims; in 864
the pope required him to return to his see the suffragan bishop of Soissons,
Rotado, who the archbishop, in an act of sheer arrogance, had deposed and
replaced; the pontiff also reminded the archbishop that such a measure could
not be taken without the consent of the pope. Another serious question that the
pope had to face, solving it positively in favor of the sanctity of marriage,
was for the King Lothair II of Lorraine to return to his lawful wife Teutberga,
whom he had repudiated under false accusations, annulling the marriage to wed
his concubine Valdrada. Pope Nicholas I worked actively in favor of her native
city carrying out various public works, such as the reactivation of two
aqueducts, the construction of several church buildings, the embellishment of
various churches, including S. Maria in Cosmedin and S. Maria Nova (now S.
Francesca Romana). He created nine cardinals in three promotions.
His pontificate saw the rise of the papal theocracy, based on the principle of
dependence on the Church of Rome and its supreme leader, the Supreme Pontiff,
of all other Churches and of all other ecclesiastical hierarchs. A man of
strong personality, Pope Nicholas I distinguished himself by the breadth of his
culture, his indomitable energy, the austerity of life and his pastoral care
and also, for his zeal for the good of the Church and of his subjects, so much
so, that posterity rightly calls him the Great (1).
Death. November 13, 867,
from a stress-induced illness, Rome. Buried in an elegant (eximium) marble
mausoleum in the atrium of the Vatican basilica(ante fores basilicæ beati Petri),
near the tomb of his predecessor Pope Benedict III. Fragments of his epitaph
are preserved in the Vatican grottos (2).
Sainthood. Shortly after
his death, his successor Pope Adrian II recommended the participants of the
Synod of Troyes, celebrated on May 8, 868, to include the name Pope Nicholas I
in the prayers at Mass, but, surprisingly, it was not formally inserted in the Roman
Martyrology until 1630 by Pope Urban VIII. His feast is on November 13.
The Martyrology says about him: Romæ Nicolai papæ vigore
apostolico præstantis.
Bibliography. Bougard,
François. "Niccolò I, santo." Enciclopedia dei papi. 3 vols.
Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, 2000, II, 1-22; Cardella,
Lorenzo. Memorie storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa. Rome :
Stamperia Pagliarini, 1792, I, pt. 1, 53-54; Chacón, Alfonso. Vitæ, et res
gestæ Pontificum Romanorum : et S.R.E. Cardinalium ab initio nascentis
Ecclesiae usque ad Clementem IX P. O. M. Alphonsi Ciaconii Ord. Praed.
& aliorum opera descriptæ : cum uberrimis notis. Ab Augustino Oldoino, Soc.
Jesu recognitae, et ad quatuor tomos ingenti ubique rerum accessione productae.
Additis Pontificum recentiorum imaginibus, & Cardinalium insignibus,
plurimisque aeneis figuris, cum indicibus locupletissimis. Romæ : P. et A. De
Rubeis, 1677, I, col. 626, no. 25; Del Re, Niccolò. "Niccolò I, il Grande,
papa, santo." Mondo vaticano. Passato e presente. Città del Vaticano
: Libreria Editrice Vaticana, 1995, p. 727-728; "Essai de liste générale
des cardinaux. Les cardinaux des 10 premiers siècles". Annuaire
Pontifical Catholique 1926. Paris : Maison de la Bonne Presse, 1927, p. 152,
no. 29; Gregorovius, Ferdinando. Le tombe dei papi.. Roma : Edizioni del
Centauro, 1931. Seconda edizione italiana riveduta e ampliata da C. Huelsen, p.
30, no. 32; Kelly, John Norman Davidson. The Oxford Dictionary of Popes.
Oxford ; New York : Oxford University Press, 1986, p. 107-109; Le Liber
pontificalis. Paris : E. de Boccard, 1981, 1955. 3 v. : facsims. (Bibliothèque
des Écoles françaises d'Athènes et de Rome). Notes: Reprint of the 1955
edition./ Includes indexes./ Vol. 3: "Additions et corrections de L.
Duchesne publiées par Cyrille Vogel ... avec L'Histoire du Liber pontificalis
dupuis l'édition de L. Duchesne une bibliographie et des tables générales, II,
LXVI-LVII, LXXV, 151-172; Montini, Renzo Uberto. Le tombe dei papi. Roma :
Angelo Belardetti, 1957. Note: At head of title: Instituto di studi romani, p.
139-140, no. 106; Reardon, Wendy J. The deaths of the popes :
comprehensive accounts, including funerals, burial places and epitaphs.
Jefferson, N.C. : McFarland & Co., Publishers, 2004, p. 64; Regesta
pontificum Romanorum ab conditio Ecclesia. Ad annum post Christum natum
MCXCVIII. Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1956. 2 v. Reprint.
Originally published : Lipsiae : Veit et comp., 1885-1888. Original t.p.
included : Regesta pontificum Romanorum ab condita ecclesia : ad annum
post Christum natum MCXCVIII. Editionem secundam correctam et auctam edidit
Philippus Jaffè ; auspiciis Gulielmi Wattenbach; curaverunt S. Loewenfeld, F.
Kaltenbrunner, P. Ewald, I, 341-368.
Webgraphy. Biography by
Francois Bougard, in Italian, Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 78
(2013), Treccani; biography by
Johann Peter Kirsch, The Catolic Encyclopedia; biography,
in English, Encyclopaedia Britannica; his image and biography,
in English, Wikipedia; biography,
in English, Papal Library, Saint Mike; images and biography, in
Italian, Santi e Beati; biography, in Norwegian,
Den katolske kirke; painting by
Raffaele Sanzio, Getty Images, National Gallery, London (it erroneously
indicates that the date of the work is circa 860 the painting is a fragment of
Raffaele's work "Madonna Ansidei", painted in 1505, which represents
St. Nicholas I (or perhaps St. Nicholas of Bari because his vestments are those
of a bishop not of a pope) next to the Blessed Virgin); The
Ansidei Madonna, Raffaele, 1505, The National Gallery, London; his
engraving, Bildarchiv Austria. Die Bildplattform der Österreichischen
Nationalbibliothek; his
engraving, Bildarchiv Austria. Die Bildplattform der Österreichischen
Nationalbibliothek; his
engraving, from the same source; Saint
Nicolas Ier by Jules Roy, Paris : V. Lecoffre, 1899.
(1) Del Re, "Niccolò
I, il Grande, papa, santo." Mondo vaticano. Passato e presente, p.
728, who adds that no better tribute could be made of him than the one written
by German chronicler and canonist Abbot Reginon von Prüm (ca. 842-915), who
said in his Chronicon: "regibus et tyrannis imperavit, eisque ac si
dominus orbis terrarum, auctoritate praefuit; episcopis et sacerdotibus,
religiosis ac Domini mandata servantibus humilis, blandus, plus, mansuetus
apparuit; irreligiosis ac a recta tramite exorbitantibus terribilis atque
austeritate plenus exstitit, ut merito credatur alter Elias Deo suscitante
nostris in temporibus exsurrexisse, et si non corpore, tamen spiritu et
virtute".
(2) This is the text of his epitaphy, taken from, Montini, Le tombe dei
papi, p. 139-140, no. 6:
(Scire volens cur tr)ISTE
GENVS MORTALE REPENTE
(quisquis adhuc prop)ERAS EOIS PARTIBVS AVLAE
(templa vel occidu)IS POLLENS AVSTROQVE BEATAE
(axe vela gelido) CARMEN SCRVTARE MEMENTO
conditur hoc aNTRO SACRI SVBSTANTIA CARNIS
praesulis egregii NICOLAI DOGMATE SANCTO
qui fulsit cuncTIS MVNDVM REPLEVIT ET ORBEM
intactis nituit mEMBRIS CASTOQVE PVDORE
quae docuit veRBIS ACTVQVE PEREGIT OPIMO
siderea plenuS MANSIT DOCTVSQVE SOPHIAe
caelorum claRIS QVEM SERVANT REGNA TRIVMPHis
ut vernet sollS PRocerulM PER SAECVLA VATVm
Montini adds that the the right part of that
epitaph is preserved in the Vatican grottos and that the fragment was found in
the old sacristy of St. Peter's basilica.
SOURCE : https://cardinals.fiu.edu/bios853.htm#Niccolo
Ritratto
di it:Papa Niccolò I nella it:Basilica di San Paolo fuori
la Mura, Roma
Portait
of en:Pope Nicholas I in the en:Basilica of Saint Paul
Outside the Walls, Rome
San Niccolò I Papa
Festa: 13 novembre
Roma, 819/822 - Roma, 13
novembre 867
(Papa dal 24/04/858 al 13/11/867)
Romano, riaffermò con decisione la sua autorità davanti alle rivendicazioni
autonomiste di diverse Chiese nazionali e provinciali, così come davanti
all'Imperatore e alla Chiesa greca.
Martirologio
Romano: A Roma presso san Pietro, san Nicola I, papa, che si impegnò con
vigore apostolico a rafforzare l’autorità del Romano Pontefice in tutta la
Chiesa di Dio.
Niccolò nacque a Roma probabilmente nei primi venti anni del sec. IX, lo si può dedurre dalla notizia certa che fu ordinato suddiacono da papa Sergio II che pontificò dall’844 all’847.
Suo padre Teodoro volle per lui un’educazione colta con predilezione per le lettere, questo fece sì che il giovane Niccolò fu presto introdotto alla corte pontificia. Ebbe la stima dei papi Sergio II, Leone IV e Benedetto III che lo considerò più di un parente, consultandolo in ogni importante questione. Cosìcché fu quasi logico che alla morte di papa Benedetto III avvenuta il 7 aprile 858, Niccolò venisse eletto a succedergli col favore di tutti e consacrato papa il 24 dello stesso mese.
Pontificò circa dieci anni con una personalità piena di fede profonda e completamente devota al prestigio della Chiesa Universale, al di sopra dei partiti, rendendolo bene accetto sia ai romani che all’imperatore Lodovico II, il quale gli riservò onore e rispetto.
Conosciamo molto bene l’attività apostolica di Niccolò I, egli dovette intervenire contro l’arcivescovo Giovanni VIII di Ravenna (861) comminandogli anche la scomunica, per riportarlo all’ubbidienza al papa romano, proibendogli di appropriarsi dei beni appartenenti alla Chiesa e per la sua violenza contro i vescovi delle diocesi suffraganee, fedeli a Roma.
Altra disputa che lo vide protagonista ed arbitro fu quella con Lotario II re di Lorena, il quale respinta e chiusa in un monastero la sua consorte Teutberga conviveva con una certa Valdrada e ricorrendo a calunnie, minacce, torture, richiedeva ai vescovi locali il divorzio per poterla sposare. I vescovi di Lorena, nel Sinodo di Aquisgrana dell’862, arrendevoli alle astuzie del re, accettarono la confessione d’infedeltà di Teutberga, senza tener conto che le era stata estorta con la violenza, poi Lotario II sposò Valdrada che divenne regina.
Seguì un appello al papa dalla deposta regina, il quale intervenne contro i vescovi consenzienti scatenando disubbidienze, scomuniche e ritorsioni da parte di due di loro, quali si rivolsero all’imperatore Lodovico II fratello di Lotario; l’imperatore decise di agire con la forza e al principio dell’864 venne a Roma con le armi, invadendo con i suoi soldati la città leonina, disperdendo anche processioni religiose. Niccolò dovette lasciare il Laterano e rifugiarsi in S. Pietro, ma infine l'imperatore cedette ai decreti del papa e costrinse anche i due arcivescovi ribelli Guntero di Colonia e Teutgardo di Treviri ad accettare la sentenza papale.
Mentre in Occidente Niccolò I combatteva per affermare il primato del papa sia con i re sia con i metropoliti, in Oriente dovette combattere contro le pretese delle Autorità politiche ed ecclesiastiche di Costantinopoli.
L’epicentro si ebbe con la questione di Fozio; questi già capo cancelleria del giovane imperatore Michele III, uomo molto erudito ma anche molto ambizioso, fu eletto patriarca di Costantinopoli da Bardas primo ministro il quale in precedenza aveva deposto il patriarca s. Ignazio nell’858.
Essendo un laico, in soli sei giorni ricevette tutti gli Ordini sacri. Tutto ciò provocò il sorgere di due contrapposte fazioni, l’imperatore invitò il papa ad arbitrare la questione in un Concilio tenuto nell’aprile dell’861. Ne seguì un lungo periodo di controversie, destituzioni da incarichi, ecc. che deteriorarono anche i rapporti fra l’imperatore e il papa, Fozio giunse ad ergersi giudice del papa accusandolo di eresia, fu deposto dopo la morte violenta di Bardas e Michele III e di nuovo sostituito con Ignazio.
Il suo pontificato fu tutto un energico affermare la superiorità della Chiesa nelle cose religiose come soprattutto elezione e deposizione delle cariche vescovili e nel contempo raccomanda che i consacrati non si intromettano nel governo delle cose di questo mondo. Morì il 13 novembre 867 e fu sepolto nell’atrio della Basilica di S. Pietro davanti alle porte; nel 1630 il suo nome compare nel Martirologio Romano al 6 dicembre, ma poi la S. Congregazione dei Riti l’8 luglio 1883 lo pone definitivamente al 13 novembre.
Autore: Antonio Borrelli
SOURCE : https://www.santiebeati.it/dettaglio/77525
Giovanni-Battista Cavalieri (1525–1601),
Calcografia in Giovanni Battista Cavalieri, Pontificum Romanorum effigies,
Roma, Basa Domenico\Zanetti Francesco, 1580 - bibliothèque
municipale de Trento
NICCOLO I, santo
di François Bougard
Enciclopedia dei Papi
(2000)
Nato presumibilmente
intorno all'820, N., come i suoi due predecessori, non apparteneva
all'aristocrazia romana, pur non essendo di origini "modeste". Il
Liber pontificalis, infatti, precisa che era figlio del "regionarius"
Teodoro, uno dei notai o dei "defensores" preposti
all'amministrazione del patrimonio pontificio di una delle sette regioni
ecclesiastiche della città. L'indicazione delle funzioni paterne è abbastanza
rara da saltare all'occhio: da quando i papi, della seconda metà dell'VIII
secolo, sono con sostanziale continuità romani (752, morte di Zaccaria,
l'ultimo papa greco), i membri delle grandi famiglie prendono senz'altro il
sopravvento su candidati di estrazione inferiore (otto casi su tredici), ma le
notizie del Liber pontificalis fino a quel momento si erano limitate a
registrare quest'alternanza, sia segnalando solo il nome del padre dei
pontefici, indizio di modesti natali, sia sottolineandone l'origine
aristocratica. Specificare la funzione dimostra come una carriera
amministrativa al servizio del papato potesse rivelarsi proficua per la seconda
generazione che vi si impegnava. Gli anni della formazione di N. non presentano
tratti particolarmente originali: un'educazione tradizionale nelle materie
letterarie e sacre, senz'altro simile a quella impartita ai suoi predecessori
Adriano I, Leone III e Sergio II, in casa o nel Palatium, seguita dall'ingresso
nel clero, sotto quest'ultimo papa, e dall'ammissione agli uffici del Laterano,
dove fu nominato suddiacono e poi diacono con Leone IV. Ebbe l'opportunità di
distinguersi per la prima volta dando lettura dell'ammonitio del papa durante
il sinodo riunito a Roma nel dicembre 853, che si concluse con la deposizione e
scomunica di Anastasio, cardinale prete di S. Marcello, di lì a poco antipapa,
il futuro bibliotecario della Chiesa romana (Die Konzilien, III, nr. 32, p.
317). Benedetto III lo introdusse nella sua cerchia, fino a farlo diventare suo
principale consigliere con un ruolo esecutivo. Ripercorrendo la sua ascesa ed
illustrando i suoi meriti, il Liber pontificalis (p. 148) pone l'accento sul
fatto che il papa, per averlo al proprio fianco, derogò dalla consuetudine di
dare la precedenza ai propri consanguinei. In compenso, la precisazione che N.,
"con altri diaconi", fu tra coloro che seppellirono Benedetto a S.
Pietro nell'aprile 858, non intende sottolineare l'intimità del legame con il
papa, ma si limita ad esporre l'applicazione di una regola istituita dallo
stesso pontefice, il quale aveva disposto che ogni membro del clero romano
dovesse essere accompagnato alla sepoltura dal gruppo dei suoi
"colleghi", che riuniti avrebbero raccomandato a Dio l'anima del
defunto. Benedetto III morì il 7 aprile 858. Il Liber pontificalis presenta
l'elezione al soglio pontificio di N. come il frutto di una decisione unanime
"dei Romani": il clero, i nobili (il Senato), il popolo. L'insistenza
sul consenso raccolto è al tempo stesso un luogo comune, un richiamo discreto
alla Constitutio Romana promulgata da Lotario nell'824, che parlava del
privilegio esclusivo dell'elezione genericamente accordato ai Romani, e infine
un contrappunto al resoconto dell'elezione movimentata di Benedetto III, dove era
stato stigmatizzato il ruolo svolto dal vescovo Romano da Bagnoregio, con una
nota ironica sul nome di quest'ultimo che poco si intonava al suo comportamento
da "barbaro". Pertanto la presentazione dell'elezione di N. come una
decisione unanime e indipendente non deve dissimulare che in realtà si svolse
sotto il controllo imperiale, "praesentia magis ac favore Hludowici regis
et procerum ejus quam cleri", secondo gli Annales Bertiniani redatti
"a caldo" da Prudenzio di Troyes (che morì nell'861). Ludovico II,
che si trovava ancora a Roma il 30 marzo 858 (data di un precetto per S.
Silvestro di Nonantola, cfr. J.F. Böhmer, nr. 171), si affrettò a rientrare in
città dopo averla da poco lasciata, per seguire da vicino gli eventi. La
decisione fu presa solo "dopo alcune ore di discussione" (Le Liber
pontificalis, p. 152), perché vi erano altri candidati papabili, in particolare
il futuro Adriano II, già proposto nell'855, che anche questa volta si tirò
indietro. E, soprattutto, N. divenne pontefice dopo la consacrazione "in
presenza di Cesare", il 24 aprile, nel rigoroso rispetto della Constitutio
Romana, che era stata "dimenticata" in occasione dell'elezione di
Sergio II, nell'844, e di Leone IV nell'847. Pur senza tralasciare il ruolo
svolto da Ludovico II, il Liber pontificalis preferisce tuttavia stornare
l'attenzione da ciò con una lunga digressione sui riti che seguirono, e
ristabilirono l'equilibrio fra i due poteri. Il 26 aprile N. ricevette
l'imperatore a cena e lo ammise alla sua filiazione spirituale, poi Ludovico II
lasciò la città per spostarsi a Tor di Quinto (S. Leucius, al V miglio della
via Flaminia) dove il papa lo raggiunse. Per due volte, quando lo ricevette e
al momento del congedo, l'imperatore si assoggettò all'officium stratoris,
conducendo per le briglie il cavallo del papa e rinnovando così il gesto di
Pipino nei confronti di Stefano II a Ponthion il 6 gennaio 754, secondo una
pratica, prevista anche nel Constitutum Constantini (§ 16), che conoscerà in
seguito un largo successo essendo interpretata come un rito di accettazione del
vassallaggio. L'attento controllo esercitato sull'elezione di N. faceva pesare
un'ipoteca sulla sua indipendenza dal potere imperiale. L'influenza di Ludovico
II si misura, per esempio, dall'ingresso degli antichi avversari di Benedetto
III nella cerchia pontificia: Anastasio, già reso alla comunione dei laici da
Benedetto, al quale N. non solo promise il ritorno al sacerdozio, a patto che
restasse fedele alla Chiesa, ma conferì anche la carica di abate di S. Maria in
Trastevere; Arsenio, zio di Anastasio (piuttosto che il padre: cfr. G. Arnaldi,
Il Papato) e vescovo di Orte, che sarebbe stato a Roma il "missus"
permanente dell'imperatore, in particolare in materia giudiziaria, assistito
nel suo compito dal diacono Giovanni (Libellus de imperatoria potestate in urbe
Roma, p. 203); Radoaldo, vescovo di Porto, altro rappresentante del
"partito franco" a Roma. Inoltre, appare significativo che gli atti
emanati dalla Santa Sede ristabiliscano la datazione secondo il computo degli
anni dell'Impero, di cui viene anche sottolineata di buon grado la preminenza
sulle altre potenze terrene. Comunque questi segni esteriori, come si noterà,
non implicavano necessariamente la sottomissione. Riaffermando nel sinodo
romano del febbraio 861, il primo del pontificato di N., l'attualità del
decreto conciliare lateranense del 769 - come fece dopo di lui Giovanni VIII -
che riservava l'elezione del pontefice al clero e l'eleggibilità ai soli membri
del clero di Roma, il papa offriva d'acchito ai suoi successori un'arma di
difesa contro l'ingerenza "laica" in generale e in particolare contro
l'interpretazione troppo rigida della Constitutio Romana (Die Konzilien, IV,
nr. 5, p. 51: "Ut electionem pontificis nullus contradicere
praesumat"). I primi due anni di governo di N. non sembrano aver prodotto
una documentazione copiosa - anche se non mancano gli accenni a lettere
ricevute o inviate, oggi perdute - né hanno lasciato traccia negli annali. Il
Liber pontificalis si limita ad indicare la lista delle donazioni tradizionali
alle chiese e a descrivere gli effetti delle due piene del Tevere a Roma,
nell'ottobre e nel dicembre 860, mentre della corrispondenza si è conservata
un'unica lettera indirizzata a Venilone, arcivescovo di Sens. La missiva, che
risale probabilmente ai primissimi mesi del pontificato (prima del settembre
858), risponde ad un quesito a proposito di un sinodo provinciale delegato a
decidere sul caso del vescovo di Nevers, Erimannus, troppo malato per
continuare a dirigere la sua diocesi e accusato di vari eccessi incompatibili
con la sua carica (ep. 103; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2674;
Die Konzilien, III, p. 430). La lettera ha suscitato perplessità perché esprime
un'opinione piuttosto cauta, senza alludere a quanto si suppone abbia chiesto
l'arcivescovo, in base ad una minuta dettata a Lupo di Ferrières sullo stesso
problema: il tenore di una falsa decretale di Milziade che riservava
esclusivamente alla Sede romana il potere di deporre un vescovo. Ora, il silenzio
di N. su questo particolare punto potrebbe essere indizio dell'ignoranza delle
false decretali a Roma a quell'epoca. Ma si tratta di un'interpretazione
infondata, poiché è verosimile che la minuta di Lupo di Ferrières non sia stata
inviata e che il papa abbia solo risposto ad una richiesta sullo stesso
argomento, dove però non era menzionato il riferimento a Milziade. Al
contrario, come se il periodo compreso fra l'858 e l'860 fosse stato messo a
frutto per consolidare la situazione interna e gettare le basi per l'azione
futura, gli anni successivi registrano interventi di N. in tutti gli ambiti e
su tutti i fronti geografici simultaneamente, al punto che il nostro racconto,
per risultare coerente, deve ricorrere spesso ad una presentazione di natura tematica
piuttosto che cronologica, sulla falsariga della posizione già adottata, in
sostanza, dalla notizia del Liber pontificalis e ripresa da E. Perels per la
classificazione delle lettere del pontefice. Inoltre, a partire dai primi anni
Sessanta (forse alla fine dell'861, anche se il suo ruolo è attestato solo dal
sinodo romano dell'autunno 863, che condanna Guntero e Tilgaldo), N. prende al
suo servizio Anastasio, soprattutto, ma non esclusivamente, per la conduzione
dei rapporti con l'Oriente, che richiedevano la conoscenza del greco. Anastasio
non si è limitato a dettare la corrispondenza, ma ha dato anche voce alle idee
del pontefice con le sue traduzioni di testi agiografici (N. gli commissionò,
al principio del pontificato, la traduzione della vita di s. Giovanni
Elemosiniere; cfr. la lettera di dedica in M.G.H., Epistolae, VII, 1, a cura di
E. Dümmler, 1902, pp. 395 ss.; cfr. anche la dedica della traduzione della vita
di s. Basilio al suddiacono Urso, medico di N., ibid., pp. 398 ss.), la cui
scelta ha rinnovato la tradizione agiografica romana nel senso dell'esaltazione
del potere ecclesiastico: si tratta di vescovi, papi (Martino I), santi spesso
recenti distintisi nella lotta contro l'eresia, naturalmente orientale, e che
si sono battuti, talvolta fino alla morte, con il potere politico. La coppia
formata dal papa e dal suo segretario si cementò così rapidamente, che talvolta
i biografi di Anastasio videro in lui l'uomo chiave del pontificato:
l'ispiratore delle idee politiche ed ecclesiologiche essenziali. Senza arrivare
a ciò, si possono certamente attribuire ad Anastasio (v. Anastasio
Bibliotecario, antipapa) la forza e la chiarezza d'espressione che
contraddistinguono tutte le lettere del papa. I rapporti con Bisanzio e la
conduzione della questione orientale si possono seguire secondo ritmi quasi
stagionali, nello scambio di corrieri e ambascerie. La documentazione
complessiva, che apre, forma la parte centrale e conclude quella degli
"eventi" riportati nella notizia del Liber pontificalis, è senza
dubbio la più importante del pontificato e anche quella che ha lasciato le
tracce più profonde sia nel diritto canonico successivo che nelle relazioni fra
Oriente greco e Occidente latino. La prima opportunità d'azione sulla scena
orientale fu offerta dall'arrivo di una duplice ambasceria bizantina a Roma
nella primavera dell'860. Da una parte, giunse la sinodica di intronizzazione
di Fozio (V. Grumel, nr. 467), che esigeva una risposta formale del papa
relativamente all'integrazione del neoeletto nella pentarchia. Fozio era stato
innalzato dallo stato laico al rango di patriarca di Costantinopoli, in
sostituzione del deposto Ignazio, nell'estate 858; era stato consacrato da
Gregorio Asbestas, arcivescovo di Siracusa, in precedenza deposto dallo stesso
Ignazio. Dall'altra, pervenne una richiesta di Michele III affinché fossero
inviati legati per riunire un concilio sulle immagini (Fr. Dölger, nr. 457):
ciò dimostra che a questa data la ricerca di una posizione unanime sulle
immagini era ancora all'ordine del giorno, forse semplicemente perché Fozio,
avendo fatto parte della cerchia che si era battuta nell'843 per ristabilire le
immagini ed essendo stato suo padre esiliato dagli iconoclasti, possedeva
un'arma efficace su un tema a proposito del quale i suoi avversari si erano
mostrati singolarmente prudenti. Il passo di Michele III, presentato dal Liber
pontificalis come il risultato di uno scaltro piano comune
dell'"imperatore dei Greci" e del "neofita" (la lettera del
patriarca passa sotto silenzio e la richiesta relativa alle immagini - indizio
indiretto di come la disputa non fosse più d'attualità a Roma - vien fatta
apparire come un grossolano pretesto; discutere su questo problema minore
equivaleva a riconoscere un interlocutore peraltro contestato, ossia ad
avallare l'espulsione del patriarca Ignazio), portò ad un'unica ambasceria in
risposta, affidata ai vescovi Radoaldo di Porto e Zaccaria di Anagni. N.
domandò comunque ai suoi legati di sondare, in primo luogo, la rispettiva
legittimità di Ignazio e Fozio, dando ad intendere che da questo dipendeva il
riconoscimento del secondo (epp. 82-3 a Michele III e a Fozio, 25 settembre
860; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nrr. 2682-83). Aggiunse alla loro
missione la richiesta del ristabilimento della giurisdizione della Chiesa
romana sulle diocesi dell'Illirico, dell'Italia meridionale e della Sicilia,
che nel 732-733 erano state trasferite da Leone III alla giurisdizione del
patriarca di Costantinopoli, nonché della restituzione dei redditi dei Patrimoni
della Chiesa romana situati nei domini bizantini dell'Italia meridionale e
della Sicilia, che, nella stessa occasione, erano stati devoluti al fisco
imperiale. La volontà di riappropriarsi della giurisdizione dell'Illirico era
rivolta anche al versante franco. Infatti, fu probabilmente nell'860 che N.
fondò l'arcivescovato di Nin in Croazia (politicamente carolingia dal trattato
dell'812 con Bisanzio), alle dirette dipendenze della Santa Sede e non della
metropoli di Aquileia, polo d'irradiazione missionaria in questa regione (cfr.
ep. 140, frammentaria, "al clero e al popolo di Nin"; anche in
Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2851). Al concilio riunito ai SS. Apostoli
dall'aprile 861, l'attenzione fu comunque spostata dal caso personale di Fozio
alle circostanze della nomina di Ignazio, la cui deposizione fu confermata
essendo stato dimostrato agevolmente che era stato ordinato (nell'847) senza
essere stato eletto. Fu ribadita la condanna dell'iconoclastia, senza che ciò
destasse alcuna sorpresa, mentre furono messi all'ordine del giorno alcuni
canoni disciplinari apparentemente non previsti. Radoaldo e Zaccaria
rientrarono a Roma in estate con il resoconto dell'attività svolta,
accompagnati o seguiti da una seconda ambasceria bizantina latrice di un messaggio
di autogiustificazione di Fozio, in cui difendeva la propria elezione per la
quale non aveva brigato, predicava il pluralismo delle discipline
ecclesiastiche e si trincerava dietro l'autorità del basileus per le questioni
inerenti alla giurisdizione (V. Grumel, nr. 472). Fozio protestava anche contro
la presenza a Roma di fomentatori di disordini, che, approfittando della
propria condizione di pellegrini, diffondevano propaganda dissidente;
all'inizio dell'anno seguente, in effetti, cominciò a circolare un libello
presentato come un appello di Ignazio al pontefice romano, redatto in realtà
dal monaco Teognostos, egumeno di S. Maria della Sorgente, rifugiatosi a Roma
con altri sostenitori del patriarca deposto. La reazione di Roma fu metodica.
Il 18 marzo 862 N. inviò tre lettere in Oriente: a Fozio, sul tema del primato
romano, sì da spiegargli che non aveva l'autorità per trattare questioni
disciplinari e per contestare le argomentazioni con cui giustificava il suo
rapido passaggio dallo stato laico al patriarcato; a Michele III, per
comunicargli che al suo protetto non poteva essere riconosciuta la dignità
patriarcale e che Ignazio andava reintegrato, finché l'intera questione non
fosse stata trattata in presenza del papa; infine, agli altri patriarchi orientali,
e per loro tramite a tutti i fedeli, per deplorare il comportamento di Radoaldo
e Zaccaria, che avevano oltrepassato i limiti del mandato loro assegnato, e
rendere nota la posizione della Sede apostolica a proposito del pervasor e
neofita Fozio (epp. 84-6; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nrr. 2690-92).
Da Bisanzio non giunse alcuna risposta. Le posizioni romane furono ribadite in
un sinodo riunito in primavera o nell'agosto 863 (Die Konzilien, IV, nr. 15),
che diede attuazione ai principi e alle esigenze espressi in precedenza: Fozio
fu ridotto allo stato laicale e minacciato di scomunica se avesse conservato
una carica usurpata; i vescovi sostenitori di Ignazio vennero reintegrati;
eventuali casi dubbi erano rimessi al giudizio di Roma. Zaccaria fu deposto ed
escluso dalla comunione ecclesiastica, mentre il caso di Radoaldo, assente a
causa di una legazione in Lorena, fu rinviato ad un sinodo successivo - sarà a
sua volta deposto e scomunicato l'anno seguente da un concilio convocato in
Laterano, di fronte al quale l'interessato non si degnò di comparire (ep. 98;
anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2821). L'864 trascorse senza che si
registrassero reazioni sul fronte orientale. Solo verso la fine dell'estate 865
giunse a Roma una risposta di Michele III (Fr. Dölger, nr. 464). Il testo è
andato perduto, ma è agevole ricostruirne il tenore dalla risposta del papa:
l'imperatore Michele sferrava un attacco a Roma, città arretrata e barbara fin
nella lingua, affermava il diritto del sinodo patriarcale di decidere sul caso
di Ignazio e intimava di far rientrare a Bisanzio il monaco agitatore
Teognostos. La replica romana agli "insulti blasfemi" fu una lunga
memoria redatta da Anastasio, nell'impeto dello sdegno, e rispedita tramite il
suo latore, il protospatario Michele (28 settembre 865, ep. 88; anche in
Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2796). La riaffermazione delle conclusioni
del sinodo dell'863 a proposito di Ignazio e il rifiuto di consegnare
Teognostos non vi occupavano che uno spazio ridotto. La lettera è celebre ed è
stata commentata soprattutto a causa degli sviluppi connessi, laddove Anastasio
attinge ad un vasto arsenale scritturale e canonico, che questa volta include
le false decretali - anche se la prima citazione testuale di esse la si trova
in una lettera di Adriano II - e che fu molto utile per l'autorità posteriore
degli apocrifi di Simmaco; consente inoltre di misurare l'abisso che separava
le due cristianità. Dal VI concilio ecumenico (680) gli imperatori sono in
massima parte eretici. Il papa non deve ricevere ordini da loro, neppure se
sono cattolici. Il "nazionalismo linguistico" (M. Banniard, p. 545)
viene ritorto contro l'accusatore: il basileus non può dirsi imperatore dei
Romani, se li considera barbari; la verità è che non capisce il latino. Coloro
che si sono permessi di giudicare Ignazio lo hanno fatto illegittimamente, sia
in quanto nemici dichiarati del patriarca, sia perché colpiti da una sanzione
ecclesiastica e, in ogni caso, avevano una dignità inferiore. E la presenza
dell'imperatore, in virtù del principio di separazione dei due poteri, era
inopportuna in un'assemblea dal tema strettamente ecclesiastico e non
trattandosi di un concilio ecumenico. Il primato della Sede apostolica è
ribadito con risolutezza nei confronti di Costantinopoli, che non può in alcun
modo vantare una fondazione apostolica, a differenza di Antiochia e
Alessandria. Con queste argomentazioni, N. poteva rinnovare la richiesta,
formulata come un pacato invito, che Ignazio e Fozio si recassero personalmente
o per procura a Roma per regolare il conflitto al suo cospetto. L'imperatore,
prestando ascolto a quella che doveva essere intesa come un'ammonizione paterna
e non uno scambio di insulti (il biglietto di accompagnamento per il
protospatario Michele [ep. 89; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr.
2797], che raccomanda di vigilare sulla fedeltà della traduzione in greco,
insiste su questa distinzione), avrebbe potuto tornare a partecipare alla
comunione con la santa Chiesa apostolica. La lunga lettera di N. non suscitò
alcuna reazione da parte di Bisanzio: l'autunno 865 e quasi tutto l'866
trascorsero senza che vi fossero contatti diplomatici fra Oriente e Occidente.
I cambiamenti politici e gli imperativi militari in Oriente (assassinio, il 21
aprile 866, di Cesare Barda da parte di Basilio il Macedone su commissione di
suo nipote Michele III, che, al suo posto, associò al trono Basilio; campagna
contro Creta; assedio di Ragusa da parte degli Arabi di Sicilia) e gli sviluppi
politici in Occidente spiegano ampiamente questo periodo di stasi. Ma al tempo
stesso si allargava il fronte della disputa sul tema della concorrenza
missionaria nei paesi slavi e del destino politico delle regioni conquistate di
recente alla cristianità. Il dibattito era latente già da alcuni decenni, ma
assunse toni aspri solo con il conflitto fra patriarcati. Il khan dei Bulgari
Boris, al potere dall'852, per qualche tempo si era destreggiato fra Greci,
Franchi e Latini. Il papa, e soprattutto il sovrano del Regno franco orientale,
vedevano in lui un alleato idoneo per imporsi in Moravia, dove circolavano
missionari occidentali, originari della Baviera e di Aquileia; ma Boris,
risentito per il rifiuto categorico, da parte di Roma, ad acconsentire alla sua
richiesta di creare un episcopato indipendente, si era avvicinato a Bisanzio
affinché organizzasse la sua Chiesa - fu questa la missione di
Costantino-Cirillo e di Metodio. Nell'864 N. scrisse a Ludovico il Germanico
incoraggiandolo ad intraprendere un'azione congiunta nei confronti dei Bulgari,
perché Roma prendesse piede definitivamente in quei territori (ep. 26; anche in
Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2758). Preoccupata da un possibile
avvicinamento diplomatico e militare della Bulgaria all'Occidente, Bisanzio fece
alcune dimostrazioni militari alle sue frontiere. In pegno di pace Boris si
fece battezzare (864-865), assumendo il nome di Michele - padrino per procura -
e instaurando così, sulla base della parentela spirituale e politica con
l'imperatore, un rapporto assimilabile al vassallaggio. Ma difficoltà sorsero
nell'organizzare la Chiesa e la vita religiosa in Bulgaria in un ambiente
carico di tensioni, in quanto, se la componente slava o "autoctona"
era pronta a convertirsi al cristianesimo, non lo era altrettanto l'elemento
protobulgaro, che poteva interpretare questo passo come una perdita della
propria identità. Alla fine dell'865, o all'inizio dell'866, scoppiò una
rivolta che fu duramente repressa. Comunque, mentre Boris-Michele si vedeva già
a capo di una Chiesa nazionale autonoma, Bisanzio, ossia l'interlocutore più
diretto visto che il territorio bulgaro in massima parte era giuridicamente
alle sue dipendenze, non aveva alcun interesse che ciò avvenisse. In risposta
ad un passo compiuto da Boris in questo senso, Fozio inviò, durante o dopo la
rivolta, una lunga lettera che trattava della fede e della morale del principe,
ma non affrontava la questione dello statuto della Chiesa bulgara (V. Grumel,
nr. 481). Probabilmente la delusione o la preoccupazione di salvaguardare gli
equilibri politici spinsero Boris-Michele, ribaltando il precedente di Ratislav
di Moravia, a mandare due ambascerie in Occidente nell'estate 866: a Ludovico
il Germanico, con la richiesta di inviargli preti e materiale liturgico; a N.,
prospettandogli, fra l'altro, l'ipotesi di un patriarca di Bulgaria. Roma non
poteva che rallegrarsi di questa opportunità. Ogni occasione per contrastare
gli intrighi di Fozio era benvenuta e si doveva afferrare la possibilità di
tornare sulla questione dell'Illirico dal punto di vista giuridico. Due gruppi
di legati inoltrarono una voluminosa corrispondenza datata 13 novembre 866.
Nove lettere, affidate a Donato, vescovo di Ostia, a Leone, prete di S. Lorenzo
in Damaso, e al diacono Marino, affrontavano di nuovo il dibattito tra Fozio e
Ignazio (epp. 90-8; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nrr. 2813-21). A
Michele III (ep. 90) veniva di nuovo spiegato, ma in tono più garbato rispetto
all'865, il malinteso creato dal deplorevole contegno di Radoaldo e Zaccaria
nell'861, aggravato dal fatto che le lettere papali venivano regolarmente
falsificate all'atto di essere tradotte in greco; era allegata una nuova copia
delle lettere dell'861 e della sua del settembre 865, associata alla rinnovata
ingiunzione di reintegrare Ignazio nella sua sede e scacciare Fozio, definito
scherano del diavolo. A Barda (ep. 93), che sette mesi prima era stato
assassinato - la notizia non era giunta a Roma -, veniva chiesto di appoggiare
quest'iniziativa. I senatori di Costantinopoli erano invitati ad evitare
qualsiasi comunicazione con Fozio (ep. 97). Era inoltre sollecitato
l'intervento di Eudocia, amante di Michele, a favore di Ignazio, con l'auspicio
che fosse altrettanto devota a s. Pietro di Galla Placidia († 450; ep. 96). Il patriarca
deposto era destinatario di un messaggio di conforto, in cui si riepilogavano
tutti i passi compiuti dal papato (ep. 94). L'ex imperatrice Teodora (vedova
dell'imperatore Teofilo, madre di Michele III e sorella di Barda), che
sosteneva Ignazio ed era relegata in un convento dall'857, veniva incoraggiata
a persistere nelle sue virtù e rassicurata in merito all'impegno incondizionato
di Roma per il ritorno del suo protetto (ep. 95). A Fozio era intimato di
ritirarsi, pena la scomunica perpetua (ep. 92). Infine la corrispondenza era
trasmessa anche al clero di Costantinopoli, a tutte le autorità religiose e a
tutti i fedeli difensori della vera religione "per Asiam et Libiam
constitutis" (ep. 98). Una decima lettera (ep. 99) conteneva la "Risposta
alla consultazione dei Bulgari", affidata ai vescovi Paolo di Populonia e
Formoso di Porto, accompagnati da missionari. I Responsa di N. rivelano
l'effettiva concorrenza fra il clero delle due obbedienze sul culto e la
liturgia, la disciplina dei fedeli, la caccia al paganesimo, in un paese in cui
tutto era da costruire e dove i recenti disordini erano ancora vivi negli
animi. La sostanza del testo fissa le regole della vita religiosa, evitando di
opporsi in modo troppo sistematico alle abitudini greche, alternando toni
pastorali, fermezza istituzionale e sorridente ironia. Il papato si dichiara
innanzitutto il solo dispensatore di libri, su cui intende mantenere un rigido
controllo, per evitare interpretazioni erronee e devianti: penitenziale,
sacramentario (artt. 75-6), "leggi per il secolo" (art. 13), ossia un
codice di diritto romano piuttosto che l'Editto longobardo - al contrario di
quanto pensava M. Conrat -, circostanza significativa in un momento in cui
Bisanzio non aveva ancora effettuato la traduzione e l'aggiornamento della
tradizione giuridica "romana". Si notano divergenze sulla comunione:
sulla sua frequenza, riconducibili a una diversa valutazione del digiuno tra
Greci e Latini (art. 9); sull'obbligo stabilito dai missionari greci di riceverla
con una cintura, che consentiva di distinguere più facilmente i battezzati -
che indossavano una veste bianca con cintura - da coloro che ancora non lo
erano (art. 55); sul fatto di sapere se bisognava tenere le mani giunte per
l'intera durata della messa (art. 54), per estensione della pratica prevalente
all'atto della comunione, ricevuta in piedi, in un periodo in cui l'Occidente
vedeva affermarsi la comunione impartita direttamente in bocca; ecc. Nell'art.
70, che poteva interessare l'insieme del clero bizantino presente in Bulgaria,
il matrimonio dei preti viene riprovato ma la sua eventuale condanna
disciplinare è affidata, in ogni caso, all'autorità del vescovo: un
atteggiamento abbastanza moderato, in sintonia con gli altri interventi di N.
sul tema del celibato nel confronto con interlocutori occidentali. I Responsa
sono celebri soprattutto per la descrizione dei riti matrimoniali e le
posizioni espresse a proposito dei divieti legati alla parentela. La dottrina
era tanto più rigida e la trattazione lunga, in quanto rappresentavano, in
certo qual modo, il punto d'approdo dei numerosi interventi precedenti di N.
sul tema del matrimonio: sia a titolo collettivo, per imporre la disciplina
romana in materia di divieti, come quando aveva inviato una legazione ai Sardi
- nominalmente ancora sotto la dipendenza bizantina - nell'864, per porre fine
alle "unioni illecite" assai consuete nell'isola (Le Liber
pontificalis, p. 162), o nella risposta ad un quesito dell'arcivescovo di
Besançon sugli stessi problemi nell'865 (v. oltre, la legazione di Arsenio),
sia a titolo individuale, per regolare conflitti sorti all'interno
dell'aristocrazia occidentale (Lotario II, Bosone, Baldovino, Carlo
d'Aquitania; v. oltre). Veniva posto l'accento sulla coppia e il legame coniugale.
La bigamia, abituale all'epoca in Bulgaria, era condannata senz'appello (art.
51). L'art. 2, uno di quelli ripresi nel Decretum di Graziano, estendeva alla
parentela spirituale i divieti relativi alla consanguineità e alla parentela
acquisita/affinità; la cognatio spiritualis, che derivava dalla partecipazione
al sacramento, era addirittura superiore alla parentela naturale. Quanto ai
padrini, si faceva riferimento al Codice giustinianeo, ma non in uno dei
passaggi che proibivano l'unione fra padrino e figlioccia bensì in una
citazione sugli impedimenti dipendenti dall'adozione; la funzione di padrino,
essendo una scelta volontaria, equivaleva ad un'adozione conclusa di fronte a
Dio - un argomento già usato da s. Bonifacio - con i medesimi effetti giuridici
dell'adozione civile. L'art. 3, di gran lunga il più commentato, istituiva un
parallelo tra i riti matrimoniali greci e latini, descrivendo con minuzia le
diverse tappe dell'unione fra gli sposi. Il tono è deliberatamente neutro,
visto che la pratica consigliata in gran parte coincide con l'uso bizantino,
tanto più considerando i costumi vigenti nel resto dell'Occidente
latino-germanico: le cerimonie illustrate avevano certo un valore programmatico
per i Bulgari, ma non solamente per loro. Le divergenze con Bisanzio
riguardavano soprattutto il problema del contrarre un nuovo matrimonio e della
necessità del consenso degli sposi. N. giustifica lungamente la legittimità di
risposarsi, perché la posizione della Chiesa greca allora era molto rigida
sulla questione. Inoltre, laddove Roma vedeva nel mutuo consenso l'unico
fondamento di qualsiasi unione, al di là della perfezione del rituale, il clero
bizantino insisteva sulla necessità della benedizione in chiesa. Su questo come
su altri punti, si ha l'impressione che la missione greca cercasse d'imporre
nel campo bulgaro, che fungeva da banco di prova, una pratica che passò nella
legislazione orientale solo sotto Leone VI (A.E. Laiou). Mentre su tali
questioni N. evitava il confronto tra le due cristianità, relativizzando ciò
che era ritenuto eccesso di zelo, e trovando talvolta un terreno d'intesa su
controversie di minore importanza (come nell'art. 66, che confermava l'obbligo
di entrare in chiesa a capo scoperto, norma avvertita come umiliante dalla
classe dirigente unno-turca, abituata al turbante, segno di distinzione
sociale), le posizioni riguardanti problemi organizzativi e di giurisdizione
ecclesiastica non lasciavano margini di dibattito. Il primato romano era
affermato sulla scorta delle autorità canoniche, insistendo sul fatto che
Costantinopoli non era stata fondata da alcun apostolo (artt. 92-3). Le
conseguenze di questa presa di posizione riguardavano il crisma - essenziale
per la quotidianità dell'evangelizzazione - con il rifiuto categorico della pretesa
greca di detenerne il monopolio in queste regioni (art. 94, legato al canone 28
di Calcedonia, respinto da Roma, secondo il quale il patriarca di
Costantinopoli esercitava la propria autorità su tutti i territori barbari
annessi alle diocesi di Tracia, del Ponto e dell'Asia, essendo il solo ad avere
la facoltà di benedire l'olio), senza contare che era considerato improprio un
crisma benedetto da un patriarca deposto. Infine, N. comunicava a
Boris-Michele, già consapevole che l'adozione del cristianesimo comportava
quella di un nuovo regime familiare, che la scelta di Roma implicava pure una
rigida dipendenza istituzionale (artt. 72-3). L'eventualità di un
"patriarca" (qui come in altri testi coevi sinonimo di arcivescovo,
primate o metropolitano) era subordinata alla situazione numerica e morale
della cristianità bulgara, ovvero all'impegno del suo sovrano a diffondere la
nuova religione: per ricordare che la conversione di un capo non aveva
trasformato immediatamente il suo paese in una cristianità adulta e che la fede
senza le opere, come recitava l'art. 1, non valeva nulla. L'intervento romano
in Bulgaria era gravido di conseguenze politiche. Non aveva peraltro solo
sostenitori incondizionati in Occidente, come rivela la disputa che oppose N. e
Ludovico II a proposito della consegna delle armi bulgare a Roma. Boris le
aveva inviate contemporaneamente alla sua richiesta di missionari, ma il suo
gesto evocava in modo troppo manifesto una sottomissione politica: il papa si
attribuiva così le insegne del trionfo e della victoria, che rientravano nelle
prerogative imperiali. Malgrado le rimostranze, Ludovico ottenne solo una parte
dei trofei. Inoltre si comunicò ai missionari giunti dalla Germania sotto la
guida del vescovo Ermanrico di Passau che la loro presenza, tutto sommato
tardiva, non era più di alcuna utilità, in un territorio che gli inviati di
Roma avevano già provveduto senza indugio a suddividere. L'entusiasmo, che la
rapidità della reazione pontificia e l'energia profusa dai legati sembrò provocare
nel khan, si tradusse nella richiesta, trasmessa da un'ambasceria inviata a
Roma nel settembre-ottobre 867, affinché venisse conferita a Formoso la dignità
di arcivescovo di Bulgaria. Il papa, che voleva riservarsi libertà di scelta e
temeva un'eccessiva indipendenza da parte di Formoso, addusse l'impossibilità
canonica del trasferimento da una sede episcopale ad un'altra. Formoso avrebbe
proseguito nella sua missione a Costantinopoli, mentre i vescovi Domenico di
Trivento e Grimoaldo di Bomarzo sarebbero partiti alla volta della Bulgaria
accompagnati da preti, tra i quali Boris poteva proporre un candidato. Quanto
al conflitto con Fozio, era inevitabile che si rinfocolasse, anche solo per il
fatto che uno dei primi gesti di Boris, una volta ricevuti i Responsa, fu
quello di rimandare i membri del clero greco ai loro paesi d'origine.
L'iniziativa romana appariva tanto più offensiva per il suo carattere ten-
tacolare, perché alla lettera ai Bulgari si aggiungeva quella che era
senz'altro una risposta al principe d'Armenia Aschot Bagratuni, in cui si
mescolavano informazioni relative alla condanna di Fozio e notizie sulle eresie
trinitarie e cristologiche ancora diffuse in questa regione, che aveva preso le
distanze dall'Islam e sondava il terreno sia sul versante bizantino che romano
(ep. 87; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2736, frammentaria; cfr. P.
Halfter, pp. 107-10, per la proposta di datazione). L'ambasceria romana latrice
di altre lettere, che era passata in Bulgaria, rimase bloccata alla frontiera
bizantina per quaranta giorni (primavera-estate 867), allo scadere dei quali le
venne chiesto di sottoscrivere i decreti di un sinodo che Fozio aveva appena
concluso a Costantinopoli: i Latini vi erano accusati di diffondere dottrine e
pratiche dannose in Bulgaria, tra cui una professione di fede che includeva il
Filioque. Quindi Fozio convocava gli altri patriarchi d'Oriente ad un concilio
ecumenico, per reagire a queste usurpazioni e giudicare gli errori propagati.
Poco tempo prima, forse al corrente della tensione diplomatica suscitata dalla
vicenda dei trofei bulgari, aveva scritto a Ludovico II e alla moglie
Engelberga promettendo di farli riconoscere imperatori a Costantinopoli se
avessero scacciato N. dalla Sede apostolica (V. Grumel, nr. 495). Mettendo la
coppia sullo stesso piano del basileus, era possibile rivolgersi ai due sovrani
come faceva N. con Michele III. Il "conciliabolo foziano", presieduto
da Michele III, si aprì nell'agosto o settembre 867; il primo atto consistette
nel pronunciare la deposizione di N., associata all'anatema, e nel condannare
come eretica la formulazione romana della processione dello Spirito Santo.
Mentre un'ambasceria partiva alla volta di Roma per notificare la decisione,
un'altra era inviata a Ludovico II ed Engelberga con la richiesta di cacciare
il papa deposto; un corriere separato, simmetrico a quello che N. aveva voluto
trasmettere ad Eudocia l'anno precedente e che ora si trovava in mano a Fozio,
era destinato a Engelberga, paragonata a Pulcheria imperatrice della pars
Orientis (399-453) come Eudocia lo era stata da N. a Galla Placidia, affinché
intervenisse presso il marito per gli stessi motivi (ibid., nrr. 499-500; i
testi sono perduti, ma si può supporre che Fozio abbia malignamente goduto nel
ritorcere contro l'avversario la sua stessa arma epistolare). Da parte sua N.,
indebolito nel fisico, consapevole che la posta in gioco si spostava dal
terreno della disciplina e dell'ecclesiologia a quello del dogma, forse
inquieto per l'andamento dei suoi rapporti con Ludovico II, cercò di mobilitare
in suo appoggio tutto il clero occidentale. Incmaro per il Regno franco
occidentale e Liutberto (arcivescovo di Magonza) per quello orientale
ricevettero un riepilogo del contenzioso dalle origini; venne loro richiesto di
domandare agli altri metropoliti dei rispettivi Regni di riunire i loro
suffraganei per formulare le risposte più idonee agli insulti dei Greci a
proposito del digiuno del sabato, del Filioque, del matrimonio dei preti e del
primato romano: le loro risposte andavano trasmesse a Roma. Carlo il Calvo e
Ludovico il Germanico erano invitati ad assicurare il massimo sostegno a questa
consultazione (epp. 100-02; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nrr. 2879,
2882-83, 23-30 ottobre 867; gli Annales Fuldenses, p. 66, aggiungono l'Italia
fra le destinazioni dei corrieri). Allo stesso tempo il papa riprese
l'iniziativa in campo missionario, inoltrando a Costantino-Cirillo e a Metodio
un invito affinché si recassero a Roma. L'opera da loro svolta in Moravia si
stava rivelando fruttuosa, pur suscitando reazioni vivaci nel clero
franco-occidentale; i due fratelli inoltre erano ammantati dall'aura della
scoperta delle reliquie di s. Clemente, avvenuta durante il loro soggiorno a
Cherson nell'inverno 860-861. L'invito del papa li raggiunse a Venezia, dove
erano in procinto di imbarcarsi alla volta di Costantinopoli per l'ordinazione
di un gruppo di chierici moravi. La missiva doveva contenere proposte concrete,
perché ebbe effetti immediati. Ma Costantino-Cirillo e Metodio arrivarono a
Roma solo dopo la morte del papa - anche se è a quest'ultimo che la Vita di
Metodio (cap. 6) attribuisce la ricezione dei libri slavi e la celebrazione
della liturgia in slavo a Roma, come pure l'ordinazione dei due fratelli. Nel frattempo
l'assassinio di Michele III, nella notte tra il 23 e il 24 settembre 867, mise
fine agli intrighi di Fozio, che fu subito relegato in un convento, mentre
Ignazio venne reintegrato il 23 novembre, dieci giorni dopo la morte di
Niccolò. Non è accertato che il papa abbia avuto notizia di questa rivoluzione
di palazzo. La sua vittoria postuma è racchiusa nelle lettere di Ignazio e di
Basilio I, dell'11 dicembre, che spiegavano le circostanze del ritorno di
Ignazio e si rimettevano a Roma per decidere della sorte di Fozio. Quanto alle
consultazioni richieste da N., si tennero nel quadro di un sinodo nel Regno
franco orientale (Worms, maggio 868: Die Konzilien, IV, nr. 25) e si
configurarono come trattati individuali rappresentativi dei diversi cleri locali
in quello occidentale (il Liber adversus Graecos di Enea di Parigi per la
provincia di Sens; i quattro libri dei Contra Graecorum errores opposita di
Ratramno di Corbie per la Belgica secunda, e un'opera perduta di Oddone di
Beauvais - a meno che non si tratti di quella di Ratramno messa a suo nome). Un
altro dei molti problemi scottanti all'ordine del giorno, quando N. salì al
soglio pontificio, era stato il contrasto fra Roma e Ravenna, che si protrasse
per tutto l'861, ennesima recrudescenza di un conflitto che impegnava le due
città già dall'inizio dell'VIII secolo. La disputa era legata al particolare
statuto di Ravenna: essendo quest'ultima sede del potere bizantino in Italia,
l'arcivescovo era un personaggio di spicco, il quale riteneva che la posizione
di Roma non fosse superiore alla sua. Per qualche tempo Ravenna era anche stata
autocefala, dal 666 (concessione di Costante II) al 680 (pace fra i Bizantini e
i Longobardi), poiché riceveva il pallium dall'imperatore. Nel 680
l'arcivescovo Teodoro era rientrato nei ranghi, ma continuava a sopravvivere
una forte corrente antiromana - cui aveva dato voce il Liber pontificalis di
Agnello di Ravenna una ventina d'anni prima del pontificato di N. - che
periodicamente alimentava tentativi di indipendenza, come quello intrapreso
dall'arcivescovo Felice (709-725). La situazione si era complicata alla metà
dell' VIII secolo: alla "restituzione" dell'Esarcato e della
Pentapoli a S. Pietro, grazie a Pipino il Breve, si associava la cessione di
principio dell'insieme della giurisdizione secolare, ossia del potere che
l'arcivescovo aveva gradualmente eroso col favore del disimpegno bizantino.
Dopo una lotta accanita, Paolo I aveva finito per cedere su quest'aspetto
temporale, ma soltanto a titolo di delega da parte di Roma. L'arcivescovo
Giovanni VII (850-878) disponeva di solidi argomenti per riprendere la politica
dei suoi predecessori: il fratello, il duca Gregorio, era il comandante
militare della città, la Chiesa ravennate disponeva di un cospicuo patrimonio fondiario,
lo stesso prelato era in rapporti d'amicizia con Ludovico II. Il Liber
pontificalis romano (p. 155) descrive nei dettagli gli aspetti temporali e
giurisdizionali di un'azione che sembra essere stata condotta con metodo e
continuità a discapito di Roma: i titoli di proprietà furono cercati negli
archivi per cancellarvi tutto ciò che poteva riferirsi alla Santa Sede e di
conseguenza restituire a Ravenna le terre e le loro rendite; i riconoscimenti
di soggezione a Roma dei prelati precedenti vennero falsificati, mentre si
fabbricavano privilegi o diplomi "in lingua e scrittura barbare" (in
altre parole: imitazioni dei diplomi longobardi); il clero locale fu richiamato
all'ordine in nome dell'autorità metropolitana indipendente da Roma. Giovanni
approfittò della circostanza che la sua provincia ecclesiastica coprisse larga
parte dell'Emilia per adottarvi la stessa politica. Nell'853 Leone IV aveva già
inviato lettere di biasimo a Giovanni VII e al fratello, soprattutto per
protestare contro le usurpazioni fondiarie (ep. 5, in M.G.H., Epistolae, VI, 1,
a cura di E. Dümmler, 1902, pp. 588 ss.). Al più tardi nell'860, in seguito
alle rimostranze di "molti ravennati", N. lo convocò invano a Roma
affinché desse spiegazioni di fronte ad un sinodo. Dopo tre richiami scattò la
scomunica, nel sinodo detto "dei Sette Canoni", il 24 febbraio 861
(Die Konzilien, IV, nr. 5). Nondimeno il sinodo non stigmatizzava tanto la sua
azione antiromana, quanto il fatto che Giovanni non avesse ritenuto opportuno "purgarsi"
di fronte all'istanza ecclesiastica di un'accusa di eresia rivoltagli dal
vescovo di Pola - solo la soluzione di quest'imputazione consentiva di passare
all'esame delle altre lagnanze, come dimostra il sinodo successivo. La devianza
riguardava all'apparenza la natura di Cristo (aveva sofferto sulla croce sia
come uomo che come Dio? Si ritrova la condanna del teopaschismo, su cui N.
ritornò occupandosi degli affari armeni nell'866) e l'efficacia del battesimo
(un sentore di predestinazione). Il quinto decreto, che ricordava come
l'elezione del pontefice fosse riservata ai Romani, secondo la Constitutio
dell'824, considerava nulli gli apprezzamenti che Giovanni aveva potuto fare
sui meriti di N. e, allo stesso tempo, tacendo sul ruolo dell'imperatore,
serviva forse da avvertimento a Ludovico II, i cui legami con l'arcivescovo
dovevano essere noti, se aveva mostrato delle velleità di intromettersi negli
affari ecclesiastici. Di fatto Giovanni VII si recò a Pavia per chiedere
l'appoggio dell'imperatore (e/o quello di Engelberga, a sentire il Libellus de
imperatoria potestate in urbe Roma, che tuttavia sembra far confusione con
l'intervento dell'imperatrice a favore di Guntero e Tilgaldo nell'864).
Ludovico lo fece accompagnare a Roma da due "missi" - la sospensione
era in vigore finché Giovanni non si fosse presentato davanti ad un'assemblea
ecclesiastica. N. rifiutò di cedere a questa dimostrazione di forza: poiché i
"missi" avevano comunicato con Giovanni VII, non poteva assolutamente
riceverli; quanto all'arcivescovo, avrebbe potuto rispondere delle sue azioni
di fronte ad un altro concilio, fissato per il 1° novembre. Tornato a Ravenna
(fine aprile 861), Giovanni VII riprese ancora più energicamente la sua
politica, incoraggiato dallo stesso Ludovico II, che il Libellus de imperatoria
potestate in urbe Roma descrive come dedito alla causa ravennate, al punto da
far sorgere fra l'imperatore e il pontefice una "gravis inimicitia" -
il resoconto contrasta puntualmente con quello del Liber pontificalis, che invece
mostra riguardo per Ludovico II, allo scopo di dimostrare il rispetto imperiale
verso le sanzioni emanate da Roma, mentre viene esaltato l'atteggiamento del
vescovo Liotardo di Pavia (la cui sede dipendeva direttamente da Roma), il
quale insieme al suo clero rifiutò qualsiasi contatto con lo scomunicato. Gli
obiettivi dell'imperatore ora coincidevano con quelli dell'arcivescovo,
convergendo in un unico attacco sferrato agli interessi fondiari di Roma: egli
avrebbe così proceduto alla confisca di beni che dipendevano dal Patrimonio
nella Pentapoli e in "Campania" (nell'accezione geografica romana del
termine), da distribuire ai suoi fedeli, mentre avrebbe preteso servitia
quotidiani da parte dei monasteri. In questa indicazione del Libellus si
possono scorgere i primi segni di una volontà, riaffermata in seguito alla fine
del IX secolo, di applicare a questi territori le regole di gestione dominanti
nel resto del Regnum, in particolare per la riscossione del pastus imperatoris
e per la divisio dei beni temporali ecclesiastici, una parte dei quali doveva
essere assegnata sotto forma di benefici, come nel noto caso di Bobbio.
Comunque sia, una nuova accusa prese la via di Roma, di portata più ampia come
ambito geografico ("uomini dell'Emilia") e socialmente più altolocata
("i senatori di Ravenna") rispetto alla prima. Verso la metà
dell'ottobre 861 N. si recò personalmente a Ravenna - si trattò del solo
viaggio del suo pontificato - provocando la fuga di Giovanni a Pavia. Senza
potergli manifestare, questa volta, il suo appoggio troppo esplicitamente
(secondo la versione del Liber pontificalis), l'imperatore fece di nuovo
accompagnare l'arcivescovo a Roma dai suoi rappresentanti, la cui intercessione
rimase priva di effetti come la precedente. Giovanni finì per presentarsi a
Roma (Die Konzilien, IV, nr. 8). Il 16 novembre 861, nella domus Leoniana (al
Laterano), lesse pubblicamente la dichiarazione di fedeltà a Roma, riscritta di
suo pugno, e giurò di attenervisi. La riconciliazione fu suggellata il 17,
quando si purgò dell'accusa di eresia prestando giuramento. Il 18, rimosso
ormai ogni ostacolo procedurale, i Padri furono in condizione di giudicare le
accuse di ordine materiale. Giovanni dovette impegnarsi a presentarsi ogni anno
al cospetto del pontefice, affinché si potesse controllare la sua azione. Il
concilio promulgò inoltre numerosi canoni che limitavano rigidamente le
prerogative dell'arcivescovo in materia di consacrazione dei suffraganei
emiliani, successiva all'elezione da parte del duca, del clero e del popolo, nonché
all'autorizzazione scritta del papa (decisione che allineava Ravenna alle altre
sedi metropolitane; la regola fu ricordata in seguito a Giovanni in merito alla
sostituzione del vescovo di Gavello, Oleoberto, che era stato assassinato: ep.
152; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2868). Le dispute fondiarie
erano rimesse alla giurisdizione di Roma o del rappresentante pontificio a
Ravenna, tradizionalmente incaricato della gestione dei patrimonia locali e
della percezione dei censi sulla terra. N. diede immediatamente notizia di
questa "liberazione" ad ognuno dei vescovi dell'Emilia (ep. 105;
anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2687, in cui sono riportate in
dettaglio le lagnanze nei confronti di Ravenna, di ordine essenzialmente
fiscale), premurandosi di specificare che il concilio doveva servire d'esempio
affinché gli altri metropolitani non cadessero preda di tentazioni analoghe.
L'arcivescovo di Vienne Adone fu informato a sua volta del perdono concesso a
Giovanni VII (ep. 106; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2697). La
corrispondenza di N. include anche due frammenti di lettere non datate
indirizzate all'arcivescovo di Ravenna, trasmesse dalle collezioni canoniche
posteriori. Il primo, nel quale si afferma che l'insegnamento dei catecumeni
non dipende da una Chiesa piuttosto che da un'altra, suona come un richiamo
all'ordine (ep. 135; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2841) e si
potrebbe ipotizzare di riferirlo al periodo antecedente all'861. Il secondo
(ep. 137; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2843), in risposta a una
consultazione su un adulterio, dovrebbe invece essere posteriore. La fermezza
opposta alle velleità di autocefalia di Ravenna appare identica anche nei
rapporti con gli altri metropoliti e vescovi, dai quali N. pretese sempre la
rigorosa applicazione delle regole canoniche, a rischio di tornare sulla
giurisprudenza conciliare locale e di dover puntualmente intervenire presso i
diversi sovrani. I diritti della gerarchia, in particolare metropolitana, sono
riaffermati costantemente, ma non lo è in minor misura la possibilità di
appello a Roma. Un primo esempio fu la risposta ad una consultazione di
Salomone, primo "re" di Bretagna (857-874), a proposito delle
conseguenze dello scisma bretone nell'862. Leone IV e poi Benedetto III erano
già insorti contro la deposizione di prelati bretoni guadagnati alla causa
franca che ostacolavano l'emancipazione della regione (Quimper, Alet, Dol,
Saint-Pol-de-Léon, Vannes), avvenuta nel maggio 849 per iniziativa di Nominoé
("missus imperatoris in Brittania", 831-851), in virtù dell'accusa
forse non infondata di simonia: un vescovo poteva infatti essere condannato
solo da dodici suoi pari e in presenza del metropolita. Era poi sorto un
conflitto per la sede di Nantes: Attardo, sostituito nell'850 da Gislardo, fu
poi reintegrato grazie all'accordo concluso fra Carlo il Calvo ed Erispoé
(851-857), figlio e successore di Nominoé, e ripeté le ordinazioni del vescovo
intruso Gislardo. N., che si era già espresso al proposito in missive andate
perdute, esortò nuovamente Salomone, desideroso di legittimarsi ristabilendo la
pace religiosa (principale esponente di un ramo collaterale della famiglia di
Nominoé, Salomone aveva assassinato Erispoé), di uniformarsi alle procedure
definite dalla ecclesia e di rimettere il caso all'arcivescovo di Tours, di cui
le diocesi bretoni erano suffraganee, o, in caso di fallimento, alla Sede
apostolica. Il papa ne approfittò per invocare la pace con Carlo il Calvo,
premessa indispensabile a qualsiasi trattativa per la creazione di una
provincia ecclesiastica bretone, che Salomone avrebbe voluto affidare al
vescovo di Dol (ep. 107; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2708).
Entrambi i problemi furono regolati provvisoriamente nell'865-866. I vescovi di
Quimper e di Saint-Pol-de-Léon, rimasti in Bretagna dopo la deposizione (quelli
di Dol e di Vannes si erano rifugiati nella Francia occidentale), riebbero le
loro sedi, mentre N. riconobbe il vescovo nominato nella sede di Alet, cui fu revocata
la scomunica pronunciata dall'arcivescovo di Tours (v. l'ep. 129; anche in
Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2852, ove N. si rivolge a lui come prelato
legittimo). Invece il papa rifiutò nuovamente l'istituzione di una provincia
ecclesiastica bretone: la metropoli bretone era Tours, a meno che la sede di
Dol potesse esibire prove che stabilivano come avesse già ricevuto il pallium
in passato, da mettere a confronto con quelle esibite da Tours (epp. 122,
126-27; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nrr. 2789, 2806-07). E il 29
settembre 866 fu l'arcivescovo di Tours, assistito per giunta da Attardo di
Nantes, che consacrò Electrannus nuovo vescovo di Rennes; Salomone, seguendo
alla lettera la procedura "romana", tanto più significativa nel caso
di Rennes considerando che il predecessore di Electrannus era stato un
sostenitore dello scisma bretone, dimostrava la sua volontà di conciliazione.
In Italia il richiamo all'ordine di Landolfo, vescovo (e conte) di Capua,
verosimilmente nell'863 - secondo la cronologia stabilita da R. Davis sul
modello di quella ricostruita da H. Geertman per i precedenti pontificati -
ossia al momento della sua elezione, obbedisce allo stesso principio. Landolfo,
di propria autorità, aveva deposto il diacono Pepone senza rispettare la
procedura che esigeva, per un giudizio secondo le regole, la presenza di tre
vescovi, la prova dell'accusa e la possibilità di difendersi per l'accusato. Su
richiesta di Pepone, N. annullò la sentenza e decise di emettere personalmente
un verdetto (Le Liber pontificalis, p. 159). Ora, malgrado l'antichità dei
decreti invocati dove si fissava il numero dei prelati richiesto per giudicare
un vescovo, di fatto si trattava di una relativa novità, "introdotta"
da Leone IV per disciplinare la prassi stabilita. L'intervento di N., in questo
come nel precedente caso, ha contribuito a dare un assetto alla giurisprudenza
di una regola di applicazione recente, che comprensibilmente si scontrò con
alcune resistenze. Sempre in Italia N. fece annullare la sostituzione del
vescovo di Piacenza Suffredo con il diacono Paolo, suo nipote. Suffredo aveva
rinunciato alla carica, che deteneva - al più tardi - dall'852, nella fase
culminante della tensione tra Ludovico II e N. a proposito di Guntero e
Tilgaldo (si è ipotizzato che si trattasse del sinodo riunito a Pavia nel
febbraio 865), senza consultare l'arcivescovo di Milano, da cui dipendeva, e
ancor meno la Sede apostolica. Suffredo non aveva cattivi rapporti con
l'imperatore, ma sembra che Engelberga, coinvolta nei suoi progetti di
fondazione monastica (S. Risurrezione-S. Sisto di Piacenza), abbia trovato in
Paolo un interlocutore più propenso a sostenere i suoi affari immobiliari e
quindi abbia sollecitato la sostituzione. Comunque sia, N. bloccò la manovra
esigendo, nel corso dell'865, la reintegrazione del prelato: il papa, se
necessario, avrebbe potuto sempre sottoporlo ad esame di fronte ai suoi pari
(ep. 120; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2791 e Le Liber
pontificalis, p. 163). Paolo ottenne la riconciliazione, accompagnata tuttavia
dal divieto di occupare la sede di Piacenza anche dopo la morte di Suffredo:
nondimeno, fu proprio lui a succedergli sotto il pontificato di Adriano II. Le
relazioni con il clero della Francia occidentale ruotano soprattutto intorno ai
contatti con Incmaro, arcivescovo di Reims, a proposito delle vicende di
Rotado, vescovo di Soissons dall'832, e di Vulfado, canonico di Reims.
All'origine della questione vi era la deposizione dell'arcivescovo Ebbone,
predecessore di Incmaro a Reims, il quale era stato sempre fedele a Lotario I.
Coinvolto nella disgrazia del suo protettore dopo la ribellione contro Ludovico
il Pio, era stato deposto nell'835, poi reintegrato brevemente da Lotario alla
morte del padre, nell'840, prima di essere nuovamente deposto nell'843, dopo la
disfatta di Lotario contro i fratelli. Incmaro, succedendo a Ebbone, sospese i
chierici ordinati nell'840-841, in seguito ottenne da un concilio riunito a
Soissons nell'aprile 853 che fossero a loro volta deposti (Die Konzilien, III,
nr. 27). Rotado era fra coloro che avevano riconosciuto Ebbone nell'840 e non
aveva aderito alle posizioni di Incmaro al concilio dell'853.
Quest'atteggiamento gli procurò una forte ostilità, rivelata da numerosi
richiami all'ordine per violazione delle regole canoniche nell'amministrazione
della sua diocesi. Scomunicato da Incmaro una prima volta nell'861 per aver
rifiutato di reintegrare un prete che era stato deposto, si era appellato a
Roma e all'arcivescovo di Treviri, un passo quest'ultimo che metteva in secondo
piano la sede di Reims, in sintonia con le pretese accampate da lungo tempo da
Treviri, ma che appariva inaccettabile ad Incmaro. Al concilio di Pîtres, nel
giugno 862 (ibid., IV, nr. 10), fu accolto il principio del giudizio di Rotado
davanti ad altri dodici vescovi - in veste di judices electi -, piuttosto che
quello dell'appello, a cui l'imputato sembrò rinunciare, almeno secondo quanto
testimonia Incmaro. Nell'autunno 862 Rotado fu condannato e confinato in un
monastero. Ma poiché a Roma giunse ugualmente la voce della sua volontà di fare
appello alla Sede apostolica, la reazione di N. fu immediata. Fin dall'inizio
del'863, il papa pretese da Incmaro (comunicandolo anche a Carlo il Calvo),
pena la sospensione, che Rotado fosse liberato e reintegrato nella carica o, se
le accuse nei suoi confronti non fossero decadute, che fosse accompagnato a
Roma dall'arcivescovo o da un suo rappresentante, insieme al clero che aveva
innescato la disputa, per esaminare la questione (epp. 55-6; anche in Regesta
Pontificum Romanorum, nrr. 2712-13). Nel mentre giunse a Roma l'arcivescovo
Oddone di Beauvais, latore degli atti e del resoconto dell'assemblea dell'862 -
dai quali emergeva che già si era provveduto a sostituire Rotado - insieme ad
una richiesta di conferma della decisione presa. N. rispose ai vescovi
dilungandosi sui motivi per cui la loro condotta era stata lesiva dei diritti
di S. Pietro; ad Incmaro, che aveva trasmesso tramite Oddone una richiesta di
conferma dei privilegi per la Chiesa di Reims, biasimando il suo contegno e
subordinando una risposta affermativa all'invio di Rotado a Roma; si rivolse a
Carlo il Calvo pregandolo di dare il suo contributo al viaggio; infine, a
Rotado, per informarlo dei passi compiuti e invitarlo a recarsi subito a Roma
perché la sua causa fosse esaminata (epp. 57-8, 60-1; anche in Regesta
Pontificum Romanorum, nrr. 2721-23, 2727, fine aprile 863). Rotado fu liberato
in estate, e nel mese di ottobre tutto sembrava pronto per la sua partenza per
Roma (cfr. epp. 62-5; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nrr. 2737-40*, in
cui N. si rallegra per la sua liberazione, appresa da corrieri inviati dal
diacono Liudone, e insiste sul viaggio). Tuttavia, la tensione nei rapporti fra
Carlo il Calvo e Ludovico II a proposito della successione "lorenese"
e fra N. e Ludovico dopo la condanna di Guntero e Tilgaldo (v. oltre) ritardò
la partenza di Rotado, che giunse solo nel giugno 864, subito dopo che il papa
aveva nuovamente protestato con Incmaro per la lentezza con cui procedeva la
vicenda (ep. 66; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2756; Annales
Bertiniani, p. 112 [J.F. Böhmer, nr. 223], per le difficoltà che venivano
frapposte all'arrivo di Rotado in Italia). Dopo aver atteso invano per un po' i
rappresentanti del partito avverso, N. prese in mano la situazione. Approfittò
della messa del 24 dicembre in S. Maria Maggiore per esporre gli antefatti
della vicenda e ristabilire solennemente Rotado nella sua carica, premessa di
qualsiasi "processo". Il discorso valeva come apertura del sinodo che
si riunì il 21 e 22 gennaio successivi, dopo aver constatato una volta di più
la mancata comparizione dei querelanti (Die Konzilien, IV, nr. 20). Il 21, in
S. Agnese fuori le Mura, Rotado diede lettura di un libello (non conservato, a
meno che non si tratti del suo Libellus proclamationis, la cui redazione non è
anteriore a dicembre, nel quale faceva apertamente appello al papa), dove
riaffermava il suo impegno a rispondere agli accusatori. Poi, rivestito degli
ornamenti episcopali, celebrò la messa nella vicina chiesa di S. Costanza. Il
22, in Laterano, la sua difesa venne esposta nei dettagli e la reintegrazione
confermata. Le lettere che annunciavano la soluzione della questione - a
Incmaro e a Carlo il Calvo, al clero della Gallia e a quello di Soissons -
furono redatte immediatamente; Rotado ripartì per la Francia all'inizio
dell'865, in occasione della legazione di Arsenio (v. oltre), e riprese le sue
funzioni in estate (morì nell'869). Incmaro non proferì parola sull'epilogo
della vicenda, ad eccezione di un resoconto sdegnato negli Annales Bertiniani.
A prescindere dalle varie vicissitudini, l'affare di Rotado assume un notevole
rilievo perché si fece ricorso indirettamente alle false decretali. La loro
influenza è manifesta nel discorso pronunciato da N. il 24 dicembre, nel
Libellus proclamationis di Rotado e nelle lettere di fine gennaio, anche se
risulterebbe vana la ricerca di una citazione diretta della raccolta negli
scritti promulgati dalla Santa Sede. La collezione fu portata probabilmente da
Rotado stesso, ma è impossibile stabilire se N. fosse consapevole di utilizzare
dei falsi. Le false decretali sono evocate da Rotado nello spirito che ha
ispirato la loro costituzione, ossia in un senso antimetropolitano "egualitario",
dove il ricorso alla Sede romana viene inteso come un baluardo contro
l'eccessiva ingerenza degli arcivescovi; da N., che volge l'argomento a proprio
favore per esaltare il primato di S. Pietro (a proposito dell'obbligo
dell'accordo papale per ogni deposizione vescovile, della prerogativa romana di
convocare concili generali e della disciplina dell'appello, tesi che
confluivano nella rivendicazione da parte di Roma di amministrare, in
esclusiva, tutto quanto concerneva i vescovi, poiché si trattava di causae
maiores); dallo stesso Incmaro, nella sua corrispondenza dedicata al tema
nell'863-864, per difendere i sinodi provinciali, la procedura dei
"giudici scelti" che escludeva l'appello, e per dare una definizione
delle primazie in cui Reims trova il suo posto, allo stesso titolo di Treviri,
garantita da un rapporto immediato con Roma. La deposizione dei "chierici
di Ebbone" innescò un nuovo conflitto nell'865, questa volta più aspro,
che ruotava intorno al caso di Vulfado, sul quale il Liber pontificalis tace,
ma che ha dato origine ad una copiosa corrispondenza. Le prospettive di
carriera ecclesiastica dei chierici deposti a Soissons nell'853, tra cui
figurava Vulfado, ponevano un duplice problema: si poteva ritenere che
facessero parte del clero a pieno titolo, visto che erano stati ordinati da
Ebbone nell'840-841, quando era stato ristabilito sulla cattedra di Reims solo
in seguito all'ordine di Lotario? Una risposta positiva avrebbe rimesso in
discussione la legittimità dello stesso Incmaro. La posizione del nuovo
arcivescovo di Reims sembrava sicura, poiché sia Leone IV che Benedetto III e
N. avevano confermato non solo il sinodo dell'853 ma anche il pallium e i
privilegi di Incmaro (epp. 59-59a; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nrr.
2664, 2720). Tutt'al più la conferma di N. provvedeva ad inserire una clausola
di riserva dell'autorità romana, che all'epoca di Benedetto III non era apparsa
utile: "si in nullo ab apostolicae sedis praeceptionibus quoquomodo
discrepaveris". N. fu probabilmente meglio informato sul complesso
dell'affare dei "chierici di Ebbone" a partire dal giugno 864,
allorché iniziò il lungo soggiorno di Rotado a Roma. E uno dei compiti affidati
nell'estate seguente alla legazione di Arsenio, vescovo dI Orte e antico avversario
di Benedetto III, fu proprio l'indagine su questa vicenda (cfr. ep. 38; anche
in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2788). Comunque sia, il 3 aprile 866, il
papa chiese a Carlo il Calvo di esercitare pressioni su Incmaro perché Vulfado
e i suoi colleghi fossero reintegrati o, almeno (e la richiesta ora suonava
come un ordine), di riunire un sinodo a Soissons perché riesaminasse a fondo la
questione. E un corriere dello stesso giorno ne comunicò anche la data, il 18
agosto seguente, ad Incmaro, ai vescovi e agli arcivescovi del Regno franco
occidentale. Se i chierici deposti volevano fare appello alla Sede apostolica,
questo loro passo avrebbe dovuto essere facilitato in ogni modo (epp. 73-6;
anche in Regesta Pontificum Romanorum, nrr. 2802-04; N. ricordava per inciso
che questa volta non avrebbe tollerato manovre, "sinistra cogitatio",
sul termine utile per l'appello, perché nulla lo giustificava nella tradizione
canonica: in questo caso, si faceva riferimento ai canoni del concilio di
Serdica del 342-343, citati da Incmaro nell'affare di Rotado). Gli atti,
secondo la norma, sarebbero stati inviati a Roma. Mentre si preparava il
concilio, Carlo il Calvo, legato a Vulfado, volle accelerare la procedura e
chiese a N. di reintegrarlo senza ulteriori formalità, dato che si presentava
l'occasione di destinarlo alla sede di Bourges, vacante per la morte
dell'arcivescovo Rodolfo (21 giugno 866). Ma il papa rifiutò questa decisione
"immatura" e incurante del suo personale esame, che invece egli
teneva a fondare sugli atti del sinodo da lui stesso convocato (ep. 77; anche
in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2811, 29 agosto 866). La riunione si
svolse alla data prevista, presieduta dall'arcivescovo di Sens Egilone e con
una forte rappresentanza di vescovi (Die Konzilien, IV, nr. 23, 18-25 agosto
866). Com'era prevedibile, i prelati del Regno franco occidentale fecero
ricadere su Roma la responsabilità della decisione. Certo, i sacramenti
amministrati da Ebbone nell'840-841 erano validi (rimetterli in discussione o procedere
a nuove ordinazioni equivaleva ad esporsi ad un'accusa di eresia). Ma un primo
concilio si era già pronunciato e i suoi atti, irreprensibili sul piano del
diritto, erano stati confermati da Roma, di conseguenza solo Roma avrebbe
potuto tornare sulla questione: in altre parole, riformare la propria
decisione, secondo una procedura che N. difficilmente avrebbe potuto
legittimare sulla base della tradizione canonica. Carlo il Calvo, di per sé,
ritenne risolto il caso e senza indugi dispose l'elezione di Vulfado alla sede
di Bourges. Il papa regolò la questione nel dicembre 866. Vulfado fu
reintegrato ufficialmente e ricevette un messaggio di felicitazioni. Tuttavia
N., vietatogli ogni trionfalismo nei confronti di Incmaro, il quale aveva a
disposizione un anno per appellarsi a sua volta contro la decisione di Roma,
espresse le proprie rimostranze nei confronti di Carlo il Calvo, dei
partecipanti al concilio e dello stesso Incmaro, per il trattamento scorretto
che gli era stato riservato. Infatti Egilone aveva recapitato al papa solo una
lettera sinodale, invece degli atti propriamente detti; la reintegrazione di
Vulfado e la sua immediata elezione erano state troppo rapide, non concertate e
dipendevano da un fatto compiuto, come se si fosse giudicato inutile che il
papa perdesse il suo tempo a dimostrare ciò che tutti si aspettavano; al
contrario, N. si applicò minuziosamente a rilevare tutti gli errori della
procedura seguita nell'863 (epp. 78-81; anche in Regesta Pontificum Romanorum,
nrr. 2822-25). Nella lettera indirizzata ad Incmaro, particolarmente severa, si
rimproverava all'arcivescovo d'aver manipolato la vicenda: si era degnato di
inviare al papa un'unica missiva non autenticata dal suo sigillo e aveva
abusato dei diritti conferitigli dal pallium. Egilone, rientrato da Roma,
trasmise le lettere a Carlo il Calvo (che lo ricevette a Samoussy il 20 maggio
867) e ad Incmaro (v. la risposta di quest'ultimo alle accuse di N., in M.G.H.,
Epistolae, VIII, 1, a cura di E. Perels, 1939, nrr. 198-99). Su richiesta di
N., Carlo il Calvo convocò un nuovo sinodo a Troyes in autunno (Die Konzilien,
IV, nr. 24). Il dibattito in merito al contegno di Incmaro fu burrascoso.
Questi riuscì alla fine a guadagnarsi il favore dell'assemblea, ma a Roma
furono inviate due lettere contrastanti, la prima di Carlo, molto prevenuta -
sem-bra - nei confronti di Incmaro, la seconda del concilio che ne prendeva le
difese. Uno degli ultimi atti di N., se si presta fede a quanto dichiara lo
stesso Incmaro negli Annales Bertiniani (p. 138), fu quello di esprimere il suo
appoggio all'arcivescovo di Reims, il quale gli aveva "dato soddisfazione
su tutti i punti". La posizione di N. consisteva nel proporsi come
un'istanza cui far riferimento in permanenza. Tale atteggiamento fu esteso anche
al clero regolare, non tanto per contrastare le ingerenze episcopali quanto per
fare da contrappeso ai doveri derivanti dalla protezione reale e alle pressioni
dell'aristocrazia. Uno degli scopi della missione di Oddone di Beauvais a Roma
nell'aprile 863 fu quello di ottenere le conferme per numerosi monasteri del
Regno franco occidentale. Oddone era stato abate di Corbie prima di occupare la
sede di Beauvais nell'861. Aveva già chiesto a Benedetto III, nell'855, un
importante privilegio di conferma dei beni del monastero - dedicato, è
opportuno ricordarlo, ai ss. Pietro e Paolo - e della libertà dell'elezione
abbaziale, che si sommava ai diplomi reali consueti. Il privilegio di N.
rinnovò questa conferma rafforzando i punti relativi all'autorità pontificia,
soprattutto in materia di appello, e aggiungendo esplicitamente il sovrano fra
le potenze contro cui poteva essere esercitata la protezione romana, sulla base
della formulazione dei privilegi concessi da Gregorio Magno alla Chiesa di
Autun (Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2717). Il monastero di St-Denis
beneficiò di un testo equivalente (ibid., nr. 2718), mentre quello di St-Calais
ebbe confermata l'indipendenza nei confronti del vescovato di Le Mans, già
pronunciata da un concilio nell'855 (v. oltre per i dettagli della disputa tra
St-Calais e Le Mans). Alla stessa data, ma ora per rispondere ad una
sollecitazione del conte Gherardo di Vienne, fu accordato un privilegio anche
ai monasteri di Vézelay e di Pothières (ibid., nrr. 2830-31; il nr. 2831, per
Pothières, è perduto). Gherardo e sua moglie Berta avevano fondato Vézelay e
Pothières, nel Regno di Carlo il Calvo, nell'858-859, e li avevano affidati con
i beni a S. Pietro, dopo essersi impegnati a versare un censo annuale,
rimettendoli alla protezione sia di Roma che di Carlo il Calvo. Ma alla morte
di Carlo di Provenza, al principio dell'863, Gherardo si schierò dalla parte di
Lotario II. Fece giungere a Roma una lettera destinata a N., al clero e al
popolo della città, ove riaffermava la donazione alla Santa Sede con l'intento
di ottenerne protezione. Il papa gliela accordò, con la stessa clausola
restrittiva "antireale" prevista per Corbie e St-Denis, che in questo
caso appariva ancora più esplicita. Vézelay e Pothières segnarono una tappa
nella concezione di protezione pontificia, che sarà ripresa e sviluppata sotto
Giovanni VIII e in seguito nell'XI secolo. Tuttavia Roma reagiva in modo ancora
passivo alle sollecitazioni esterne: nulla, in questi anni, fa pensare che N.
vedesse nei privilegi lo strumento di una politica contro la Chiesa
"imperiale"; del resto, i testi in favore di Corbie e di St-Calais
erano solo conferme di ratifiche già pronunciate nei sinodi locali. Il
pontificato di Benedetto III si era concluso senza che si potesse trovare una
soluzione alla disputa che opponeva il conte (forse di Milano) Bosone alla
moglie Engeltruda, figlia del conte Matfridus di Orléans, il quale si era
stabilito in Italia al seguito di Lotario I nell'834. Nell'857 Engeltruda era
fuggita dalla residenza coniugale con uno dei vassalli del marito, Wangerus,
per rifugiarsi sull'altro versante delle Alpi. Bosone si appellò a Benedetto
III, il quale, nell'858, ingiunse ai cinque sovrani carolingi e ai loro vescovi
di costringere la donna a tornare dallo sposo legittimo (ibid., nr. 2673, cfr.
epp. 29, 53). Nell'859, applicando questa circolare e su interpellatio di N.,
si tenne un sinodo a Savonnières (presso Toul), in cui la questione fu
semplicemente messa all'ordine del giorno, senza prendere in considerazione una
sanzione canonica, a causa dell'assenza di Engeltruda (Incmaro, De divortio
Lotharii, pp. 105, 226 s.), che all'epoca si divideva tra il Regno franco
occidentale e la corte di Lotario II (re della regione che da lui avrebbe preso
il nome di Lotaringia), con cui era imparentata. È certo che nello stesso anno
N. inviò una lettera (ancora perduta) a Incmaro e, per suo tramite, all'insieme
dei vescovi del Regno franco occidentale perché inducessero Engeltruda a
tornare dal marito. Alla fine, a una data che rimane imprecisa, l'arcivescovo
di Milano, provincia ecclesiastica da cui dipendevano i coniugi, e i suoi
suffraganei domandarono al papa (epp. 18 e 53; anche in Regesta Pontificum
Romanorum, nrr. 2750, 2886) di pronunciare l'anatema contro Engeltruda, richiesta
che venne accolta. Da parte sua, Bosone approfittò della partecipazione alla
riunione di Coblenza fra Carlo il Calvo, Ludovico il Germanico e Lotario II,
nel giugno 860, per reclamare la moglie; il 22 ottobre 860 intraprese un altro
passo al concilio di Tusey, latore di lettere del pontefice, la prima
indirizzata ad Incmaro (che nell'occasione redasse il De uxore Bosonis, per
rispondere a una domanda dell'arcivescovo di Colonia), in cui N. rinnovava la
precedente richiesta, pena la scomunica per Engeltruda, la seconda destinata a
Carlo il Calvo, perché diffidasse suo nipote dall'offrire rifugio alla moglie
recalcitrante: se essa fosse rientrata nel Regno franco occidentale, la si
doveva riconsegnare a Bosone (epp. 1-2; anche in Regesta Pontificum Romanorum,
nrr. 2684-85; Die Konzilien, IV, p. 13). Nel frattempo erano giunte a Roma le
prime informazioni relative alle manovre di Lotario II in vista del suo
divorzio da Teutberga, sorella di Bosone. Salendo al potere nel settembre 855,
Lotario aveva lasciato la sua concubina Gualdrada per sposare Teutberga secondo
le regole (che prescrivevano la dote e il consenso dell'aristocrazia). Il
matrimonio aveva procurato al re soprattutto l'alleanza del fratello maggiore
di Teutberga, Uberto, abate di St-Maurice-en-Valais, che deteneva il controllo
su una regione d'importanza vitale per le relazioni con l'Italia. Alla fine
dell'estate 856, l'incontro di Orbe tra Ludovico II, Carlo di Provenza e
Lotario II regolò le trattative relative all'eredità di Lotario I, grazie alla
mediazione di Benedetto III; l'accordo, pur ancora precario, rendeva ormai
superfluo il ruolo dei Bosonidi. In questo periodo Uberto, da parte sua, si
rese indipendente e cominciò ad estendere la sua influenza territoriale sulle
terre di confine sotto il suo controllo, a discapito sia di Lotario che di
Ludovico II e Carlo il Calvo. Nell'857 una lettera di Benedetto III al clero
del Regno franco occidentale accusava l'abate di aver compromesso in tal modo
la pace fra i tre fratelli (M.G.H., Epistolae, V; anche in Regesta Pontificum
Romanorum, nr. 2669). Nell'857 Lotario II fece i primi passi per separarsi da
Teutberga e riunirsi a Gualdrada, dalla quale aveva già avuto un figlio, e
contemporaneamente diede inizio alle operazioni militari contro il cognato. Da
questo momento, le fonti pongono decisamente in secondo piano il caso
Bosone-Engeltruda, malgrado che, per la parentela che univa Bosone a Teutberga
e Lotario a Engeltruda (dal lato paterno), per la protezione accordata dal re
alla fuggitiva e per la loro particolare natura, le due questioni siano state
trattate congiuntamente, nelle stesse riunioni e dalle stesse autorità.
Nell'858 Teutberga dovette (vittoriosamente) sottomettersi ad un'ordalia per
discolparsi da un'accusa di incesto con Uberto, resa ancor più grave da un
aborto (in seguito si aggiunse la sodomia). Due sinodi furono poi riuniti ad
Aquisgrana per esaminarla, uno composto di soli ecclesiastici, il 9 gennaio
860, l'altro nel quadro di un'assemblea del Regno, nel mese di febbraio (Die Konzilien,
IV, nrr. 1-2). Teutberga ammise e confessò per iscritto la sua colpa, e fu in
un primo tempo autorizzata a ritirarsi in un monastero per farvi penitenza. Poi
una seconda riunione la condannò ad una penitenza pubblica. Tuttavia, verso la
fine dell'anno, la donna fuggì per trovare rifugio presso Uberto, nel Regno
franco occidentale. La nuova unione di Lotario II fu comunque autorizzata solo
da un terzo sinodo, il 29 aprile 862, e poi benedetta dall'arcivescovo di
Colonia Tilgaldo, che incoronò regina Gualdrada a Natale. Fin dopo le prime
accuse, tra la primavera 858 e i primi giorni dell'860, Teutberga aveva inviato
un appello a Roma, in cui si difendeva dai crimini di cui era incolpata e
denunciava le pressioni adoperate per farla confessare. Malgrado l'appello
reiterato una prima e una seconda volta (ep. 11; anche in Regesta Pontificum
Romanorum, nr. 2726), in un primo tempo non ottenne risposta. Gli atti dei
concili dell'860 e 862 furono portati a Roma separatamente; da parte sua,
Lotario, in data imprecisata, aveva consultato N. a tale proposito (Le Liber
pontificalis, p. 159), ma non si era aspettata la risposta per procedere alle
nuove nozze. N. reagì solo dopo la pubblicizzazione della vicenda nel De
divortio Lotharii di Incmaro (pubblicato in due tempi, in marzo-maggio e poi in
settembre-ottobre 860, vi si auspicava la convocazione di un concilio generale
del mondo franco per dirimere la questione) e dopo che l'episcopato lorenese si
era scisso sul tema dell'indissolubilità. Con una serie di lettere datate a
partire dal 23 novembre 862 (epp. 3-6; anche in Regesta Pontificum Romanorum,
nrr. 2698-702), N. confermava un precedente corriere (perduto) in cui rimetteva
la decisione riguardo all'intera vicenda a un concilio convocato a Metz, ma
presieduto dai vescovi Radoaldo di Porto e Giovanni di Ficocle - l'epistola 3,
rivolta "ai vescovi e arcivescovi presenti al concilio", è un
messaggio destinato ad essere letto da questi ultimi ai convenuti in apertura
dei lavori. Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, in nome dei quali erano
stati già tenuti i due sinodi dell'860, questa volta sarebbero stati
rappresentati da due vescovi per uno, al pari di Carlo di Provenza. Gli atti
del concilio dovevano essere trasmessi a Roma, ove si sarebbe giudicata in ultima
istanza la justitia delle decisioni prese. Le lettere di N. giunsero ai
destinatari solo successivamente al matrimonio celebrato nel Natale 862. Il
papa, messo di fronte al fatto compiuto, comunicò al clero dei Regni franco
occidentale e franco orientale che il comportamento di Lotario era
"illecito" e "scellerato". I vescovi dovevano vigilare
perché questi si presentasse davanti al concilio per esservi giudicato e
condannato ad una penitenza, sotto pena di scomunica (ep. 10; anche in Regesta
Pontificum Romanorum, nr. 2725, in cui per la prima volta emerge l'ostilità
dichiarata del papa). I legati, da parte loro, erano destinatari di un
commonitorium da leggere di fronte all'assemblea. Da un messaggio di apertura
sereno si passava quindi ad un attacco in piena regola contro la violazione
delle direttive pontificie da parte di Lotario. Alla fine il concilio si aprì
nel giugno 863 (Die Konzilien, IV, nr. 14), davanti ai legati ma con un
uditorio esclusivamente "lorenese", e in assenza di Teutberga.
L'argomentazione di Lotario si era arricchita di una perorazione di carattere
più giuridico, in difesa dell'idea che l'unione con Gualdrada possedesse già
tutte le garanzie della legittimità, in particolare in materia di pubblicità e
di dote. Egli dichiarava di aver sposato Teutberga in seguito alle pressioni
minacciose del fratello Uberto, responsabile quindi di un adulterio forzato, e
in un momento in cui subiva gli attacchi militari congiunti delle truppe di
Lotario e Ludovico II. Il precedente giudizio venne confermato, mentre
s'annullò la sentenza emessa contro Engeltruda. Come N. aveva chiesto, gli atti
del concilio furono portati a Roma, e gli arcivescovi Guntero di Colonia e
Tilgaldo di Treviri accompagnarono personalmente i legati. Dopo un esame del
libellum conciliare, la sentenza fu diffusa il 30 ottobre nel quadro di un
sinodo convocato qualche tempo prima per trattare "argomenti diversi"
(v. la lettera di invito al patriarca di Grado, ep. 17; anche in Regesta
Pontificum Romanorum, nr. 2747), ma il cui ordine del giorno fu occupato quasi
per intero dal dibattito sulla vicenda di Lotario (Die Konzilien, IV, nr. 16).
Gli atti di Metz furono cassati come prostibulum adulteris, Guntero e Tilgaldo
vennero deposti e scomunicati (cfr. M.G.H., Epistolae, VI, 1, p. 218) come pure
il vescovo di Bergamo, Aganone, presente a Metz in rappresentanza di Ludovico
II, che sembra aver avuto un ruolo attivo nei dibattiti (Le Liber pontificalis,
p. 160): il provvedimento non fu causato dalla loro compiacenza nei confronti
di Lotario, ma per aver ignorato la condanna papale contro Engeltruda.
Nuovamente anatemizzata, questa venne invitata una volta di più a ricongiugersi
al marito o a recarsi a Roma per ottenere il perdono. Anche gli altri
partecipanti al concilio dovevano presentarsi a Roma per sottomettersi, o
inviare loro rappresentanti presso il papa. L'ultimo decreto lanciava il
generalizzato anatema su chi avesse osato contrastare qualsiasi decisione
("dogmata, mandata, interdicta, sanctiones vel decreta") romana. Gli
atti del sinodo furono comunicati in lettere separate ad Adone di Vienne, ai
cleri dei Regni franco occidentale e franco orientale, e alla gerarchia
"di Gallia, Italia e Germania" (epp. 18-21; e in Regesta Pontificum
Romanorum, nrr. 2748-52). Guntero e Tilgaldo sulla via del ritorno ottennero
l'appoggio di Ludovico II, che comparve insieme a loro sotto le mura di Roma,
accompagnato da Engelberga, nel gennaio 864 (J.F. Böhmer, nr. 215). Secondo gli
Annales Bertiniani, la fonte più esauriente sull'episodio, il papa, avvertito
dell'arrivo di truppe imperiali, avrebbe ordinato un giorno di digiuno e di
litanie; la soldatesca disperse una processione e distrusse delle insegne
religiose, fra cui una croce che racchiudeva frammenti della vera croce offerti
da Elena a s. Pietro. In questa basilica si ritirò N., abbandonato il Laterano,
e qui restò due giorni digiunando, mentre Ludovico II era immobilizzato dalla
febbre. La crisi fu risolta grazie all'intervento di Engelberga, che portò al
pontefice un salvacondotto; dopo l'incontro, N. rientrò in Laterano, mentre
l'imperatore, non avendo ottenuto che il papa tornasse sulla sua decisione,
rimandò i due prelati nelle rispettive diocesi. Entrambi, in un primo tempo,
non recedettero dalle loro posizioni: Guntero inviò a Roma, tramite il fratello
Ilduino, una lettera che fece circolare anche in tutte le diocesi del Regno di
Lotario, in cui protestava per l'attentato perpetrato contro i loro diritti.
Erano stati costretti ad attendere, senza ricevere alcuna comunicazione, nel
lasso di tempo intercorso tra la consegna degli atti di Metz e l'apertura della
cospirazione romana "more latrocinali facta", alla quale negavano il
carattere di sinodo; nulla era stato esaminato in modo approfondito e non
avevano avuto alcuna possibilità di organizzare una difesa. Di fronte a questo
disprezzo di ogni regola canonica, dichiaravano N., "qui dicitur
papa", escluso dalla loro comunione, ossia da quella dell'intera Chiesa, e
riaffermavano la validità del matrimonio fra Lotario e Gualdrada, "uxor
profecto, non concubina". Ilduino si era impegnato a deporre il manifesto
sulla tomba di s. Pietro, se il papa avesse rifiutato di riceverlo; e questo
accadde, verso la fine di febbraio, ancora una volta con l'appoggio dei soldati
di Ludovico II, e a prezzo di uno scontro che costò la vita ad una guardia
della basilica. Guntero, il più agguerrito nella battaglia contro il papa, fu
comunque isolato rapidamente. Mentre Tilgaldo rispettò l'interdetto pontificio
e gli altri vescovi, invitati alla "resistenza", fecero in
successione onorevole ammenda per aver partecipato al "concilium
vanitatis" (cfr. epp. 30-1; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nrr.
2767-68: perdono di N. al vescovo di Tongres e ad Adventius di Metz; v. anche
le numerose lettere di Adventius, che, sebbene fautore del divorzio, aveva
raccomandato prudenza a Tilgaldo prima dell'assemblea dell'863, e si preoccupò
di dissociarsi dalle sue conclusioni, chiedendo anche un intervento di Carlo il
Calvo in suo favore presso il pontefice, il quale alla fine gli concesse il
perdono ufficiale nell'865, in M.G.H., Epistolae, VI, 1, pp. 214 ss., 219-24),
l'arcivescovo di Colonia celebrò la messa nella sua cattedrale il venerdì santo
dell'864. Il gesto gli costò la deposizione, questa volta su iniziativa dello stesso
Lotario, che non aveva alcun interesse ad inasprire una situazione così
delicata. Il papa tornò rapidamente al nocciolo del problema, non foss'altro
che per respingere le accuse di condotta anticanonica, alle quali l'imperatore
sembrava incline a prestare attenzione (ep. 29; anche in Regesta Pontificum
Romanorum, nr. 2764). Convocò un nuovo sinodo a Roma per la fine di ottobre,
perché fossero ascoltate le sue spiegazioni, per confermare la deposizione
degli arcivescovi e, marginalmente, richiamare il caso del patriarca Ignazio
(lettera all'arcivescovo di Bourges, ibid.; Annales Bertiniani, p. 115; a
proposito di Ignazio, v. supra). Guntero e Tilgaldo si presentarono, ma pare
che la riunione non abbia avuto luogo e quindi l'arcivescovo di Colonia non ottenne
il perdono che aveva cercato. N. pensò in seguito di convocare un sinodo
generale a Roma per la metà di maggio dell'865 (cfr. M.G.H., Epistolae, VI, 1,
p. 224, epistola di Adventius a N. e l'epistola 32 di N. ad Adone di Vienne),
ma il progetto naufragò sia a causa della tensione politica fra Carlo il Calvo,
Ludovico il Germanico e Ludovico II, e dell'emergenza militare sulle coste
atlantiche per le incursioni normanne che ostacolavano i contatti fra un Regno
e l'altro, sia per il clima diffuso di resistenza passiva alle decisioni papali
(cfr. epp. 33-4, 38; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nrr. 2773-74,
2788). Ludovico II, da parte sua, fece un ultimo tentativo in favore di Guntero
e Tilgaldo in occasione di un conventus riunito a Pavia il 18 febbraio 865,
dove comparve Guntero, di ritorno da Roma (Die Konzilien, IV, nr. 21); gli
arcivescovi di Milano, Arles e Embrun redassero a nome loro e degli altri
prelati partecipanti una richiesta di clemenza che fu inviata al papa, e ad
Incmaro, cui era allegato un breve testo di Guntero sul tema del perdono. Nel
giugno 865, prendendo atto con una certa amarezza dei molti ostacoli che si
frapponevano ai suoi progetti, N. decise finalmente di dare incarico ad un
legato di risolvere l'insieme dei problemi in sospeso. La missione, preparata
con grande cura tramite molteplici raccomandazioni a tutte le parti
interessate, fu assegnata ad Arsenio di Orte (epp. 33-5, 37-9; anche in Regesta
Pontificum Romanorum, nrr. 2773-74, 2776, 2778, 2788, 2790). Arsenio, che assommava
in sé le funzioni di apocrisario, "missus" della Sede apostolica e
"consiliarius" personale del papa, doveva mettere fine al duplice
adulterio di Lotario ("pro abolenda copula", secondo l'espressione
del Liber pontificalis) e di Engeltruda, ma anche reclamare le imposte e le
decime dovute a Roma dalle Chiese del Regno franco orientale, vigilare sulla
reintegrazione di Rotado di Soissons (v. supra), far riconciliare Carlo il
Calvo, Lotario, Ludovico il Germanico e Ludovico II (Annales Fuldenses, pp. 63
s.) e, per finire, portare la risposta di N. ad una consultazione
dell'arcivescovo di Besançon su questioni di disciplina matrimoniale legate
agli interdetti di parentela e di legislazione ecclesiastica (ep. 123; anche in
Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2787). Lotario, aspramente redarguito per
aver corrotto i legati presenti a Metz, veniva risolutamente invitato a
ravvedersi prima del rientro a Roma dell'apocrisario, perché N. aveva rinviato
la scomunica solo per l'affetto che nutriva per il fratello Ludovico II (epp.
36-7; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nrr. 2777-78). Gli Annales
Bertiniani raccontano come Arsenio, dopo aver consegnato le lettere papali, fra
giugno e luglio 865, a Ludovico il Germanico (a Francoforte), Lotario II (a
Gondreville) e Carlo il Calvo (a Attigny), tornò da Lotario a Douzy, in
compagnia di Teutberga, mentre Gualdrada rientrava dall'Italia - dove la sua
sicurezza sembrava più garantita che nelle vicinanze degli zii di Lotario. Il 3
agosto, davanti a molti vescovi, fra cui Adone di Vienne, dodici uomini si
fecero garanti sotto giuramento non solo del fatto che Lotario avrebbe ripreso
al suo fianco Teutberga, ma che l'avrebbe trattata come una moglie: la donna fu
quindi riconsegnata al marito. Questo successo fu palesemente favorito dal
desiderio di Lotario, espresso già un anno prima, di conseguire i suoi scopi
evitando scontri frontali con il papa, sebbene la morte di Uberto, caduto
combattendo contro le truppe di Ludovico II l'anno precedente, avesse rimosso
un ostacolo dalla sua strada (J.F. Böhmer, nr. 228). La buona volontà del re si
misura, da un lato, dal suo auspicio, manifestato già all'inizio dell'865, di
potersi recare a Roma per perorare personalmente la propria causa (su richiesta
di N. Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico lo dissuasero, intimandogli di
risolvere il suo problema matrimoniale prima di progettare qualsiasi
spostamento: ep. 38; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2788),
dall'altro, dalla presenza e dalla sottomissione di Engeltruda, qualche giorno
più tardi, a Gondreville, dove Arsenio celebrò la messa dell'Assunzione (15
agosto) davanti alla coppia reale ricostituita. Nondimeno, Lotario non aveva
fatto a sua volta atto di pentimento ("nulla ecclesiastica satisfactione
pro adulterio publico ab eo secundum canones sacros parata"), un dettaglio
che influirà sul seguito degli eventi. Era previsto che Gualdrada ed Engeltruda
accompagnassero il legato a Roma, al suo rientro dal viaggio in Alemannia e
Baviera per riscuotere quanto era dovuto a S. Pietro. Tuttavia, entrambe lo
piantarono in asso - con la complicità passiva di Arsenio, al quale bastava
aver negoziato il ripudio di Gualdrada? -, la prima per riunirsi a Lotario, la
seconda per raggiungere di nuovo la regione di Colonia, dove si era stabilita
con Wangerus. Le due donne furono colpite da sanzione: N. ricordò il pericolo
di comunicare con Engeltruda "saepe damnata" e, il 2 febbraio 866,
scomunicò Gualdrada, assicurando alla sua condanna una vasta diffusione (epp.
41-2; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nrr. 2800, 2808; Reginonis abbatis
Prumiensis, pp. 87 ss.; resoconto di Arsenio su Engeltruda, in M.G.H.,
Epistolae, VI, 1, pp. 225 s.). Il resto dell'anno fu segnato da un nuovo
tentativo, da parte di Lotario, di uscire dall'impasse, questa volta con
l'appoggio di Carlo il Calvo, al quale si era riavvicinato. Il 17 gennaio
Teutberga, "dilectissima", beneficiò di un diploma che le cedeva beni
in almeno otto contee e le assegnava delle proprietà confiscate a suo fratello
Uberto (Die Urkunden Lothars I. und Lothars II., in M.G.H., Diplomata
Karolinorum, III, a cura di Th. Schieffer, 1966, p. 429). L'atto non comportava
la legittimazione dell'unione, perché nella formulazione si evitava
accuratamente di far seguire all'aggettivo "dilectissima" un
sostantivo che precisasse la sua condizione. Ma sarà interpretato come una
contropartita all'accettazione, da parte di Teutberga, di una separazione
"in via amichevole", poiché, alla fine dell'anno o nei primi giorni
dell'867, N. ricevette una lettera in cui, questa volta, era lei a domandare
l'annullamento del matrimonio con Lotario e sceglieva "sponte ac
libenter" di rinunciare alla dignità regale. All'argomento della
legittimità dell'unione fra Gualdrada e Lotario, già trattato nel concilio di
Metz, si aggiungeva per la prima volta quello della propria sterilità. Si
poteva leggere fra le righe come Teutberga, ritirandosi di fronte a Gualdrada
che aveva saputo dare un figlio al re, assicurasse la sopravvivenza del Regno.
N. non si fece raggirare neppure per un istante da quella che giudicò una
grossolana menzogna. Rispondendole, il 24 gennaio 867, si meravigliò di questo
repentino voltafaccia, mentre tutte le testimonianze concordavano
nell'affermare che ella era costantemente sottoposta a pressioni; la sterilità
non dipendeva affatto da Teutberga, quanto piuttosto era il risultato
dell'"iniquità" del marito, la cui condotta impediva che l'unione
desse i suoi frutti; quanto al viaggio a Roma, dove la donna progettava di
recarsi per confessare al papa i segreti di cui pareva ancora intenzionata a
incolparsi, non era neppure in questione, poiché Gualdrada era stata convocata
prima di lei ed allontanarsi dalla corte equivaleva a cedere di fronte
all'adultera; per finire, uno scioglimento delle nozze per ragioni di pudicitia
era impensabile: la rinuncia a qualsiasi commercio carnale, di per sé nobile,
in questo caso doveva essere condivisa dallo sposo (ep. 45; anche in Regesta
Pontificum Romanorum, nr. 2870). Nello stesso giorno furono redatte alcune lettere
di "accompagnamento": a Lotario, per comunicargli negli stessi
termini di non riporre speranze in una soluzione della vicenda con il ricorso
all'ennesima manovra, da cui il papa non intendeva farsi abbindolare, e
specificare che neppure la scomparsa di Teutberga avrebbe potuto ricomporre la
questione (ep. 46; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2873); al clero
del suo Regno, per ricordare che Gualdrada era colpita da scomunica e domandare
che diffondesse con zelo la notizia della sanzione e dei suoi effetti, e
l'informasse sulla condotta di Lotario verso Teutberga, nei confronti della
quale si era impegnato di fronte ad Arsenio (ep. 47; anche in Regesta
Pontificum Romanorum, nr. 2871). Una copia della lettera fu inviata a Carlo il
Calvo, perché la diffondesse nel Regno franco occidentale, e per suo tramite
anche a Lotario, per avvertirlo che al papa erano giunte voci di un tentativo
di alleanza contro Teutberga e soprattutto del progetto, da parte di Lotario,
di liberarsi della moglie appena reintegrata nel focolare coniugale sulla base
di un'accusa di adulterio presentata di fronte ad un tribunale secolare, come
era accaduto per quella di incesto nell'858, provocando così un duello
giudiziario - per campione interposto - che si supponeva vinto in anticipo, con
la conseguente possibilità di mettere a morte la colpevole (ep. 48; anche in
Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2872: il ricorso al duello come soluzione
liberatoria dall'accusa di adulterio era la norma; secondo la lettera,
Teutberga l'aveva già proposto all'epoca dell'ambasceria di Arsenio nell'865,
ma questi avrebbe rifiutato, come N. dopo di lui). Infine, il 7 marzo, il papa
chiese a Ludovico il Germanico di intervenire presso il nipote in favore di
Teutberga e contro Gualdrada, mentre tornava sul caso di Engeltruda applicando
lo stesso ragionamento esposto per la moglie di Lotario: anche rinunciando a
lei, come avrebbe voluto fare la regina Teutberga, Bosone non poteva
assolutamente contrarre un secondo matrimonio, su cui non aveva facoltà di decisione;
Ludovico era invitato a costringerla a ravvedersi, per porre fine ad una
situazione che rendeva adultero, suo malgrado, lo stesso Bosone (ep. 49; anche
in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2874). I prelati "lorenesi"
sembrano aver avuto notizia solo in ritardo del corriere di Niccolò. Adventius
di Metz afferma di averlo ricevuto nel giugno 867. Leale nei confronti del suo
sovrano e senza arrischiarsi ad indicare chi, tra i vescovi, fosse sostenitore
o avversario dichiarato dell'adultero, si adoperò per rassicurare il papa,
garantendogli che Lotario non aveva più alcun contatto con Gualdrada fin
dall'epoca dell'ambasceria di Arsenio e mostrava, al contrario, tutti i segni
del comportamento degno di un coniuge: "ut relatio innuit, coniugalis habitus
debitum solvere hilariter praetendit" (in M.G.H., Epistolae, VI, 1, p.
235). Lotario, da parte sua, progettava ancora di recarsi a Roma. Mentre
disponeva perché in sua assenza il Regno fosse affidato a Ludovico il Germanico
(incontro di Francoforte), il caso di Guntero e Tilgaldo creò ulteriore
tensione con Roma. Come si è visto, Lotario aveva deposto Guntero dopo che
questi, malgrado la scomunica, aveva celebrato la messa a Colonia il venerdì
santo dell'864. Ora, N. aveva preteso che la scelta dei nuovi prelati per le
sedi di Treviri e Colonia fosse preliminarmente sottoposta all'approvazione di
Roma (ep. 23; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2753). Pur inviando al
papa un messaggio conciliante (in M.G.H., Epistolae, VI, 1, pp. 217 ss.),
Lotario, in un primo tempo, sostituì Guntero con Ugo; poi, in seguito alle
pressioni di Ludovico II, senza dubbio come ultima compensazione dopo
l'assemblea di Pavia, del febbraio 865, assegnò la diocesi a Ilduino, fratello
di Guntero, lasciando tuttavia a quest'ultimo la responsabilità del temporale.
Ma nell'autunno 867 N. comunicò che reputava gli errori di Guntero e Tilgaldo
troppo gravi per poterli reintegrare. Il 7 ottobre chiese a Lotario di porre
fine ad una vacanza disdicevole e di riunire il clero di Colonia e di Treviri
per un'elezione canonica, in base alla quale Roma avrebbe potuto conferire il
pallium. Il 30 di quello stesso mese tre lettere esortavano Ludovico il
Germanico a sospendere i suoi interventi in favore degli arcivescovi deposti e
a comunicare a Lotario che qualsiasi viaggio a Roma era subordinato non solo
all'esigenza, già formulata, di una venuta di Gualdrada alla Santa Sede e del
riconoscimento di Teutberga come regina, ma anche ad un'elezione canonica a
Colonia e a Treviri, che non doveva essere influenzata né da Guntero e
Tilgaldo, né da Gualdrada (epp. 50-3; anche in Regesta Pontificum Romanorum,
nrr. 2878, 2884-86; l'epistola 53 offre un resoconto completo di tutta la
vicenda, a partire dagli interventi di Benedetto III contro Engeltruda nell'858).
Il papa dovette prendere posizione anche a proposito di altre questioni
matrimoniali coinvolgenti l'aristocrazia del Regno franco occidentale, che si
tende qui a trascurare per via della massa di documentazione relativa al caso
di Lotario II, ma che agli occhi del papato non rivestirono minor importanza.
Le prime lettere di N. sul divorzio di Lotario II, nel novembre 862, contengono
anche due richieste di clemenza rivolte a Carlo il Calvo. La prima in favore di
Baldovino, conte di Fiandra e vassallo del re, che aveva rapito la figlia di
Carlo, Giuditta (vedova del re del Wessex dall'860, era tornata dal padre che
la teneva sub custodia, in attesa di trovarle un partito all'altezza della
politica matrimoniale praticata dal Regno), l'aveva sposata con il suo accordo
e quello del fratello Luigi il Balbo - allora ribelle contro Carlo -, ma senza
il consenso paterno, una decisione che li aveva esposti alla scomunica:
Baldovino a causa del rapimento e Giuditta per la sua complicità, aggravata
dalla vedovanza. I due avevano trovato rifugio presso Lotario II, poi Baldovino
si era recato a Roma per chiedere a N. di intercedere in suo favore (epp. 7-8;
anche in Regesta Pontificum Romanorum, nrr. 2703-04; l'epistola 8 rivolge la
richiesta all'imperatrice Ermentruda in termini più precisi sul piano
giuridico: vi è stato rapimento, poi atto di pentimento presso la Santa Sede).
Il caso venne evocato di nuovo a due riprese nell'863 (ep. 57; anche in Regesta
Pontificum Romanorum, nr. 2723; epp. 60, 78; anche in Regesta Pontificum
Romanorum, nrr. 2722-23); quello stesso anno Incmaro, malgrado la sua ostilità
dichiarata per quest'unione, ricevette Giuditta, mentre il re, che attribuiva
maggior importanza al sostegno di N. contro Lotario II, concedeva il perdono e
accettava di prendere come genero Baldovino (v. i ringraziamenti rivolti dal
papa a Carlo il Calvo, ep. 78; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr.
2784). Un conflitto analogo suscitò l'altra iniziativa (ep. 9; anche in Regesta
Pontificum Romanorum, nr. 2705) in favore del figlio di Carlo il Calvo, il re
di Aquitania Carlo il Giovane, che nell'862, appena quindicenne, aveva sposato
la vedova di Umberto, conte (forse) di Nevers, senza il consenso del padre ma
con l'incoraggiamento del conte Stefano, successore di Umberto, per il quale
l'alleanza matrimoniale con il re d'Aquitania aveva un valore inestimabile.
Carlo fece atto di sottomissione al padre, ma il matrimonio non fu sciolto. I
due interventi erano riconducibili ad un unico principio: quello della priorità
del consenso degli sposi, che fu riaffermata sul piano teorico nella lettera ai
Bulgari dell'866. L'azione di N. come vescovo di Roma e difensore della città,
preoccupato delle condizioni della sua popolazione, è trattata in modo conciso
nel Liber pontificalis, dove le menzioni relative a donazioni alle chiese, a
riparazioni e a fondazioni sono state forse condensate allorché la notizia fu
rimaneggiata (sono del resto troncate accidentalmente per le donazioni che
corrispondono all'indizione XI, settembre 862-agosto 863 [Le Liber
pontificalis, p. 159] - riferendosi alla cronologia stabilita da R. Davis sul
modello di quella ricostruita da H. Geertman per i precedenti pontificati). La
lista delle chiese e dei monasteri beneficiari di oggetti liturgici e di
tessuti preziosi include quanto dipende dalla generosità pontificia, in parte
alimentata dai doni dei diversi sovrani e pellegrini del mondo cristiano
(Ludovico II, in occasione dell'elezione e nell'862-863, Michele III nell'860
[si nota in quest'occasione la presenza di repida, termine sul quale si sono
arenati curatori e traduttori del Liber pontificalis, che è una trascrizione
latina di ριπίδια: ventagli liturgici a forma e con piume di pavone],
pellegrini inglesi nell'863-864, il re di Danimarca e Ermentruda nell'864 [epp.
27-8; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nrr. 2761, 2763], Boris-Michele
nell'866): S. Pietro in testa (una donazione quasi per ogni anno di
pontificato), S. Paolo (860-861, 861-862, 866-867), il Laterano (858, 865-866,
866-867) e S. Lorenzo fuori le Mura (858, 866-867), S. Anastasio ad Aquas
Salvias (861-862), S. Maria ad Praesepe (866-867); vi figura anche S. Maria
Antiqua, la recente fondazione di Leone IV (861-862). Più inattese sono le
menzioni dei tituli di S. Eusebio (860-861 e 861-862, citato per la prima volta
da Gregorio IV), come pure il monastero di S. Valentino, nella diocesi di Narni
(860-861), che non era stato più onorato dopo Zaccaria. N. sembra comunque aver
accordato una particolare attenzione alle comunità monastiche greche; forse vi
si può scorgere l'indizio di una forte immigrazione proveniente da Bisanzio,
che lo stesso papa ricordò a Michele III nella lettera del settembre 865 e che
fu rilanciata dallo scisma foziano. Se i doni a S. Anastasio ad Aquas Salvias erano
consueti, quelli a S. Dionigi di Roma (858-859), la chiesa che si erigeva
all'interno della cinta del monastero dei SS. Stefano e Silvestro, fondazione
di Pasquale I, lo sono assai meno - si potrebbero interpretare come una
manifestazione di riconoscenza per aver ospitato l'assemblea che lo aveva
eletto al soglio pontificio. Senza dubbio più significativa è la frequenza
delle volte in cui ricorre S. Maria in Cosmedin (858, 860-861, 861-862,
863-864), diaconia che riappare per la prima volta dopo Gregorio IV e
beneficia, oltre ai doni abituali, di importanti ristrutturazioni: rinnovo del
secretarium e del portico adiacente, costruzione dell'oratorio dedicato a s.
Nicola (una basilica a s. Nicola fu edificata anche al Laterano: Le Liber
pontificalis, p. 176) e di appartamenti (hospitium) per il pontefice. Alcuni
autori ritengono - ma senza poter addurre prove - che questa sollecitudine
denoti come N. fosse stato diacono di S. Maria in Cosmedin. Il papa fece anche
riedificare l'acquedotto dell'Aqua Jovia, che raggiungeva il Tevere in
prossimità della chiesa. Quest'ultima iniziativa si inquadra nel capitolo più
generale della gestione dell'acqua a Roma e del suo approvvigionamento,
servizio a carico del Laterano, che doveva provvedere almeno al clero, ai poveri
e ai pellegrini, se non all'intera popolazione, sulla base delle rendite
fornite dai patrimonia. In questo contesto, N. fece anche restaurare
l'acquedotto dell'Aqua Traiana (Sabbatino), che serviva la zona di S. Pietro ed
aveva già subito interventi all'epoca di Adriano I, se non di Onorio. Quanto
alle provvidenze a favore degli indigenti - il cui numero sembra essere stato
assai elevato dall'inizio dell'VIII secolo - il Liber pontificalis descrive nei
dettagli il sistema messo in opera probabilmente nell'863-864, che permise di
fare una selezione tra i beneficiari, evitando gli abusi: oltre la ventina di
centri abituali di distribuzione del grano e altre derrate (le diaconie) e
l'approvvigionamento quotidiano dei più bisognosi, si concesse ai meno disagiati,
sulla base di un registro di iscrizione, una razione settimanale, in modo che
ognuno poteva essere individuato da una "bolla" marcata col nome di
N., provvista di un numero di "nodi" diverso secondo il giorno della
settimana corrispondente alla distribuzione; bisogna immaginare, piuttosto che
una tessera annonaria, una capsula metallica appesa al collo con un cordone,
simile a quella che portavano i giovani nell'antichità. Per l'863-864 sono
segnalati inoltre interventi nei cimiteri posti fuori delle mura, a quel tempo
abbandonati: S. Felice, sulla via Portuense, e le catacombe di S. Sebastiano,
dove il pontefice ricreò una comunità monastica perché avesse cura di questi
luoghi. Infine, pur senza arrivare a distinguersi grazie a fondazioni urbane
con il suo nome, sulle orme di Gregorio IV e di Leone IV (e come farà in
seguito Giovanni VIII), N. fece ricostruire e fortificare Gregoriopolis (Ostia)
"in ruinis jacentem" - a causa dell'incursione dei Saraceni nell'865
-, insediandovi una guarnigione. I dieci anni di governo di N., nel corso dei
quali i concili dell'863 rappresentarono una svolta, furono ben presto ritenuti
decisivi per la storia del papato, nel bene e nel male. La corrente ostile, in
linea con l'indignazione esternata da Fozio, Guntero e Tilgaldo, e talvolta da
Incmaro, è allarmata dal suo autoritarismo, dalla sua "brutalità",
dalla inquietante propensione a ricondurre ogni cosa a Roma. Una manifestazione
precoce di questi sentimenti, espressi quasi a caldo, è offerta dal Libellus de
imperatoria potestate in urbe Roma (fine sec. IX-inizio sec. X), che
stigmatizza la mancanza di considerazione mostrata da N. nei confronti
dell'honor regius. Più di recente, altri hanno insistito sulla scarsa
originalità delle posizioni ecclesiologiche o disciplinari di N., che si
limitavano a riprendere la tradizione di pontefici giudicati particolarmente
importanti, come Gelasio e Leone Magno, o a ripetere formulazioni già espresse
qualche anno prima nella corrispondenza di Leone IV e Benedetto III, papi ingiustamente
offuscati, non avendo beneficiato di una notizia "storico-letteraria"
nel Liber pontificalis; oppure N. è stato dipinto come una vittima degli
eccessi epistolari di Anastasio (accusa già pronunciata da Guntero e Tilgaldo
nella loro condanna del sinodo romano dell'ottobre 863, ripresa in sostanza da
A. Lapôtre). La forza d'animo di cui diede prova il papa, viceversa, è apparsa
l'unico baluardo contro "l'invasione dei laici", nell'ottica di una
corrente che culmina nell'opera, spinta agli estremi, di J. Richterich. Una
generazione dopo la sua morte, Reginone di Prüm (nel suo Chronicon, ad a. 908)
vedeva in N. il solo pontefice che potesse sostenere il confronto con Gregorio
Magno - un accostamento lusinghiero, citato al principio dei riassunti posteriori
della vita di N., ad esempio da Martino di Troppau († 1278) e Thomas Ebendorfer
(† 1464) - perché "comandava ai re e ai tiranni, dominandoli con
un'autorità superiore, quasi fosse stato il padrone del mondo" (p. 94).
Nell'XI secolo, il suo nome e la sua azione rappresentano sia un punto di
riferimento e una fonte d'ispirazione per il gruppo dei riformatori, sia una
posta in gioco nelle dispute con il partito imperiale. Eletto papa, il vescovo
Gerardo di Firenze, secondo alcuni, rivendicò l'eredità di N. assumendone il
nome (Niccolò II). Bonizone da Sutri († 1090) lo invoca nel Liber ad amicum,
anche a costo di distorcere la realtà dicendo che "scomunicò due
imperatori", quello d'Oriente a causa del patriarca Ignazio e quello
d'Occidente (!) per la sua deplorevole condotta matrimoniale. Ma Guido di
Osnabrück († 1101), per il partito avverso, sottolinea come N. abbia ricevuto
il donum consecrationis "in presenza e per ordine" dell'imperatore
Ludovico; e, in occasione degli avvenimenti dell'864, preferì fingere umiltà e
pazienza piuttosto che suscitare il furore del principe, designato "pater
clericorum". Da questo momento a N. viene riconosciuto un posto nella
catena dei "grandi papi", rappresentando una sorta di anello di
congiunzione fra Gregorio Magno e Gregorio VII (v. F. Gregorovius nella sua
Storia della città di Roma nel Medio Evo). La tradizione canonica ha anch'essa
ampiamente contribuito ad eternare la sua memoria, inserendo numerosi estratti
della sua corrispondenza fra i testi capitali del diritto ecclesiastico. Quelli
riguardanti il matrimonio (a cominciare dai Responsa ai Bulgari) e l'epistola
88 a Michele III (citata il più delle volte a partire da un'epitome, e al
servizio dell'idea che il papa, giudice superiore, non possa essere giudicato ["prima
sedes a nemine judicatur"]) sono i più celebri, ma ve n'è una pletora,
censita a suo tempo da E. Perels, nella collezione di Anselmo di Lucca (†
1086), in Reginone, Burcardo di Worms († 1025), Deusdedit († 1097/1100),
Bonizone, Ivo di Chartres († 1116) e Graziano (ottantadue citazioni nel
Decretum, a. 1142), per citare solo le raccolte più significative. Al di là
degli apprezzamenti complessivi e della constatazione della fortuna delle
posizioni ecclesiologiche e disciplinari espresse da N. nel Medioevo e oltre, è
opportuno individuare i principi che ne hanno guidato il pontificato. L'esame
dei suoi punti di riferimento è sufficiente a individuarli: la corrispondenza
del papa invoca largamente coloro che, con maggiore o minor fortuna, hanno
esaltato l'autorità della Sede apostolica: Leone I e Gelasio (rispettivamente
in diciassette e dieci lettere) e, in misura più modesta, Innocenzo I e
Celestino I; più originale appare la rivendicazione dell'eredità di Gregorio
Magno, citato prima di tutto per il Regestum ma anche per la Regula pastoralis,
i Moralia, i Dialoghi, i commentari al vangelo e ai salmi (le citazioni sono
distribuite in dodici lettere, con non meno di sei casi nei Responsa ai Bulgari
e quattro nell'epistola a Miche-le III). Si delinea quindi una duplice
ispirazione che ha alimentato il programma di N., riassunto nella formula della
"monarchia pastorale" (Y. Congar, p. 210), che pur non innovando nel
profondo costruisce, a partire da affermazioni rimaste sparse e talvolta
teoriche, un programma d'azione che poté essere attuato. Il pontificato di N. è
importante anche per l'apparente contraddizione che induce il papa ad insistere
a più riprese sull'autenticità dei testi e sulla fedeltà al diritto, pur
respingendo questo stesso diritto a seconda degli affari trattati e degli
interlocutori da affrontare. Nel caso di Lotario II, Guntero e Tilgaldo si sono
quindi fronteggiate due logiche (cfr. R. Kottje). L'indignazione dei due
arcivescovi dopo la condanna subita nell'autunno 863 era legittima, perché non
avevano avuto l'opportunità di pronunciare la propria difesa. Il papa, da parte
sua, fu guidato costantemente dalla preoccupazione di affermare l'autorità di
S. Pietro, il riconoscimento della quale fu posto come condizione preliminare
all'esame della documentazione. Dipende dalla mancata comprensione della natura
dell'ostacolo il fatto che gli argomenti presentati a favore del divorzio di
Lotario siano cambiati nel corso degli anni e affinati alla ricerca
dell'angolazione giuridica migliore: dall'incesto all'illegittimità, dalla
sterilità all'adulterio. Per la stessa ragione sono stati respinti l'uno dopo
l'altro, con una stessa motivazione ricorrente. Quand'anche il diritto
ecclesiastico o secolare e la ragione umana fossero schierati dalla parte della
separazione, quest'ultima non sarebbe attuabile; non tanto in nome di un
principio d'indissolubilità non ancora elaborato a Roma, ma piuttosto per
l'ostinata difesa della preminenza di S. Pietro. Questa auctoritas annullava le
auctoritates. Per questo N. fu così attento a fondare le sue pretese su una
tradizione testuale e giuridica rigorosa. La sua corrispondenza è densa di
allusioni alle fonti autentiche, ricercate, diligentissime, negli archivi della
Santa Sede, e il papa non perde occasione per stigmatizzare le subdole imprese
di falsificazione. Guntero, Tilgaldo, Giovanni di Ravenna, Incmaro, Michele III
e Fozio furono bersaglio di aspri rimproveri in merito a questo tema. Ne è un
caso esemplare la disputa fra il monastero di St-Calais e il vescovo di Le
Mans, studiata nei dettagli da W. Goffart. Nell'855 il concilio di Bonneuil,
confermato da Carlo il Calvo, aveva dato ragione alle accuse dell'abate di
St-Calais Rainaldo contro le pretese del vescovo, che intendeva far passare il
monastero sotto la sua giurisdizione in materia di proprietà e di elezione
abbaziale (Die Konzilien, III, nr. 34). Il conflitto si riaccese allorché
Roberto occupò la sede di Le Mans nell'859. In circostanze tuttora oscure,
questi ottenne l'abbazia in beneficio da Carlo il Calvo, il che scatenò nuove
rimostranze da parte dei monaci, il cui caso fu portato davanti al concilio di
Pîtres nell'862. L'assemblea, non avendo potuto ascoltare le argomentazioni di
Roberto, confermò la decisione di Bonneuil senza pronunciarsi sugli elementi di
novità intervenuti nella disputa; il vescovo, invitato ad apporre anche la
propria firma al testo dell'855, rifiutò. Nei primi giorni dell'estate 863,
Oddone di Beauvais portò da Roma (dove si era recato per presentare gli atti di
Pîtres; v. supra, a proposito dell'affare di Rotado) un privilegio di N. a
favore di St-Calais, un testo di routine redatto sulla base degli atti del
sinodo. A questo punto il vescovo fece trasmettere al papa le proprie
auctoritates: turbato dal suo gesto, N. inviò sei lettere (una è perduta) in
Francia, chiedendo a Carlo il Calvo e al suo clero di regolare la questione,
allo scopo di esaminare il ricorso di Roberto (epp. 109-13; anche in Regesta
Pontificum Romanorum, nrr. 2742-46). Nell'ottobre 863 si riunì un'assemblea a
Verberie (Die Konzilien, IV, nr. 18), in presenza del re, nel corso della quale
emerse che le pretese di Le Mans si fondavano su una trama di falsi documenti;
venne così ordinata la consegna degli atti entro quindici giorni per
distruggerli pubblicamente. Forti della conferma ottenuta, i monaci inviarono a
Roma un archivio composto per l'occasione, inducendo così N. a conferire al
monastero un nuovo privilegio, che si sofferma lungamente sulla frode e la
machinatio di cui i monaci, e indirettamente Roma, erano stati vittime (ep.
159; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2735, in forma di decreto). Si
può comunque osservare che l'attenzione di N. non era stata rigida sin dal
primo momento e che il privilegio finale è riconducibile ad una reazione
successiva alle decisioni del placito di Verberie. Un'analoga carenza di
attenzione si può riscontrare nell'approvazione concessa, nel giugno 867, alle
pretese dell'arcivescovato di Vienne, rappresentato da Adone, che aveva chiesto
di sottomettere alla sua autorità la Tarantasia, sulla base di una copiosa
documentazione di atti falsi attribuiti a Zosimo, che formano il nucleo delle
Epistolae Viennenses spuriae (Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2876; Giovanni
VIII tornò sulla decisione nell'878, trattando le sedi di Vienne e la
Tarantasia come Chiese metropolitane indipendenti). Neppure i dibattiti con gli
esperti in diritto canonico sono affrontati con leggerezza: nei rapporti con
Incmaro, N. vigila attentamente sul rispetto delle procedure, insistendo ad
esempio in modo inconsueto sul termine di cui dispone per fare appello contro
la reintegrazione di Vulfado, con l'evidente preoccupazione di non fornire il
destro a contestazioni in merito alla forma dei suoi interventi. Si noterà
inoltre l'uso estensivo delle fonti giuridiche, che è stato più volte
sottolineato a proposito dei Responsa ai Bulgari, definiti da B. Paradisi una
collezione giuridica mista, che attinge alle norme giustinianee (le
Institutiones e il Codex - in una versione ridotta che non era né l'Epitome né
la Summa Perusina), longobarde e franche, affiancandole ai decreti canonici, un
uso reso possibile dall'idea che N. aveva della sua posizione rispetto al
diritto, qualunque ne fosse la provenienza, foss'anche dubbia come nel caso
delle false decretali: quella di un potere imperiale in grado di conferire, in
virtù della sua autorità, un'omogeneità agli elementi più disparati, al
servizio della causa della Chiesa romana militante. Infine, N. si considerava
il guardiano dei libri non meno che delle leggi. Si è visto che i Responsa
respingevano il libero uso dei libri di culto in un paese non ancora
cristianizzato e non latino. Una posizione analoga a quella espressa nel
richiamo all'ordine rivolto forse nell'862 a Carlo il Calvo, a proposito della
traduzione di Dionigi l'Aeropagita fatta da Giovanni Scoto Eriugena: avendone
appreso l'esistenza da fonti esterne, N. pretese che il testo fosse sottoposto
all'approvazione della sua autorità, juxta morem, in considerazione del
principio che quanto riceveva la Sede apostolica aveva valore universale (ep.
130; anche in Regesta Pontificum Romanorum, nr. 2833; cfr. R. Somerville in
merito all'autenticità del documento e ad un'ipotesi di datazione). Nei
rapporti con gli altri poteri, N. si era saldamente attestato, come i suoi
predecessori, sulla linea gelasiana della separazione e dell'indipendenza,
senza cercare di stabilire una preminenza che avrebbe giustificato
l'universalità della propria missione e la sua investitura dall'alto.
L'insuccesso, per esempio, delle prese di posizione di Ludovico II a favore di
Giovanni di Ravenna, o di Guntero e Tilgaldo, o del tentativo di sostituire il
vescovo Suffredo a Piacenza, scaturisce da una difesa accanita di ciò che N.
considerava un dominio rigorosamente ecclesiastico, ma senza approdare a
conseguenze teoriche particolari. Allo stesso modo, sottolineare che
l'imperatore era stato incoronato dal papa (ep. 34, p. 305; anche in Regesta
Pontificum Romanorum, nr. 2774, argomento ripreso dallo stesso Ludovico II
nella sua lettera a Basilio I nell'871, redatta da Anastasio) vale unicamente a
rafforzare un'autorità in rapporto ad altre potenze laiche e non a collocarla
in seconda posizione all'interno di una gerarchia dominata dal pontefice.
Invece appare rilevante che i grandi laici abbiano considerato il papato un
riferimento obbligato, e non solo come arbitro nelle relazioni politiche
internazionali. Come i vescovi trovarono in N. un guardiano geloso della loro
facoltà di appello "contro" i metropoliti, i grandi cercarono a Roma
la protezione più efficace per difenderli dai rischi dell'ingerenza reale.
Questo accadde nel caso del conte Gherardo di Vienne nell'863, quando il papa
confermò definitivamente la traditio romana di Pothières e Vézelay nel momento
in cui egli si schierava dalla parte di Lotario II contro Carlo il Calvo.
L'influenza romana si può misurare anche sulla base delle numerose lagnanze e
consultazioni che affluivano a Roma a proposito di questioni matrimoniali. Il
pontificato di N. non fu certo il primo a ricevere queste sollecitazioni, ma la
frequenza dei ricorsi sotto il suo governo gli attribuisce una dimensione
particolare in questa sfera, considerando che l'intervento della Chiesa nelle
dispute fra coniugi non era scontato, a giudicare dal dibattito cui dà voce il
De divortio di Incmaro, in merito all'opportunità, da parte dei vescovi, di
pronunciarsi sull'unione di Lotario II. Lo sforzo di cristianizzare e
disciplinare il matrimonio sortì l'effetto di estendere la cerchia dei
corrispondenti laici diretti della Santa Sede. Fu il pontificato di N. a far
infine venire prepotentemente alla luce la divisione fra Oriente greco e
Occidente latino. Lo scambio di invettive fra N. e Michele III sul tema della
lingua, la ricorrente designazione del basileus come "imperatore dei
greci" sono le manifestazioni più lampanti di un'ostilità epidermica
alimentata in profondità da conflitti teologici, ecclesiologici o disciplinari
(sul Filioque, il primato, l'apostolicità, il matrimonio, ecc.). Nell'867,
l'accusa di eresia da parte di Fozio è semplicemente un indizio rivelatore: il
successo della consultazione di N. presso il clero a nord delle Alpi - dove
l'assenza fisica dell'imperatore aveva annullato perfino gli eventuali contatti
diplomatici con Bisanzio, circoscritti all'Italia - dimostra come l'opposizione
latente attendesse soltanto l'occasione per essere formulata e argomentata al
di fuori della cerchia pontificia (cfr. K. Herbers, Papst Nikolaus I. und
Patriarch Photios). Dopo la morte, avvenuta il 13 novembre 867, N. fu sepolto a
S. Pietro, non all'interno della basilica ma, secondo una prassi inaugurata da
Benedetto III e ripresa dai suoi successori (Giovanni VIII, Marino I, Stefano V
e Stefano VI, Giovanni IX e forse Sergio III), nell'atrium, accanto alla porta
meridionale detta "del Giudizio". Questa scelta, che nel caso di
Benedetto III poteva ancora essere interpretata come un'estrema affermazione di
legittimità (riposava nel luogo in cui Anastasio, suo concorrente nell'855, era
stato giudicato e dove Benedetto aveva fatto ridipingere a nuovo la scena della
sua scomunica da parte di Leone IV), con N. e i suoi successori si inquadra in
una trasformazione della devozione funeraria, che per un certo periodo non ha
più cercato la vicinanza della confessione di S. Pietro ma ha inteso dimostrare
un'ultima volta l'umiltà del sovrano pontefice, opportunamente messa in risalto
dall'epitaffio di N. - che è in parte ancora conservato nelle cripte vaticane
(cfr. Le Liber pontificalis, p. 172). Già il 2 febbraio 868, Adriano II chiese
ai partecipanti al concilio riunito a Troyes in autunno di inserire il nome di
N. nei libri e dittici delle loro chiese e di introdurlo nelle litanie della
messa (in M.G.H., Epistolae, VI, 2, p. 700). È a questo testo che fece
riferimento Benedetto XIV per iscrivere N. fra i canonizzati (De servorum Dei
beatificatione et beatorum canonizatione, a cura di E. de Azevedo, Bruxelles
1840, p. 5), mentre si tratta semplicemente del pendant della sua
commemorazione all'VIII concilio ecumenico, in un momento in cui era opportuno
rivendicare la sua eredità a fronte delle dispute con l'Oriente. P. De
Natalibus gli dedica una breve notizia ispirata al Liber pontificalis
(Catalogus sanctorum […], I, Vicentiae 1493, nr. 34), ma alla data del 6
dicembre, festa di s. Nicola di Bari. Il Martyrologium Romanum di Baronio
(1605) riprende tale indicazione nell'edizione del 1630, che accoglieva il suo
nome per la prima volta (p. 559). Dopo uno spostamento al 5 dicembre (decreto
del 6 maggio 1850), la Congregazione dei Riti, con decreto dell'8 luglio 1883,
fissò infine la sua festa nel giorno dell'anniversario della morte. Fonti e
Bibl.: la fonte "romana" sul pontificato di N. è costituita dalla sua
corrispondenza, ricca di circa centosessanta lettere (che contengono numerose
menzioni di altre lettere perdute) e particolarmente ragguardevole a proposito
dei rapporti con l'Oriente, nonché dalla notizia del Liber pontificalis, che,
in questo caso, si discosta dalla consueta composizione basata essenzialmente
sulla compilazione dei dati provenienti dal vestiarium. Le informazioni
materiali quali le liste delle donazioni, le riparazioni e gli abbellimenti
relativi a chiese o monasteri principalmente romani occupano solo uno spazio
modesto in una biografia rielaborata da un redattore esterno con il supporto
del registro della corrispondenza pontificia (il termine regestum compare nel
cap. 57, p. 162; v. anche il canonista, cardinale Deusdedit, in M.G.H., Libelli
de lite imperatorum et pontificum saec. XI et XII conscripti, II, a cura di E. Dümmler-F.
Thaner-E. Sackur, 1892, p. 346). Quanto al redattore, lo si potrebbe
identificare con Anastasio Bibliotecario o con Giovanni Diacono (Immonide), che
fu del resto l'autore della notizia rimasta incompleta su Adriano II.
L'intervento di autori di livello socio-culturale più elevato, già avvertibile
nella biografia di Leone IV, diviene preponderante nella notizia su N.,
segnando un cambiamento fondamentale nella concezione del Liber pontificalis,
non più scritto nella linea di una continuità burocratica, ma con l'intento di
trasmettere un'ideologia; e preannuncia inoltre la fine dell'opera, la cui
prosecuzione non dipendeva più dal lavoro di anonimi compilatori
intercambiabili ma da spiccate personalità: alla morte di personaggi come
Giovanni Diacono (880/882) o Anastasio (verso l'879), la stesura dell'opera
subisce un arresto per mancanza di redattori, in un contesto burrascoso che è
d'ostacolo ad una sua ripresa. Una presentazione del pontificato di N., oltre
ai resoconti contemporanei o leggermente posteriori (principalmente: Annales
Bertiniani, Annales Fuldenses, Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma),
deve quindi considerare questo doppio filtro: di sperimentata routine, da una
parte, e di lavoro nutrito di ambizioni storiche e politiche, dall'altra, che
esprime il punto di vista di Giovanni Diacono o Anastasio e, soprattutto, del
suo committente Giovanni VIII, negli anni Settanta. L'energia e l'autorità
attribuite a N. sono servite da modello al suo successore Adriano II, che ha
dovuto misurarsi con i medesimi problemi, mettendo in ombra anche gli immediati
predecessori, Leone IV e Benedetto III, che pure assunsero posizioni
anticipatrici rispetto a quelle adottate da Niccolò. Più specificamente v.:
I.D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XV, Venetiis
1770; Martini Oppaviensis Chronicon pontificum et imperatorum, a cura di L.
Weiland, in M.G.H., Scriptores, XXII, a cura di G.H. Pertz, 1872, p. 429;
Andreae Bergomatis Historia 13, ibid., Scriptores rerum Langobardicarum et
Italicarum saec. VI-IX, a cura di G. Waitz, 1878, p. 227; Erchemperti Historia
Langobardorum, 37, ibid., p. 248; Annales Bertiniani, ibid., Scriptores rerum
Germanicarum in usum scholarum, V, a cura di G. Waitz, 1883, ad indicem;
Regesta Pontificum Romanorum, a cura di Ph. Jaffé-G. Wattenbach-S.
Loewenfeld-F. Kaltenbrunner-P. Ewald, I-II, Lipsiae 1885-88: I, nrr. 2674-888,
pp. 341-68; II, p. 703; Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon, in M.G.H.,
Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, L, a cura di Fr. Kurze, 1890,
ad indicem; Annales Fuldenses sive Annales Regni Francorum orientalis, ibid.,
VII, a cura di Fr. Kurze, 1891, ad indicem; Excerpta ex Widonis Osnabrugensis
libro de controversia inter Hildebrandum et Heinricum, a cura di L. von Heinemann,
ibid., Libelli de lite imperatorum et pontificum saec. XI et XII conscripti, I,
a cura di E. Dümmler-L. von Heinemann-F. Thaner, 1891, pp. 465, 467; Bonizonis
episcopi Sutrini Liber ad amicum, a cura di E. Dümmler, ibid., pp. 608 s.; Le
Liber pontificalis, a cura di L. Duchesne, II, Paris 1892, pp. 151-72
[Bibliotheca Hagiographica Latina [...], II, Bruxellis 1900-01, nr. 6095;
epitome di Flodoardo, De Christi triumphis apud Italiam XII, 2, in P.L., CXXXV,
coll. 819-22], 176; P.F. Kehr, Le bolle pontificie anteriori al 1198 che si
conservano nell'Archivio di Montecassino, Montecassino 1899, nr. 1, pp. 23-6
(ora anche in Id., Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia
Pontificia, I-VI, Città del Vaticano 1977: II, pp. 149-52); Id., Papsturkunden
in Venetien, "Nachrichten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften
zu Göttingen", Phil.-hist. Klasse, 1899, nr. 1, pp. 215 s. (ora anche in
Id., Papsturkunden in Italien, I, pp. 523 s.); Id., Papsturkunden in Mailand,
ibid., 1902, nr. 2, pp. 81 s. (ora anche in Id., Papsturkunden in Italien, III,
pp. 255 s.); L. Levillain, Examen critique des chartes mérovingiennes et
carolingiennes de Corbie, Paris 1902, ad indicem e nr. 32 [Regesta Pontificum
Romanorum, nr. 2717]; Nicolai I papae Epistolae, in M.G.H., Epistolae, VI, 2, a
cura di E. Perels, 1902-25, pp. 257-690; Il Chronicon di Benedetto monaco di S.
Andrea del Soratte e il Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma, a cura
di G. Zucchetti, Roma 1920, pp. 201 ss.; F. Dölger, Rege- sten der Kaiserurkunden
des oströmischen Reiches von 565-1453, I, Mün- chen-Berlin 1924, nrr. 457, 464;
Monumenta Vezaliciensia: textes relatifs à l'histoire de l'abbaye de Vézelay, a
cura di R.B.C. Huygens, Turnhout 1976, pp. 249-58 [Regesta Pontificum
Romanorum, nrr. 2830-31]; Die Konzilien der karolingischen Teilreiche 843-859,
in M.G.H., Leges, Legum sectio III: Concilia, III, a cura di W. Hartmann, 1984,
pp. 317, 339, 430, 489; V. Grumel, Les regestes des actes du Patriarcat de
Constantinople, I, Les actes des Patriarches, fascc. 1-2, Les regestes de 715 à
1206, a cura di J. Darrouzès, Paris 1989², nrr. 467, 469-72, 495, 498-501, 529;
J.F. Böhmer, Regesta Imperii, I, Die Regesten des Kaiserreichs unter den
Karolingern 751-918 (926), 3, 1, Die Karolinger im Regnum Italiae 840-887
(888), a cura di H. Zielinski, Köln-Wien 1991, ad indicem; Incmaro, De divortio
Lotharii regis et Theutbergae reginae, in M.G.H., Leges, Legum sectio III:
Concilia, IV, Supplementum, I, a cura di L. Böhringer, 1992; T. Ebendorfer,
Chronica pontificum Romanorum, a cura di H. Zimmermann, ibid., Scriptores rerum
Germanicarum. Nova series, XVI, 1994, pp. 293 ss.; Die Konzilien der
karolingischen Teilreiche 860-874, ibid., Leges, Legum sectio III: Concilia,
IV, a cura di W. Hartmann, 1998, nrr. 5, 8, 15-6, 20. A. Thiel, De Nicolao papa
I commentationes duae historico-canonicae, Braunsberg 1859; A. Lapôtre, De
Anastasio bibliothecario sedis apostolicae, Paris 1885 (ora in Id., Études sur
la Papauté au IXe siècle, I-II, Torino 1978: I), pp. 68-207; E. Dümmler,
Geschichte des ostfränkischen Reiches, II-III, Leipzig 1887-88, ad indices; H.
Dopffel, Kaisertum und Papstwechsel unter den Karolingern, Freiburg im Br.
1889, pp. 48-51, 128-33; A. Lapôtre, L'Europe et le Saint-Siège à l'époque
carolingienne, I, Le pape Jean VIII, 872-882, Paris 1895 (ora in Id., Études
sur la Papauté, II), pp. 37 s., 40, 54-8, 104, 109-12, 222; J. Roy,
Principes du pape Nicolas Ier sur les rapports des deux puissances, in Études
d'histoire du Moyen Âge dédiées à Gabriel Monod, ivi 1896 (rist. anast. Genève
1975), pp. 95-105; Id., St. Nicolas Ier, ivi 1899; J. Richterich, Papst
Nikolaus I., Bern 1903; É. Lesne, La hiérarchie épiscopale. Provinces,
métropolitains, primats en Gaule et en Germanie depuis la réforme de saint
Boniface jusqu'à la mort d'Hincmar 742-882, Lille 1904, ad indicem; H. Quentin,
Lettre de Nicolas Ier pour le concile de Soissons et formules ecclésiastiques
de la province de Tours dans un manuscrit de Nicolas Le Fèvre, "Le Moyen
Âge", 17, 1904, pp. 97-114; E. Perels, Ein Berufungsschreiben Papst
Nikolaus' I. zur fränkischen Reichssynode in Rom, "Neues Archiv", 32,
1907, pp. 133-49; L.M. Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter, III, 1-2,
Gotha 1908-11, ad indices; A. Greinacher, Die Anschauungen des Papstes Nikolaus
I. über das Verhältnis von Staat und Kirche, Berlin-Leipzig 1909; M. Conrat,
Römisches Recht bei Papst Nicolaus I., "Neues Archiv", 36, 1911, pp.
719-22; Ch.J. Hefele-H. Leclercq, Histoire des conciles d'après les documents
originaux, IV, 1, Paris 1911; É. Lesne, Nicolas Ier et les libertés des
monastères des Gaules, "Le Moyen Âge", 24, 1911, pp. 276-306, 333-45;
E. Perels, Die Briefe Papst Nikolaus' I., "Neues Archiv", 37, 1912,
pp. 535-86; Id., Die Briefe Papst Nikolaus' I., II, Die kanonistische Überlieferung,
ibid., 39, 1914, pp. 43-153; Id., Papst Nikolaus I. und Anastasius
Bibliothecarius. Ein Beitrag zur Geschichte des Papsttums im neunten
Jahrhundert, Berlin 1920; H.K. Mann, The Lives of the Popes in the Early Middle
Ages, III, London 1925², pp. 1-148; F. Schneider, Rom und Romgedanke im
Mittelalter. Die geistigen Grundlagen der Renaissance, München 1926, ad
indicem; F. Dvornik, Les Slaves, Byzance et Rome au IXe siècle, Paris 1926, ad
indicem; E. Perels, Papst Nikolaus I. im Streit zwischen Le Mans und St.
Calais, in Papsttum und Kaisertum. Forschungen für Paul Kehr zum 65. Geburtstag
dargebracht, a cura di A. Brackmann, München 1926, pp. 146-62; R. Holtzmann,
Der Kaiser als Marschall des Papstes. Eine Untersuchung zur Geschichte der
Beziehungen zwischen Kaiser und Papsttum im Mittelalter, Berlin-Leipzig 1928,
pp. 22-6; G. Laehr, Die Briefe und Prologe des Bibliothekars Anastasius,
"Neues Archiv", 47, 1928, pp. 416-68; P.E. Schramm, Kaiser, Rom und
Renovatio, II, München 1929, ad indicem; J. Haller, Nikolaus I. und
Pseudo-Isidor, Leipzig 1936; H. Sproemberg, Judith, Koenigin von England,
Graefin von Flandern, "Revue Belge de Philologie et d'Histoire", 15,
1936, pp. 930 ss.; N. Ertl, Diktatoren frühmittelalterlichen Papstbriefe, "Archiv
für Urkundenforschung", 15, 1937-38, pp. 56-132; F. Gregorovius, Storia
della città di Roma nel Medio Evo, V, Roma 1940, pp. 9 ss.; E. Amann, in
Histoire de l'Église, a cura di A. Fliche-V. Martin, VI, Paris 1941, pp. 367
ss.; R. Louís, Girart, comte de Vienne (819-877) et ses fondations monastiques,
Auxerre 1946, ad indicem; F.A. Norwood, The Political Pretensions of Pope
Nicholas I, "Church History", 15, 1946, pp. 271-85; P. Brezzi, Roma e
l'Impero medioevale, Bologna 1947, pp. 61-4; F. Dvornik, The Photian Schism:
History and Legend, Cambridge 1948; I. DujŠcev, Die Responsa Nicolai I. papae
ad Consulta Bulgarorum als Quelle für die bulgarische Geschichte [1949], in
Id., Medioevo bizantino-slavo, I, Roma 1965, pp. 125-48; A. Frugoni, La Chiesa
di Niccolò I. Niccolò I e il potere temporale, "Humanitas", 4, 1949,
pp. 495-501, 603-09; F.X. Seppelt, Geschichte der Päpste, München 1955², pp.
241 ss.; W. Ullmann, The Growth of Papal Government in the Middle Ages. A Study
in the Ideological Relation of Clerical to Lay Power, London 1955, pp. 190-209;
G.T. Dennis, The "anti-Greek" Character of the Responsa of Nicholas
I, "Orientalia Christiana Periodica", 24, 1958, pp. 165-74; H.
Fuhrmann, Papst Nikolaus I. und die Absetzung des Erzbischofs Johannes von
Ravenna, "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte",
Kanonistische Abteilung, 44, 1958, pp. 353-58; Id., Eine im Original erhaltene
Propagandaschrift des Erzbischofs Gunthar von Köln (865), "Archiv für
Diplomatik", 4, 1958, pp. 1-5; F. Cognasso, I papi nell'età carolingia
(795-888), in P. Paschini-V. Monachino, I papi nella storia, I, Roma 1961, pp.
292-301; W. Goffart, The Privilege of Nicholas I for St. Calais: a New Theory,
"Revue Bénédictine", 71, 1961, pp. 287-337; Id., The Le Mans
Forgeries. A Chapter from the History of Church Property in the Ninth Century,
Cambridge, Mass. 1966, ad indicem; F. Dvornik, Byzance et la primauté romaine,
Paris 1964, ad indicem; J. Haller, Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit, II,
Hamburg 1965³, pp. 54 ss.; Handbuch der Kirchengeschichte. Die
mittel-alterliche Kirche, vom kirchlichen Frühmittelalter zur gregorianischen
Reform, a cura di H. Jedin, III, 1, Freiburg im Br. 1966 (trad. it. Storia
della Chiesa, a cura di H. Jedin, IV, Il primo Medio Evo, Milano 1978), pp.
160-72, 186-94, 197-204; Y. Congar, S. Nicolas Ier: ses positions
ecclésiologiques, "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", 21,
1967, pp. 393-410 (ora anche in Id., L'ecclésiologie du haut Moyen Âge de saint
Grégoire le Grand à la désunion entre Byzance et Rome, Paris 1968, pp. 206
ss.); B. Paradisi, Il diritto romano nell'Alto Medio Evo, le epistole di Nicola
I e un'ipotesi del Conrat, Bononiae 1967, pp. 209-51 (ora anche in Id., Studi
sul medio evo giuridico, I, Roma 1987, pp. 225-62); D. Stiernon, Constantinople
IV, Paris 1967, pp. 32-5, 41-68; P. Delogu, Strutture politiche e ideologia nel
regno di Lodovico II, "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il
Medio Evo e Archivio Muratoriano", 80, 1968, pp. 157-64, 172 s.; C.
Falconi, Storia dei papi e del papato, II, Roma-Milano 1968, pp. 417-48; F.
Dvornik, Byzantine Missions among the Slavs. SS. Constantine-Cyril and
Methodius, New Brunswick-New Jersey 1970, ad indicem; H. Grotz, Erbe wider
Willen. Hadrian II.(867-872) und seine Zeit, Wien 1970; I. DujŠcev, I "Responsa"
di papa Nicolò I ai Bulgari neoconvertiti, "Aevum", 42, 1968, pp.
403-28 (ora anche in Id., Medioevo bizantino-slavo, III, Roma 1971, pp.
143-71); J. Ch. Picard, Études sur l'emplacement des tombes des papes du IIIe au
Xe siècle, "Mélanges d'Archéologie et d'Histoire. École Française de
Rome", 81, 1969, pp. 769 s. (ora anche in Id., Évêques, saints et cités en
Italie et en Gaule. Études d'archéologie et d'histoire, Roma 1998, pp. 241 s.);
P. Llewellyn, Rome in the Dark Ages, London 1971, pp. 112, 271-76; S. Kuttner,
Sulla trasmissione in ambito canonico dell'ep. 88 di Niccolò I all'imperatore
Michele e sulla seconda recensione del Polycarpus, appendice III a Id., Urban
II and the Doctrine of Interpretation: A Turning Point?, Roma 1972 (Studia Gratiana,
15), ora anche in Id., The History of Ideas and Doctrines of Canon Law in the
Middle Ages, London 1980, cap. IV, pp. 81-4; G. Denzler, Das Papsttum und der
Amtszölibat, I, Stuttgart 1973, pp. 39-41; F. Dvornik, Photius, Nicholas I and
Hadrian II, "Byzantinoslavica", 34, 1973, pp. 33-50 (ora anche in
Id., Photian and Byzantine Ecclesiastical Studies, London 1974, cap. XIX); P.
Duthilleul, L'évangélisation des Slaves: Cyrille et Méthode, Tournai 1973, pp.
70, 81-9; H. Hees, Studien zur Geschichte Kaiser Ludwigs II., Regensburg 1973,
pp. 90-2 e passim; H. Fuhrmann, Einfluß und Verbreitung der pseudo-isidorischen
Fälschungen von ihrem Auftauchen bis in die neuere Zeit, II, München 1974, pp.
237-88; P.R. McKeon, Archbishop Ebbo of Reims, "Church History", 43,
1974, pp. 437-47; J.L. Wieczynski, The Anti-Papal Conspiracy of the Patriarch
Photius in 867, "Byzantine Studies", 1, 1974, pp. 180-89; E. Boshof,
Traditio romana und Papstschutz im 9. Jahrhundert. Untersuchungen zur
vorcluniazensischen libertas, in Rechtsgeschichtlich-diplomatische Studien zu
frühmittelalterlichen Papsturkunden, a cura di E. Boshof-H. Wolter, Köln 1976,
pp. 1-100; J. Devisse, Hincmar, archevêque de Reims, 845-882, II, Genève 1976,
pp. 582 ss., ad indicem; P. Leisching, Der Inhalt der Responsa des Nikolaus I.
ad consulta Bulgarorum im Lichte westkirchlicher Quellen, "Kanonistisches
Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen", 3, 1977, pp.
240-48; G. Arnaldi, Il Papato della seconda metà del secolo IX nell'opera di p.
Lapôtre S.J., "La Cultura", 16, 1978, pp. 185-217; J. Fried,
Laienadel und Papst in der Frühzeit der französischen und deutschen Geschichte,
in Nationes, I, Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter, a cura di H.
Beumann-W. Schröder, Sigmaringen 1978, pp. 368-71, 377 s.; N. Gussone, Thron
und Inthronisation der Päpste von den Anfängen bis zum 12. Jahrhundert, Bonn
1978, ad indicem; P.C. Jacobsen, Flodoard von Reims: sein Leben und seine
Dichtung "De triumphis Christi", London-Köln 1978, pp. 265 s.; L. Heiser,
Die Responsa ad consulta Bulgarorum des Papstes Nikolaus I. (858-867): ein
Zeugnis päpstlicher Hirtensorge und ein Dokument unterschiedlichen
Entwicklungen in den Kirchen von Rom und Konstantinopel, Trier 1979; R.J.
Belletzkie, Pope Nicholas I and John of Ravenna. The Struggle for
Ecclesiastical Rights in the Ninth Century, "Church History", 49,
1980, pp. 262-72; J.C. Bishop, Pope Nicholas I and the First Age of Papal
Independance, Ann Arbor-London 1981; J.H.M. Smith, The
"archbishopric" of Dol and the Ecclesiastical Politics of Ninth
Century Brittany, in Religion and National Identity, a cura di S. Mews, Oxford
1982, pp. 59-70; N. Staubach, Das Herrscherbild Karls des Kahlen. Formen und
Funktionen monarchischer Repräsentation im früheren Mittelalter, Münster 1982,
ad indicem; K. Kennedy, The Permanence of an Idea: Three Ninth Century Frankish
Ecclesiastics and the Authority of the Roman See, in Aus Kirche und Reich.
Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter. Festschrift für
Friedrich Kempf, a cura di H. Mordek, Sigmaringen 1983, pp. 105-16; R. Kottje,
Kirchliches Recht und päpstlicher Autoritätsanspruch. Zu den
Auseinandersetzungen über die Ehe Lothars II., ibid., pp. 97-103; J.-M.
Sansterre, Les moines grecs et orientaux à Rome aux époques byzantine et
carolingienne (milieu du VIe s.-fin du IXe s.), Bruxelles 1983, ad indicem; A.
Chédeville-H. Guillotel, La Bretagne des saints et des rois, Ve-Xe siècle,
Rennes 1984, ad indicem; Th. F. X. Noble, The Republic of St. Peter. The Birth of
the Papal State 680-825, Philadelphia 1984 (trad. it. La Repubblica di San
Pietro. Nascita dello Stato pontificio 680-825, Genova 1998), p. 229; B.
Ward-Perkins, From Classical Antiquity to the Middle Ages. Urban Public
Building in Northern and Central Italy A.D. 300-850, Oxford 1984, ad indicem;
V. Gjuzelev, Das Papsttum und Bulgarien im Mittelalter (9.-14. Jh.), Wien 1985,
ad indicem; A.E. Laiou, "Consensus facit nuptias - Et non": Pope
Nicholas I's Responsa to the Bulgarians as a Source for Byzantine Marriage Customs,
"Rechtshistorisches Journal", 4, 1985, pp. 189-201 (ora in Ead.,
Gender, Society and Economic Life in Byzantium, London 1992, cap. IV); W.
Hartmann, Fälschungsverdacht und Fälschungs- nachweis im früheren Mittelalter,
in Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongress der Monumenta Germaniae
Historica. München, 15.-18. September 1986, II, Hannover 1988, pp. 111-28; E.
Boshof, Odo von Beauvais, Hinkmar von Reims und die kirchenpolitischen
Auseinandersetzungen im westfränkischen Reich, in Ecclesia et regnum. Beiträge
zur Geschichte von Kirche, Recht und Staat im Mittelalter. Festschrift für
Franz-Josef Schmale zu seinem 65. Geburtstag, a cura di D. Berg-M.W. Goetz,
Bochum 1989, pp. 39-59; M. Borgolte, Petrusnachfolge und Kaiserimitation. Die
Grablegen der Päpste, ihre Genese und Traditionsbildung, Göttingen 1989, pp.
122, 350; W. Hartmann, Synoden der Karolingerzeit im Frankenreich und in
Italien, Paderborn 1989, ad indicem; P.A. Holmes, Nicholas I's "Reply to
the Bulgarians" Revisited, "Ecclesia Orans", 7, 1990, pp.
131-43; K. Herbers, Der Konflikt Papst Nikolaus' I. mit Erzbischof Johannes
VII. von Ravenna (861), in Diplomatische und chronologische Studien aus der
Arbeit an den Regesta Imperii, a cura di P.J. Heinig, Köln 1991, pp. 51-66;
M.M. Sheehan, The Bishop of Rome to a Barbarian King on the Rituals of
Marriage, in In Iure veritas. Studies in Canon Law in Memory of S. Williams, a
cura di S.B. Bowman-B.E. Cody, Ann Arbor 1991, pp. 187-99 (ora anche in Id.,
Marriage, Family and Law in Medieval Europe. Collected Studies, a cura di J.K.
Farge, Toronto-Buffalo 1996); M. Banniard, "Viva voce": Communication
écrite et communication orale du IVe au IXe siècle en Occident latin, Paris
1992, pp. 545 s.; R. Savigni, I papi e Ravenna dalla caduta dell'Esarcato alla
fine del secolo X, in Storia di Ravenna, a cura di A. Carile, II, 2, Ravenna
1992, pp. 42-348; K. Herbers, Papst Nikolaus I. und Patriarch Photios. Das Bild
des byzantinischen Gegners in lateinischen Quellen, in Die Begegnung des
Westens mit dem Osten. Kongressakten des 4. Symposions des Mediävistenverbandes
in Köln 1991 aus Anlaß des 1000. Todesjahres der Kaiserin Theophanu, a cura di
O. Engels-P. Schreiner, Sigmaringen 1993, pp. 51-74; Histoire du Christianisme
des origines à nos jours, a cura di J.M. Mayeur et al., IV, Paris 1993, ad
indicem; M. Sot, Un historien et son Église au Xe siècle: Flodoard de Reims,
ivi 1993, ad indicem; S. Vacca, "Prima Sedes a nemine iudicatur".
Genesi e sviluppo storico dell'assioma fino al Decreto di Graziano, Roma 1993,
pp. 109-19; G. Arnaldi, Tramonto e rinascita di Roma nella Storia di
Gregorovius, in Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio
Violante, I, Spoleto 1994, p. 120; W. Georgi, Erzbischof Gunthar von Köln und
die Konflikte um das Reich König Lothars II. Überlegungen zum politischen und
rechtlichen Kontext der Absetzung durch Papst Nikolaus I. im Jahre,
"Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins", 66, 1995, pp. 1-33; P.
Halfter, Das Papsttum und die Armenier im frühen und hohen Mittelalter. Von den
ersten Kontakten bis zur Fixierung der Kirchen-union im Jahre 1198,
Köln-Weimar-Wien 1996, pp. 85-110; K. Herbers, Leo IV. und das Papsttum in der
Mitte des 9. Jahrhunderts. Möglichkeiten und Grenzen päpstlicher Herrschaft in
der späten Karolingerzeit, Stuttgart 1996, ad indicem; K. Heidecker, Kerk,
huwelijk en politieke macht. De zaak Lotharius II 855-869, Amsterdam 1997, ad
indicem; R. Somerville, Pope Nicholas I and John Scottus Eriugena: JE 2833,
"Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte", Kanonistische
Abteilung, 114, 1997, pp. 67-85; M.T. Fögen, Reanimation of Roman Law in the
Ninth Century: Remarks on Reasons and Results, in Byzantium in the Ninth
Century. Dead or Alive?, a cura di L. Brubaker, Aldershot 1998, pp. 17-22; B.
Judic, La tradition de Grégoire le Grand dans l'idéologie politique
carolingienne, in La royauté et les élites dans l'Europe carolingienne (du
début du IXe aux environs de 920), a cura di R. Le Jan, Lille 1998, pp. 47-50;
F. Marazzi, I "patrimonia Sanctae Romanae Ecclesiae" nel Lazio
(secoli IV-X). Struttura amministrativa e prassi gestionali, Roma 1998, ad
indicem; B. Schilling, Guido von Vienne - Papst Calixt II., Hannover 1998, pp.
276-79 e passim. Real-encycklopädie für protestantische Theologie und Kirche,
XIV, Leipzig 1904, s.v., pp. 68-72; Dictionnaire de théologie catholique, XI,
1, Paris 1931, s.v., coll. 506-26; E.C., VIII, s.v., coll. 1823 s.; Vies des
Saints et des Bienheureux, XI, Paris 1954, s.v., pp. 406-12; G. Arnaldi,
Anastasio Bibliotecario, in D.B.I., III, pp. 25-37; A. Petrucci, Arsenio,
ibid., IV, pp. 339-41; P. Rabikauskas, Niccolò I, in B.S., IX, coll. 860-69;
New Catholic Encyclopaedia, X, Washington 1967, s.v., p. 441; Catholicisme, IX,
Paris 1982, s.v., coll. 1230-34; Lexikon des Mittelalters, VI, München-Zürich
1986, s.v., coll. 1168-70; Dictionnaire des saints et de la sainteté
chrétienne, V, Paris 1986, s.v., pp. 198-205; J.N.D. Kelly, The Oxford
Dictionary of Popes, Oxford-New York 1986, s.v., pp. 107-09; Theologische
Realenzyklopädie, XXIV, Berlin-New York 1994, s.v., pp. 535-40; Dizionario
storico del Papato, a cura di Ph. Levillain, II, Milano 1996, s.v., pp. 993-95;
Lexikon für Theologie und Kirche, VII, Freiburg im Br. 1998³, s.v., coll. 976
s. Traduzione di Maria Paola Arena.
© Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata
SOURCE : https://www.treccani.it/enciclopedia/santo-niccolo-i_(Enciclopedia-dei-Papi)/