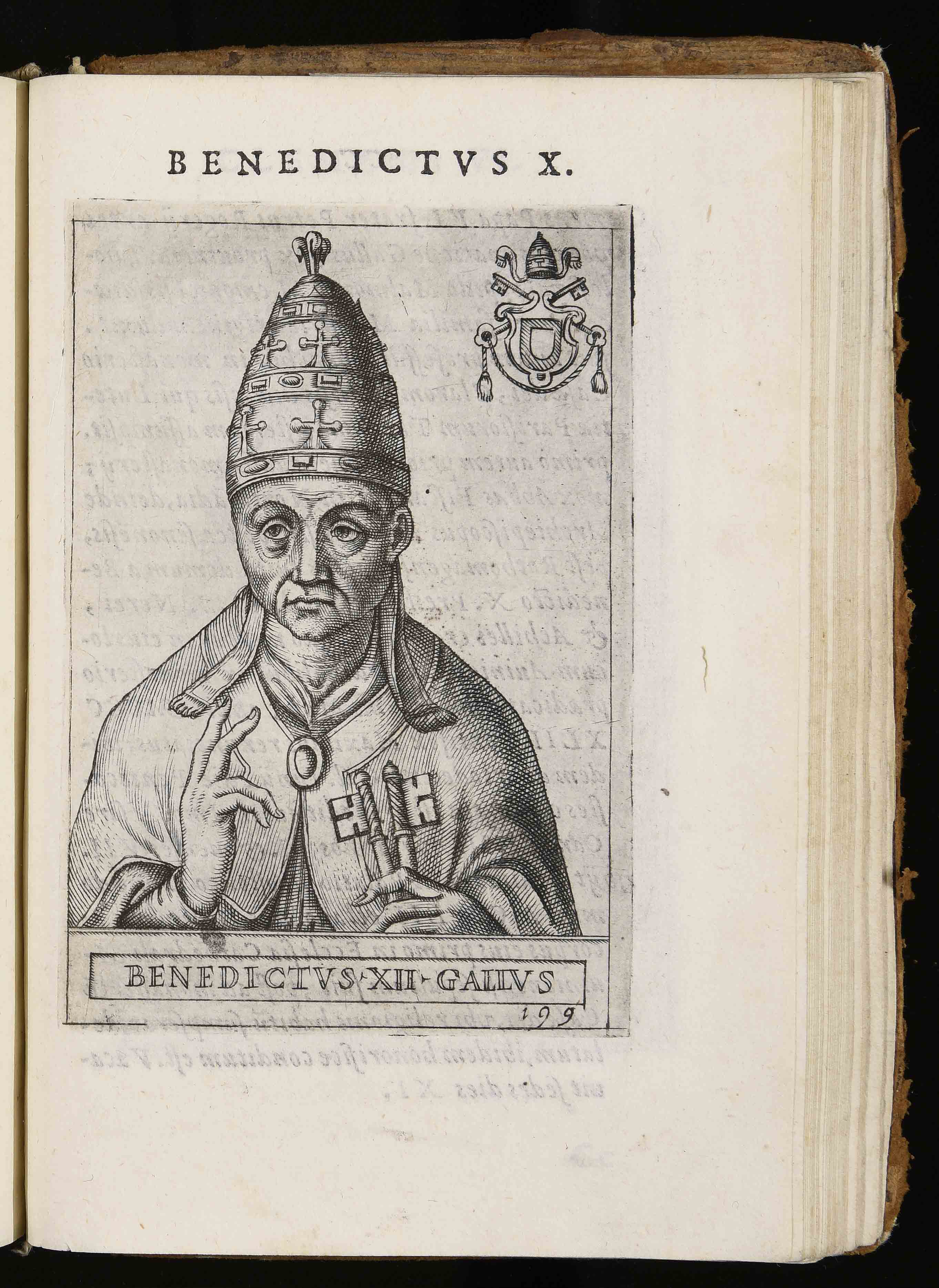Portait of en:Pope Benedict XII in the en:Basilica of Saint Paul
Outside the Walls, Rome
Ritratto
di it:Papa Benedetto XII nella it:Basilica di San Paolo fuori
la Mura, Roma
Bienheureux BENOÎT XII,
Pape
Jacques Dufour (ou
Fournier), prit l'habit cistercien à Boulbonne et devint successivement abbé de
Fontfroide, évêque de Pamiers puis de Mirepoix. Il se montra défenseur de la
foi et juge impartial et diligent ; il fut honoré de la pourpre romaine et
surnommé le cardinal blanc, car il ne voulut jamais quitter la coule
cistercienne.
Élu pape en 1334, il
continua à porter la coule monastique dans ses appartements privés et à suivre,
dans la mesure du possible, les observances cisterciennes. Il mit aussi tout
son zèle à réveiller chez les moines blancs (cisterciens) comme chez les moines
noirs (bénédictins) leur première ferveur. C'est ainsi qu'après avoir fait
visiter les abbayes cisterciennes il publia à leur intention la célèbre
Constitution "Fulgens sicut stella matutina", qui promulguait de
sages directives sur la discipline monastique, l'administration du temporel et
les études dans les monastères et les collèges.
Il promulgue ensuite la
Constitution “Benedictus Deus”, plus célèbre encore que la précédente, sur la
vision de Dieu qui est celle des élus après leur mort.
Il poursuivait avec
vigueur les hérésies foisonnant un peu partout.
Homme d'une humilité
profonde, toujours souriant et même jovial, il fuyait la pompe et l'ostentation
et avait le népotisme en horreur.
Comme, sur le point de
mourir, en 1342, on lui demandait de consentir un legs en faveur de sa famille,
il répondit : "Je suis moine, je n'ai rien en propre". Les
contemporains lui ont décerné les beaux surnoms "d'amant de la croix"
et de "zélateur de la paix".
SOURCE : http://www.abbayes.fr/histoire/saints/a_g/benoit_XII.htm
Benoît XII et des messagers de Chine, MS Français 2810 (Bibliothèque Nationale Française), circas 1410
Pape Benoit XII
Jacques Fournier - Pape
de 1334 à 1342
Moine cistercien et
évêque de Pamiers, il est élu au premier conclave d'Avignon. Contrairement à
son prédécesseur, il donna l'exemple d'une vie austère et mit fin au
nepotisme.
Il chercha à réformer
l'Eglise, à rétablir la paix entre la France et l'Angleterre, et reprit les
relations avec Louis de Bavière, il s'efforça de ramener le calme en Italie et
d'apaiser la révolte des états de l'église.
Il tenta par deux fois de
ramener la papauté à Rome, mais l'echec de ses projets le décida à demeurer à
Avignon.
Il entreprit la
construction d'un palais plus grand et mieux protégé que l'ancien palais
épiscopal, ce sera le début de la construction du palais des papes en
1340.
Il meurt le 25 avril
1342.
Selon sa volonté, il fut
inhumé dans la Cathédrale Notre Dame des Doms. Le manque d'entretien, les
profanations révolutionnaires firent pratiquement disparaitre sa sépulture. Le
tombeau a été reconstruit en grande partie avec les éléments d'un autre
mausolée.
SOURCE : https://www.avignon-et-provence.com/culture/papes-davignon/pape-benoit-xii
Paolo de Siena, Benoît XII, 1341, crypte de Saint-Pierre de Rome
Paolo
di Siena, Benedict XII, circa 1341, Vatican Grotto
Papst
Benedikt XII., zeitgenössische Darstellung, Unterkirche Petersdom, Rom
Paolo de Siena, Benoît XII, 1341, crypte de Saint-Pierre de Rome
Paolo
di Siena, Benedict XII, circa 1341, Vatican Grotto
Papst
Benedikt XII., zeitgenössische Darstellung, Unterkirche Petersdom, Rom
Also
known as
Jacques Fournier
Profile
Cistercian monk. Bishop of Pamiers, France. Cardinal.
Third of the Avignon popes.
Worked to free the papacy from French influence
and to return to Rome, Italy.
Came to terms with emperor Louis, and with the Franciscans,
who were alienated from the Vatican. He curbed nepotism and monastic excess,
condemned “pluralities”, evangelized outlying
districts, and made appointments strictly on merit.
Born
Saverdun, France as Jacques
Fournier
Papal Ascension
25 April 1342 at Rome, Italy of
natural causes
Additional
Information
Saints
and Saintly Dominicans, by Blessed Hyacinthe-Marie
Cormier, O.P.
fonti
in italiano
MLA
Citation
“Pope Benedict
XII“. CatholicSaints.Info. 10 July 2022. Web. 31 January 2025.
<https://catholicsaints.info/pope-benedict-xii/>
SOURCE : https://catholicsaints.info/pope-benedict-xii/
Gisant de Benoît XII, métropole de Notre-Dame-des-Doms d'Avignon
Tomb of Benedict XII, Cathédrale de Notre-Dame-des-Doms, Avignon
Pope Benedict XII
(JACQUES FOURNIER)
Third of the Avignon popes,
b. at Saverdun in the province of Toulouse, France,
elected 20 December, 1334; d. at Avignon 24
April, 1342. Nothing is known of
his parentage or boyhood. In youth he became a Cistercian monk in
the monastery of
Boulbonne, whence he moved to that of Fontfroide, whose abbot was
his natural uncle, Arnold Novelli, by whose name Fournier was also known. He
studied at the University
of Paris, where he received the doctorate in theology.
Meantime he was made Abbot of
Fontfroide, succeeding his uncle who was created cardinal 19
December, 1310. In December 1317, he became Bishop of
his native Diocese of Palmiers, was translated to Mirepoix 26 January, 1327,
and was made cardinal by Pope
John XXII, 18 December, 1327. On the latter's death, 4 December, 1334,
the cardinals in conclave,
most of whom opposed a return to Rome,
demanded of Cardinal de Comminges whose election seemed assured, the promise to
remain at Avignon.
His refusal precipitated an unexpected canvass for candidates. On the first
ballot, 20 December, 1334, many electors, intending to sound the mind of
the conclave,
voted for the unlikely Cardinal Fournier, who, though he was one of the few men
of real merit in the college, was but lightly regarded because of his obscure
origin and lack of wealth and following. He amazed the conclave by
receiving the necessary two-thirds
vote. On 8 January, 1335, he was enthroned as
Benedict XII.
Resolved to re-establish
the papacy at Rome,
Benedict signalized his accession by providing for the restoration of St.
Peter's basilica and the Lateran. He was prepared to acquiesce in the petition
of a Roman deputation soliciting his return, but his cardinals pictured
the impossibility of living in faction-rent Italy.
They were right, whatever were their motives, and Benedict yielded.
Conscience-stricken during a critical illness, he proposed as a compromise a
transfer of his court to Bologna. The cardinals urged
the slender hope of securing obedience, and Benedict decided to remain at Avignon,
where in 1339 he commenced to build the massive papal castle
which still exists. Mindful always of distracted Italy,
he often sent money to succour the famine-stricken people and to restore
churches. Reform of abuse was Benedict's chief concern. Immediately after his
elevation he remanded to their benefices clerics not
needed at Avignon,
and menaced with summary chastisement violators of the law of
residence. He revoked the scandalous "expectances"
granted by his predecessors and forbade conferring benefices in
commendam. (See COMMENDATORY ABBOT.)
He condemned unseemly "pluralities" and conferred benefices with
such conscientious discrimination that several were left long vacant, and so
gave colour to the calumny that
he was himself harvesting their revenues. He inveighed vigorously against greed for
gain among ecclesiastics;
regulated the taxes on documents issued by papal bureaux;
made episcopal visitation less of a financial burden to the clergy;
abolished the practice of countersigning requests for papal favours,
which was extremely lucrative to venal officials; and established the Registry
of Supplications for the control of such petitions. Abhorring nepotism, he
granted preferment to but one relative, naming the eminent John Bauzian Archbishop of
Arles in deference to the insistence of the cardinals;
he compelled his only niece to discourage noble suitors, and marry one of her
own humble rank.
A legend, vouched for by Ægidius
of Viterbo (d. 1532), accredits him with saying, "a pope should
be like Melchisedech,
without father, mother, or genealogy". Monastic reform particularly
engaged his zeal.
Himself a Cistercian,
he sought to revive pristine monastic fervour and devotion to study. Pertinent
papal constitutions and visitations of monasteries attest
his solicitude for a monastic renaissance.
Being a learned theologian,
he was as bishop, cardinal,
and pope,
keenly interested in scholastic discussions. He terminated the controversy on
the vexed question as to whether the Beatific
Vision was enjoyed before or only after the General Judgment. John
XXII had advocated the latter view and stirred up vigorous discussion.
Eager to solve the question, Benedict heard the opinions of those maintaining
the theory of deferred vision, and, with a commission of theologians,
gave four months to patristic research. Their labours terminated in the
proclamation (29 January, 1336) of the Bull "Benedictus
Deus" defining the immediate
intuitive vision of God by the souls of
the just having no faults to expiate. Zealous too for the preservation of the
Faith, he stimulated the bishops of
infected districts to vigilance in the repression of heresy and
urged the use of the preventive remedies of the Inquisition.
He combatted energetically the anti-papal doctrines which the ecclesiastico-
political theorists of the disturbed Avignon period
had spread, and which were unfortunately sustained by a school of
misguided Franciscans.
(See FRATICELLI, MARSILIUS
OF PADUA , WILLIAM
OF OCCAM, MICHAEL
OF CESENA.) Distressed by disloyalty in Ireland,
he tried to persuade Edward
III to establish the Inquisition in
his realm and urged him to assist the Irish bishops to
extirpate heresy.
But, though the most ardent foe of heresy,
Benedict was remarkably patient and loving in dealing with heretics.
He looked also to the union of the Eastern
Church with Rome through
a delegate of the Emperor Andronicus, whose sincerity, however, Benedict was
forced to question; manifested his solicitude for the Church in Armenia which,
in the early fourteenth century, suffered from Mohammedan invasions,
succouring the unfortunates in temporal matters and healing doctrinal differences
which had long rent Armenia with schism.
In purely ecclesiastical affairs
Benedict's pontificate was creditable to himself and productive of good to
the Church.
Pious, prudent, and firm, he strove conscientiously to meet the Church's needs
at a critical period. In political relations, however, he was not so
successful. Inexperienced in politics, he had little taste for diplomacy and an
imperfect knowledge of
men and affairs of the world. Conflicting political motives confused him, and
hesitancy and vacillation contrasted painfully with his firmness and decision
in ecclesiastical matters.
Though determined to act independently of Philip VI of France,
the latter generally succeeded in committing the pope to
his policy. He helped to prevent his return to Rome.
He frustrated his desire to make peace with the Emperor Louis of Bavaria whom John
XXII had excommunicated for
fomenting sedition in Italy,
proclaiming himself King of the Romans, and intruding an antipope.
Willing to absolve him should he but submit to the Church,
Benedict exposed to Louis's delegates his generous terms of peace (July, 1335).
But Philip, aided by the cardinals,
persuaded the pope that
his generosity encouraged heresy and
rebellion. Benedict yielded. Thrice the imperial envoys came to Avignon,
but French influence prevailed, and, on 11 April, 1337, Benedict declared it
impossible to absolve Louis. The latter, as Benedict feared, allied himself
with Edward
III of England against France.
In vain the pope tried
to avert war,
but he was no match for the kings and their allies. His good offices were
spurned; and he was humiliated by Philip's later alliance with Louis, who had
also allied to himself the pope's political
and ecclesiastical enemies,
and by the emperor's denial of the pope's authority
over him, and, worst insult of all, by his usurpation of papal power
in declaring the nullity of the marriage of John Henry of Bohemia and
Margaret Maultasch, that the latter might marry his son, Louis of Brandenburg.
The French king hindered Benedict's projected crusade against
the infidels, making the war with England an
excuse to forego his promise to lead the armies, and even diverting the money
subscribed for it to financing his own wars,
despite the protests of the conscientious pope.
Benedict's crusading ardour
found solace in Spain,
where he encouraged the campaign against the Mohammedans who
in 1339 invaded the peninsula.
Benedict XII has not
escaped calumny.
Reformer, foe of heresy,
builder of the Avignon papal palace,
unwilling ally of France and
enemy of Germany,
he made many enemies whose misrepresentations have inspired most non- Catholic appreciations
of his character. Much harm was done to his memory by the satires of Petrarch,
who, though befriended and honoured by
Benedict, yet bitterly resented his failure to return to Rome.
His natural obesity, too, stimulated caricature and undeserved criticism. But
history offers a vindication and testifies that, though he failed to cope
successfully with the political difficulties to which he fell heir, his piety, virtue,
and pacific spirit, his justice,
rectitude, and firmness in ruling, his zeal for doctrinal and
moral reform, and his integrity of character were above reproach.
Sources
RAYNALDUS, in
BARONIUS, Annales (Bar-le-Duc, 1872), XXV, 20-274; CHRISTOPHE, Hist.
de la papauté pendant le XIVe siècle (Paris, 1853), II, 36-79;
ROCQUAIN, La Cour de Rome (Paris, 1895), II, 437-463;
PASTOR-ANTROBUS, History of the Popes (St. Louis, 1898), I, 83-86;
VIDAL, Benoît XII: Lettres (Paris, 1902); DAUMET, Benoît XII:
Lettres (Paris, 1889); Acta SS., XIII, 83-86; Liber
Pontificalis, ed. DUCHESNE (Paris, 1886), II, 486, 527;
MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores f (Milan, 1734), III-XIII; LE
BACHELET in Dict. théol. cath., II, 653-704, an exhaustive theological
study with a good bibliography.
Peterson, John
Bertram. "Pope Benedict XII." The Catholic Encyclopedia. Vol.
2. New York: Robert Appleton Company, 1907. 24 Apr.
2020 <http://www.newadvent.org/cathen/02430a.htm>.
Transcription. This
article was transcribed for New Advent by WGKofron. In memory of Fr. John
Hilkert, Akron, Ohio — Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super
familiam suam.
Ecclesiastical
approbation. Nihil Obstat. 1907. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John
M. Farley, Archbishop of New York.
Copyright © 2020 by Kevin
Knight. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.
SOURCE : https://www.newadvent.org/cathen/02430a.htm
Kloster Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg; Collegiumskapelle; Bildnisse von Päpsten (in den Arkadenzwickeln) und zugehörige Wappen; Benedikt XII
Saints and
Saintly Dominicans – 6 November
Venerable Benedict
XII, Pope, O.P.
His mother,
the Duchess of Orsini, to gratify her caprice, had a little Dominican habit
made for Benedict in his childhood; but when later on he wished seriously to
enter the Order she opposed his desire, although in vain, for grace triumphed
over nature. The Bible, the Constitutions and the Lives of the Saints were the
bocks of predilection of the new religious. Having been created, first cardinal,
and then elected Pope on account of his great merits, he encouraged the
foundation of seminaries, popular exposition of the Sacred Scriptures, and the
ceremonies of the Church; also the cultus of Mary, in whose honor he often
preached with much pleasure. The establishment of pawn-shops, the diminution of
taxes, the success of the Christian armies against the Turks, the approval of
the cultus of the saints were the objects of his researches, of his bounty, his
prayers, his penances and his apostolic decrees. The excess of his goodness was
the only criticism passed upon his government. He loved to come into the choir
of the Minerva to chant the psalmody and make prostrations like the least of
the Friars. He often used to arrive unexpectedly at the hospitals to assure
himself that all was properly attended to, or in the middle of the conferences
of the clergy, to see how they observed his recommendations. Various graces,
are recorded as having been obtained by his intercession both during his life
and after death. (1730) Benedict
XIV in one of his works invokes him as a saint.
Prayer
My God, how much good
have I not omitted to do, and how much good have I not spoilt by doing badly!
Practice
Consider how to employ
your time better everywhere and always have with you a good book to occupy
yourself with whilst waiting for the common exercises to begin.
– taken from the
book Saints
and Saintly Dominicans, by Blessed Hyacinthe-Marie
Cormier, O.P.
SOURCE : https://catholicsaints.info/saints-and-saintly-dominicans-6-november/
(19) 3. FOURNIER, O.CIST., Jacques (ca. 1280/1285-1342)
Birth.
Ca. 1280/1285, Canté, Saverdun, diocese of Pamiers, France. His father was
perhaps a miller (1). Nephew of Cardinal Arnaud Nouvel, O.Cist.
(1310), on his mother's side (2). Relative (uncle?) of Cardinal Guillaume Court,
O.Cist. (1338). Relative of Pope John XXII (?). His
first name is also listed as Jacopo and as Iacobus; and his last name as
Fornerio. He was called the Cardinal Blanc because of the color of
his religious habit.
Education. Entered the
Order of Cîteaux (Cistercians) in the abbey of Boulbonne, diocese of Mirepoix.
Resided in Collège des Bernardins, Paris; obtained a doctorate in theology
at the Theological Faculty of Paris.
Priesthood. Ordained (no
further information found). Abbot of the monastery of Fontfroide, archdiocese
of Narbonne, in 1311; succeeded his uncle the cardinal. Inquisitor of the
province of Toulouse.
Episcopate. Elected
bishop of Pamiers, March 19, 1317. Consecrated, Rome, by Cardinal Niccolò
Alberti, O.P., bishop of Ostia e Velletri. He left the papal curia on August
21, 1317. Transferred to the see of Mirepoix, March 2, 1326; occupied the see
until his promotion to the cardinalate.
Cardinalate. Created
cardinal priest of S. Prisca in the consistory of December 18, 1327.
Cardinal protoprete toward 1333. Participated in the conclave of 1334 and
was elected pope.
Papacy. Elected pope on
December 20, 1334, in Avignon. Took the name Benedict XII. Crowned on January
8, 1335, church of the Dominicans, Avignon, by Cardinal Napoleone Orsini,
protodeacon of S. Adriano. He created seven cardinals in one
consistory.
Death. April 25, 1342, in
odor of sanctity, Avignon. Buried in the cathedral of Notre-Dame des Doms,
Avignon; his tomb was almost totally destroyed during the French Revolution and
rebuilt in the 19th century. The Cistercian martyrology venerates him as a
blessed.
Bibliography. Cardella,
Lorenzo. Memorie storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa. Rome :
Stamperia Pagliarini, 1793, II, 125-126; Chacón, Alfonso. Vitæ, et res
gestæ Pontificvm Romanorum et S. R. E. Cardinalivm ab initio nascentis Ecclesiæ
vsque ad Vrbanvm VIII. Pont. Max. 2 volumes. Romae : Typis Vaticanis,
1677, II, col. 424-425; Du Chesne, François. Histoire de tous les
cardinaux françois : de naissance, ou qui ont esté promeus au cardinalat par
l'expresse recommandation de nos roys, pour les grands services qu'ils ont
rendus a leur estat, et a leur couronne. Comprenant commairement leurs
legations, ambassades & voyages par eux faits en divers pays &
royaumes, vers les papes, empereurs, roys, potentats, republiques, communautex
& universitez, pour affaires importantes à l'église universelle, & à
l'auguste majesté de nos souuerains. Enrichie de leurs armes et de leurs
portraits. Divisée en deux tomes, et justifiée par tiltres et chartres du
thresor de sa majesté, arrests des parlemens de France, registres des Chambres
des comptes; donations, fondations, epitaphes, testamens, manuscripts, ancients
monumens, chroniques & chartulaires d'abbayes, & autres histoires
publiques & particlieres. 2 vols. A Paris : Aux despens de l'autheur, &
se vendent chez luy ..., 1660, I, 473-476; Duvernoy, Jean. Le régistre
d'inquisition de Jacques Fournier (Évêque de Pamiers), 1318-1325. Paris ; New
York : Mouton, 1978. (Civilisations et societés ; 43); "Essai de liste
générale des cardinaux. Les cardinaux du XIVè siècle jusqu'au Grand
Schisme". Annuaire Pontifical Catholique 1930. Paris : Maison de la
Bonne Presse, 1930, p. 144-145; Eubel, Conradus and Gulik, Guglielmus
van. Hierarchia Catholica Medii Aevi. Volumen I (1198-1431). Münich :
Sumptibus et Typis Librariae Regensbergianae, 1913; reprint, Padua : Il
Messagero di S. Antonio, 1960, pp. 16, 17, 46, 94 and 344; Féret, Pierre. La
Faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres : Moyen-Age. 4
v. Paris : Picard, 1894-1897. Note: Added t.p.: La Faculté de théologie de
Paris au Moyen-Age et ses docteurs les plus célèbres. Other title: Faculté
de théologie de Paris au Moyen-Age et ses docteurs les plus célébres, III,
572-576; Felten, F.J. "Le pape Benoît XII (1334-1342) et les Frères
Prêcheurs", in: La Papauté d'Avignon et le Languedoc : 1316-1342.
Toulouse : E. Privat, 1991. (Cahiers de Fanjeaux ; 26). Note: "Ouvrage
publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique et de
la Direction des Archives de France"; Guillemain, Bernard. "Benedetto
XII." Enciclopedia dei papi. 3 vols. Roma : Istituto della
Enciclopedia italiana, 2000, II, 524-530; Guillemain, Bernard. La
politique bénéficiale du pape Benoît XII, 1334-1342. Paris, H. Champion, 1952.
(Bibliothèque de l'École des hautes études,; fasc. 299; Variation: Bibliothèque
de l'École des hautes études.; Sciences historiques et philologiques ; 299.
fasc.); Ilari, Annibale. "Benedetto XII." Mondo vaticano.
Passato e presente. Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 1995, p.
131-132; Jacob, Karl. Studien über Papst Benedict XII. (20. Dezember 1334
bis 25. April 1342). Berlin: Trenkel, 1909. (History,; 533); Kelly, John Norman
Davidson. The Oxford Dictionary of Popes. Oxford ; New York : Oxford
University Press, 1986, p. 217-219; Mahn, Jean-Berthold. Le pape Benoît
XII et les cisterciens. Paris : H. Champion, 1949. (Bibliothèque de l'École des
hautes études. Sciences historiques et philologiques, 295 fasc; Variation: Bibliothèque
de l'école des hautes études.; Sciences historiques et philologiques ; 295
fasc.). Note: Appendix: Protestation des abbés cisterciens contre la réforme
projetée par Benoît XII; Le registre d'inquisition de Jacques Fournier. 3
vols. Translated by Jean Duvernoy. Paris : Bibliothèque des introuvables, 2004,
1977; Schmitt, Clement. Un pape réformateur et un défenseur de l'unité de
l'Église: Benoît XII et l'Ordre des frères mineurs, 1334-1342. Quaracchi,
College Saint-Bonaventure, 1959; Wetter, Friedrich. Die Lehre Benedikts
XII. vom intensiven Wachstum der Gottesschau. Romae : Apud aedes Universitatis
Gregorianae, 1958. Thesis (doctoral)--Pdpstliche Gregorianische Universitdt,
1956. (Analecta Gregoriana ; vol. 92.; Series Facultatis Theologicae. Sectio B
; n. 31; Variation: Analecta Gregoriana ; v. 92.; Analecta Gregoriana.; Series
Facultatis Theologicae.; Sectio B ; n. 31).
Webgraphy. Biography by
Bernard Guillemain, in Italian, Enciclopedia dei Papi (2000), Treccani; biography by John
Bertram Peterson, in English, The Catholic Encyclopedia; biography,
in English, Encyclopaedia Britannica; his engraving
and biography in Histoire de tous les cardinaux françois de
naissance, ou qui ont esté promeus au cardinalat. [Volume 1] / by François
Duchesne (1616-1693). Auteur du texte, in French, p. 473-476, Gallica; portrait and biography,
in English, Wikipedia; images and biography,
in French, Wikipédia; biography in La
Faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres. Moyen Âge.
[Volume 3] / by l'abbé Pierre Feret (1830-1911). Auteur du texte, in French, p.
572-576, Gallica; his
bust and biography, in English, second on the page, 30giorni.it; biographical
entry, in English; his
portrait, attributed to Giuseppe Franchi, 17th century, Pinacoteca
Ambrosiana, Milan; his
tomb and his portrait by Henri Ségur, Palais des papes, Avignon; his
engraving, allposter.com; miniature of
Pope Benedict XII preaching the crusade; miniature of
Pope Benedict XII and the messengers of China; another
miniature of Pope Benedict XIII and the messengers of China; Abbaye de Fontfroide, in
French (the biography of the pope is at the end of the page); his bust by Paolo
da Siena, grotto of the patriarchal Vatican basilica; detail
of the same bust; another
view of his bust; his
tomb, cathedral of Notre-Dame des Doms, Avignon; his
tomb.
(1) Féret, La Faculté de théologie de Paris et ses docteurs, III, 572, indicates that his father was a baker ("fournier" or worker of the oven) and that the cardinal's last name was Nouveau (Novelli) although he was known by his father's humble profession.
(2) This is according to Guillemain, Bernard. "Benedetto XII." Enciclopedia
dei papi, II, 524; and Ilari, "Benedetto XII." Mondo vaticano.
Passato e presente, p. 131; other sources say that he was a paternal uncle.
SOURCE : https://cardinals.fiu.edu/bios1327.htm#Fournier
Giovanni Battista de'Cavalieri (1525–1601),
Calcografia in Giovanni Battista Cavalieri, Pontificum Romanorum effigies, Roma,
Basa Domenico\Zanetti Francesco, 1580. Municipal
Library of Trento
Beato Benedetto XII
(Jacques Fournier) Papa
Saverdun, Francia, XIII
secolo – Avignone, Francia, 25 aprile 1342
(Papa dal 08/01/1335 al 25/04/1342)
Nato da una famiglia modesta della Contea di Foix, divenne un monaco
cistercense a Boulbonne e in seguito a Fontfroide da suo zio, Arnaud Nouvel,
che lo inviò a studiare a Parigi al collegio Saint-Bernard. Maestro di
teologia, successe a suo zio come abate di Fontfroide nel 1311. Vescovo di
Pamiers nel 1317, portò avanti attivamente la lotta contro i seguaci del
Catarismo. Nel 1326, diventa vescovo di Mirepoix e cardinale della sede di
Santa Prisca nel 1327. Soprannominato il cardinale bianco - poiché aveva
mantenuto la sua veste da cistercense - fu un uomo austero e ardente, che
intervenne con autorità in tutti i dibattiti teologici del momento: povertà
evangelica, fraticelli, visione beatifica. Su quest'ultimo punto, fisserà la
dottrina nella sua "Benedictus Deus" del 1336. Eletto Papa il 20
dicembre 1334 alla morte di Papa Giovanni XXII, fece pace con l'Imperatore
Luigi che era stato precedentemente scomunicato e per quanto possibile scese a
patti con l'Ordine Francescano, che era all'epoca in contrasto con la sede
romana. Tentato di riportare la sede pontificia a Roma nel 1335, alla fine si
accontenterà di dimorare ad Avignone, dove costruirà il primo palazzo
pontificio, la cui austerità architettonica ben riflette la personalità di
Benedetto XII. Non rifiuterà comunque di dare un certo decoro all'edificio,
motivo per cui chiamerà presso di se il pittore senese Simone Martini. Metterà
ordine nel sistema di collazione dei benefici e di conseguenza il fisco
pontificio. Presso i Cistercensi è stato considerato sin dal secolo XV quale
Beato e l’agiografo Saussay nel suo ‘Martyrologium Gallicanum’ lo pone al 25
aprile. Non risulta essere mai stata aperta la causa per ottenenrne dalla Santa
Sede la conferma di culto. Il suo corpo riposa ancora oggi nella momumentale
tomba posta nella navata sinistra della Cattedrale di Avignone.
E’ il terzo papa del
periodo avignonese; presso i Cistercensi ha avuto sin dal secolo XV un culto
come beato e l’agiografo Saussay nel suo ‘Martyrologium Gallicanum’ lo pone al
25 aprile; ma pur essendo catalogato come beato nella ‘Bibliotheca Sanctorum’,
non risulta un culto ufficiale, quindi è da considerare una venerabile figura
di testimone della fede, del suo tempo.
Il suo nome era Giacomo
Fournier ed era nato nel XIII secolo a Saverdun nella diocesi di Pamiers, il
padre era mugnaio e la madre proveniva da umile famiglia.
Giovanissimo entrò
nell’abbazia cistercense di Boulbonne, proseguì gli studi a Parigi nel collegio
dei ‘Bernardini’, dove si laureò in teologia; poi andò nell’abbazia di
Font-Froide, dove nel 1311 ne divenne abate. Sei anni dopo fu fatto vescovo di
Pamiers e nel 1326 vescovo di Mirepoix; nelle due diocesi dimostrò grande zelo
contro gli Albigesi ed i Valdesi.
Il 18 dicembre 1327 fu
elevato alla dignità cardinalizia da papa Giovanni XXII (1316-1334) e quando lo
stesso papa morì ad Avignone il 20 dicembre 1334, Giacomo Fournier venne eletto
a succedergli dai cardinali presenti ad Avignone; venne incoronato nella chiesa
dei Domenicani l’8 gennaio 1335.
Brillò, nel suo
pontificato, per sapienza, santità di vita e fortezza nel governare la Chiesa,
austero nei costumi, si preoccupò di eliminare gli abusi della corte
pontificia, obbligando i vescovi di risiedere nelle diocesi di cui avevano la
cura delle anime; vietò il cumulo dei benefici, soppresse i privilegi concessi
dai suoi predecessori, diede regole rigorose ai monaci rilassati, riformò gli
Ordini Benedettino, Francescano e Domenicano, condannò il movimento dei
“Fraticelli”.
(I ‘Fraticelli’ furono
dichiarati eretici da papa Giovanni XXII nel 1317; essi erano religiosi
dell’Ordine Francescano, fautori di un rigido rispetto della Regola della
povertà assoluta e raccolti in una setta eterodossa e scismatica; si
ricollegavano al movimento degli ‘Spirituali’, furono in un primo tempo
autorizzati da papa Celestino V nel 1294, ma poi questo privilegio fu soppresso
dal 1295 da papa Bonifacio VIII. Il loro estremismo li portò a dichiarare
eretici e decaduti sia papa Giovanni XXII, sia i vescovi che l’appoggiavano; proclamando
alcuni gruppi di essi, un proprio papa e propri vescovi; fuori dall’Italia
presero forma nei movimenti laicali dei ‘bizzochi’ o ‘beghini’).
Papa Benedetto XII
definì, a seguito di discussioni sulla visione beatifica di Dio di quel
periodo, che le anime dei bambini battezzati e le anime dei giusti, sono
ammesse subito alla visione dell’Eterno.
Come sovrano dello Stato
Pontificio, assoggettò Bologna, ebbe buoni rapporti con i principi d’Europa,
Filippo VI re di Francia, l’obbligò a vivere in Francia; gli viene rimproverato
per questo di aver fatto costruire il palazzo pontificio ad Avignone, rendendo
più problematico un’eventuale futuro ritorno a Roma; ad ogni modo le turbolenze
esistenti nella Città Capitolina, rendevano inopportuno il ritorno del papa,
anche il tentativo di portare la Curia papale almeno nell’Italia
Settentrionale, risultò inattuabile.
Fece il rifacimento dei
tetti della Basilica di S. Pietro, riordinò il governo civile di Roma;
contrario al nepotismo, non favorì i parenti, solo suo nipote Giovanni di
Cardone, persona da tutti stimata, fu promosso vescovo di Arles nel 1341.
Per la sua austerità si
fece parecchi nemici, che lo denigrarono con contumelie anche scritte, ma
Benedetto XII non raffreddò il suo zelo; nella vita privata riprendeva le vesti
monastiche cistercensi, osservando il regime del chiostro.
Morì ad Avignone il 25
aprile 1342, dopo sette anni di intenso pontificato e venne sepolto nella
cattedrale.
Autore: Antonio
Borrelli
SOURCE : http://www.santiebeati.it/dettaglio/91408
Artaud de Montor (1772–1849), The Lives and Times of the Popes (1842),
New York: The Catholic Publication Society of America, 1911.
BENEDETTO XII papa
di Giorgio Falco
Enciclopedia Italiana
(1930)
Giacomo Fournier, nato di
umile origine a Zaverdun, nella contea di Foix, professò i voti nel monastero
cisterciense di Boulbonne, e si addottorò in teologia a Parigi. Nel 1311 fu
eletto abate del monastero di Fontfroide, nel 1317 vescovo di Pamiers, nel 1326
di Mirepoix; e si distinse negli ultimi due uffici per il suo zelo nel
perseguitare gli eretici. Creato cardinale nel 1327 da Giovanni XXII, combatté
con gli scritti antiche e nuove eresie e attese in curia all'esame delle cause
d'inquisizione appellate alla Santa Sede.
Elevato alla tiara il 20
dicembre 1334, assunse il nome di Benedetto XII. Nel campo dottrinale, pose
fine con la Benedictus Deus del 29 gennaio 1336 alle questioni
suscitate da Giovanni XXII intorno alla visione beatifica. Rigido e
operosissimo nel campo disciplinare, riordinò gli uffici della curia e ne
represse gli abusi; sottopose a esame gli aspiranti ad uffici ecclesiastici;
allontanò da Avignone e impose l'obbligo della residenza agli ecclesiastici
provvisti di cura d'anime; riformò vari ordini religiosi e diede esempio del
più rigoroso disinteresse personale e familiare. Del suo favore agli studî è
prova fra l'altro la fondazione dell'università di Grenoble. Meno efficace fu
in complesso la sua opera politica. Il proposito di restituire la sede papale
prima a Roma, poi a Bologna, fu reso vano sia dall'opposizione del re di
Francia e di una parte del sacro collegio, sia dai torbidi da cui erano agitate
le due città. Fallito il disegno, egli pose mano alla costruzione del grande
palazzo d'Avignone, difeso da torri gigantesche. Tentò, sebbene con scarso
esito, di pacificare l'Italia e di reprimere abusi e violenze nello stato
pontificio, affidandone l'incarico all'arcivescovo d'Embrun, Bertrando di Deux
e a Giovanni d'Amiel. Per gl'intrighi di Filippo VI di Francia, contrario a
un'intesa tra papa e imperatore, vide fallire nel 1335 e nel 1336 le trattative
per la conciliazione intavolate da Ludovico il Bavaro, che, respinto da questa
parte, entrò nel 1337 in alleanza con Edoardo III d'Inghilterra, nemico di
Filippo, e addivenne nel 1338 alle decisioni della dieta di Rhense. La
conciliazione da lui promossa dal 1337 fra Alfonso XI di Castiglia e Alfonso IV
di Portogallo ebbe il merito di consolidare gli stati cristiani contro la
potenza araba; prive di risultato rimasero invece le trattative avviate nel
1339 dall'imperatore d'Oriente Andronico per un aiuto militare contro i Turchi,
con la promessa della riunione delle due chiese. Il 25 aprile del 1342
Benedetto moriva, lasciando fama di valente teologo e canonista, oltre che di
pontefice giusto, energico e austero.
Bibl.: G. Mollat, Les
Papes d'Avignon, Parigi 1912, p. 63 segg. e passim; J. Hergenröther, Handb.
d. Kirchengesch., 6ª ed., III, 34 segg.; Realencykl. für protest. Theol.
und Kirche, 3ª ed., II, p. 566 segg., XXIII, p. 182 seg. e rimandi ivi.
© Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata
SOURCE : https://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-xii-papa_(Enciclopedia-Italiana)/
Cromolitografia in L. Tripepi, Ritratti e biografie dei romani pontefici: da S.
Pietro a Leone 13, Roma, Vaglimigli Davide, 1879. Municipal
Library of Trento
BENEDETTO XII, papa
di Bernard
Guillemain
Dizionario Biografico
degli Italiani - Volume 8 (1966)
Giacomo Fournier,
originario di Saverdun (dipartimento dell'Ariège distretto di Pamiers) nella
contea di Foix (Francia meridionale), nacque, probabilmente tra il 1280 e il
1285, da una famiglia che non apparteneva certamente né alla nobiltà né alla
borghesia mercantile da cui erano usciti i suoi due predecessori, Clemente V e
Giovanni XXII; suo padre era forse mugnaio. Destinato alla carriera
ecclesiastica, la sua fortuna fu rappresentata dallo zio materno Arnaud Novel,
monaco cisterciense, che aveva studiato presso le scuole e ricoperto la carica
di ufficiale a Tolosa. Il nipote seguì le orme dello zio, fece la professione
nell'abbazia di Boulbonne, poi passò a quella di Fontfroide, in cui Arnaud era
divenuto abate. Fu allora inviato a Parigi al collegio S. Bernardo,
appartenente all'Ordine, a seguire gli studi di teologia; compì tutta la
carriera universitaria fino al grado di magister e insegnò ai pensionanti del
suo collegio. Nel frattempo Arnaud Novel era divenuto uno degli uomini di
fiducia di papa Clemente V; aveva ricevuto la direzione della Cancelleria e il
19 dic. 1310 era stato creato cardinale; domandò subito il privilegio di
designare lui stesso il suo successore a Fontfroide, approfittandone per
eleggere suo nipote, nel 1311.
Per alcuni anni il
giovane abate si piegò alla vita del chiostro, ma nulla ci è pervenuto di
questo periodo di preghiera e di riflessione. Egli dovette sentire quanto i
compromessi avevano attenuato il rigore della regola cisterciense, quali
ambizioni si agitavano nella mente dei monaci; forse si formò allora quella
convinzione, da lui espressa più tardi, che le sole materie che dovevano
coltivare gli studenti dell'Ordine fossero la filosofia e la teologia.
Quando Arnaud Novel stimò
che il suo protetto fosse sufficientemente maturo per iniziare una carriera più
attiva, gli fece affidare dal pontefice Giovanni XXII, il 19 marzo 1317, la
sede episcopale di Pamiers. Riuscì a vederlo ancora alla corte di Avignone,
mavenne a morte sei giorni prima che il nuovo vescovo fosse consacrato. Giacomo
Fournier non poteva contare ormai più che sulle proprie capacità.
La sua diocesi di
montagna servivadi rifugio a eretici, valdesi o albigesi, e il vescovo ne
iniziò la ricerca e la persecuzione, ciò che l'Inquisizione di Carcassonne non
era riuscita a ottenere. Si è calcolato che in sette anni egli presiedette il
suo tribunale per trecentosettanta giorni. Girava per la diocesi, ascoltava i
testimoni, interrogava i sospetti; i processi verbali delle sedute, che ci sono
stati conservati, lo mostrano attento ai dettagli della procedura, preciso,
severo, ma pronto a esporre lungamente la dottrina cattolica per convincere gli
avversari; ottenute le confessioni, allentava il suo rigore: in novantotto
processi condannò al rogo soltanto cinque eretici recidivi. Si dedicò anche
all'istruzione dei suoi fedeli: la maggior parte dei trentun sermoni, che ci
sono stati conservati in forma schematica, risalgono al periodo del suo
vescovato.
Giovanni XXII apprezzò
questo zelo, e chiamò il vescovo a partecipare al processo del celebre frate
minore Bernardo Delicieux; ebbe poi da lui la giustificazione dei suoi
interventi nella dibattuta questione della povertà che divideva l'Ordine dei
minori: Giacomo Fournier dimostrò infatti che un pontefice non era legato alle
costituzioni dei suoi predecessori in materia di disciplina. Il 3 marzo 1326 il
papa lo trasferì a Mirepoix, nella stessa regione di Pamiers, nei Pirenei,
perché riprendesse qui la lotta contro gli eretici, ma ben presto ritenne più utile
averlo stabilmente presso di lui: il 18 dic. 1327 lo nominò cardinale prete del
titolo di S. Prisca.
Giacomo Fournier divenne
così il teologo della Curia pontificia, colui che esaminava le dottrine
sospette. Partecipava ai processi, confutava gli "errori" degli
spirituali, dei gioachimiti, di Meister Eckhart; risalgono a questo periodo i
suoi trattati che ci sono stati conservati.
La questione principale
nella quale intervenne fu quella provocata dalle dichiarazioni di Giovanni XXII
sulla visione beatifica. L'opinione tradizionale era che le anime dei giusti,
dopo la morte, godessero della contemplazione diretta di Dio, anche prima del
giudizio universale, ma il papa, in una serie di sermoni, iniziati nel 1331,
l'aveva messa in dubbio, suscitando viva emozione; i nemici che Giovanni XXII
aveva tra i francescani intensificarono i loro attacchi. Il pontefice si
rivolse allora a tre riprese a Giacomo Fournier, che spiegò come il capo della
Chiesa avesse il diritto di esprimersi a titolo personale e come fossero
infondate le accuse di Michele di Cesena, Guglielmo di Occam e Bonagrazia da
Bergamo; confutò le proposizioni di Durand di Saint-Pourçain con le Decem
questiones in Durandum, intraprese uno studio De statu animarum sanctarum
ante generale iudicium, che, pur confermando le opinioni correnti, andava
tuttavia incontro, non senza coraggio, a quelle del pontefice.
La fama non aveva mutato
le abitudini austere di Giacomo Fournier, che conservò tra l'altro l'abito dei
cisterciensi, come aveva fatto Arnaud Novel, e fu soprannominato per questo il
e cardinale bianco". Il 4 dic. 1334 moriva Giovanni XXII. Dopo un
pontificato di diciotto anni, la successione si presentava difficile per molti
motivi: conflitto con Ludovico il Bavaro, che il papa si era rifiutato di riconoscere
come re e imperatore; fallimento di una politica di potenza in Italia per la
preparazione del ritorno della Santa Sede a Roma; progetto di una crociata;
lamentele contro la centralizzazione dell'amministrazione e la colonizzazione
della corte pontificia da parte dei Francesi; confusione negli Ordini
religiosi, specialmente in quello dei frati minori; turbamento suscitato dalle
polemiche sulla visione beatifica. I cardinali, che entrarono in conclave il 13
dic. 1334, erano incerti e divisi. Il 20 elessero Giacomo Fournier, che assunse
il nome di Benedetto XII.
Sembra che la scelta
rappresentasse una sorpresa: il nuovo papa non aveva alcuna esperienza di
questioni politiche, ma la sua competenza teologica, la sua attività pastorale,
la sua austerità erano atte a produrre un serio sforzo di rettitudine
dottrinale, morale e amministrativa. Il nome di Benedetto mostra come l'eletto
intendesse ispirarsi all'esempio del "patriarca dei monaci
d'Occidente"; fin dal suo primo concistoro segreto invitò i cardinali che
lo avevano eletto ad aiutarlo a "rendere produttiva la vigna del
Signore".
L'incoronazione del nuovo
pontefice ebbe luogo l'8 genn. 1335 nella chiesa dei domenicani di Avignone. B.
XII si adoperò immediatamente per eliminare gli abusi che erano stati
introdotti nel governo della Chiesa. Non si limitò solo a ordinare un'inchiesta
sulle esazioni di cui si rendevano colpevoli gli ufficiali, a riorganizzare la
polizia curiale, a stabilire il salario dei funzionari, ma si rifiutò anche di
esaminare le innumerevoli domande di favori che gli venivano presentate e
ordinò ai prelati e ai chierici che abitavano ad Avignone, senza tuttavia
avervi un incarico, di ritornare alle loro chiese. Successivamente revocò le
commende e, alla fine del 1335, le aspettative, vale a dire le concessioni di
benefici, fatte quando chi ne godeva al momento della concessione ad altra
persona era ancora in vita. Impose inoltre l'obbligo di un esame per i
candidati ai benefici.
Ma era la Chiesa intera
che egli desiderava riformare. Designò alcuni commissari per l'accertamento
dello stato del clero secolare; limitò l'importo delle tasse che i prelati
ricevevano in occasione delle visite nelle loro circoscrizioni; e, soprattutto,
formatosi lui stesso in un monastero, volle dedicarsi alla riorganizzazione
degli Ordini religiosi. In pochi mesi si succedettero le disposizioni al
riguardo: il 17 giugno 1335, con la bolla Pastor bonus, ordinava ai monaci
vaganti di entrare in qualche convento, i cui superiori erano invitati ad
accoglierli benevolmente; il 4 luglio la bolla Regularem vitam proibiva
il passaggio da un Ordine all'altro; il 12 luglio la bolla Fulgens sicut
stella imponeva ai cisterciensi, di cui il papa conosceva per esperienza
personale il modo di vita, un ritorno alle disposizioni disciplinari male
applicate e definiva un insieme di norme sulla gestione delle proprietà,
l'ammissione dei novizi e lo studio dei monaci; il 20 giugno 1336 la
bolla Summi magistri, designata spesso con il nome di
"benedettina", dava al più venerabile degli Ordini, quello di s.
Benedetto, una struttura che esso non aveva mai avuto: i monasteri venivano
suddivisi in trentadue province, gli abati dovevano riunirsi in capitolo ogni
tre anni, un monaco su venti era autorizzato a frequentare le università a
determinate condizioni. Il 28 nov. 1336 erano i frati minori a ricevere, con la
bolla Redemptor noster, una costituzione in trenta articoli: tra le molte
indicazioni, che non lasciavano in ombra né i dettagli della disciplina né gli
obblighi dei dignitari né l'organizzazione dei conventi, né lo statuto proprio
delle clarisse, una parte importante riguardava gli studi, preoccupazione
dominante nel pensiero del pontefice: la principale innovazione era costituita
dalla istituzione di scuole generali aperte a studenti scelti dai conventi
vicini in cui dovevano insegnare i frati più dotati che contemporaneamente
seguivano la carriera universitaria. Un capitolo completamente nuovo affidava
alle comunità l'elezione deicustodi e dei guardiani, che fino ad allora erano
sempre stati nominati dai provinciali. È difficile conoscere i risultati
ottenuti da queste disposizioni.
Si racconta che B. XII
avesse dichiarato che il papa, come Melchisedec., non conosceva parenti; è
certo che i membri della sua famiglia, gli amici, i compatrioti non ot.tennero
quei favori che l'esempio dei precedenti pontefici avrebbe potuto far loro sperare:
B. XII si lamentò perfino degli onori concessi dal re di Napoli a un suo
nipote, Guglielmo Fournier. Meno severamente si comportò con i cardinali, che
continuarono a usare il sistema della commenda e a raccomandare i loro clienti.
Eliminato qualche abuso,
continuò tuttavia la distribuzione dei benefici e delle dispense: B. XII nominò
direttamente i titolari di trecentoventotto vescovati o abbazie e
millecinquecentocinque cariche inferiori, in virtù delle riserve
precedentemente definite, che egli confermò nella bolla Adregimen,
promulgata fin dal 15 genn. 1335. Dopo essersi lasciato indurre a concedere
milleduecentoquaranta aspettative durante il primo anno del suo pontificato,
egli le aveva revocate: negli anni seguenti promise tuttavia lo stesso più di
ottocento benefici. Gli si è rimproverato di prolungare deliberatamente la
vacanza delle cariche che ritornavano a lui, per goderne più a lungo le
entrate, ma questi ritardi si possono anche spiegare con la preoccupazione
della scelta dei candidati adatti. Più sensibile alle debolezze umane di quanto
non si potesse pensare, il papa concesse numerose dispense a illegittimi e a
figli di preti, perché ottenessero cariche ecclesiastiche. La sua
preoccupazione di maggior rigore e austerità nel governo della Chiesa è in
fondo dimostrata dal numero degli atti emanati dalla cancelleria, notevolmente
minore di quello del pontificato precedente. Parallelamente le entrate, basate
soprattutto sullo sfruttamento dei benefici, dirninuirono, abbassandosi dalla
media annua di 228.000 fiorini di Firenze a 166.000. Ma le spese, più che
dimezzate, non oltrepassarono i 100.000 fiorini, tanto che nel 1342 il Tesoro
pontificio ammontava a un milione e 117.000 fiorini. L'amministrazione di B.
XII si dimostrò dunque prospera.
Presso i regolari
l'azione del papa non poteva esercitarsi in maniera così diretta come sulla
Curia: bisognava fare i conti con la buona volontà dei superiori e
l'attaccamento di ciascun Ordine ai propri usi. B. XII ebbe l'accortezza di
chiedere consigli e di inserire nella sua legislazione molte delle antiche
norme, ottenendo così dei risultati che la malafede dei suoi avversari è
riuscita a nascondere anche agli occhi degli storici moderni. I benedettini e i
canonici regolari di s. Agostino accettarono durevolmente l'istituzione dei
capitoli; i frati minori, nonostante alcune reticenze e nonostante le dispense
da loro richieste dopo la morte del papa riformatore, applicarono la maggior
parte delle norme della bolla Redemptor noster, che si ritrovano infatti
nelle loro successive costituzioni. Con i cisterciensi il papa fu costretto a
imporre la propria autorità su qualche abate ribelle. Presso i domenicani,
invece, incontrò tanti ostacoli che rinunciò a dar loro un regolamento che
aveva poca probabilità di essere rispettato. Lasciò semplicemente che
adottassero alcune delle norme della bolla da lui diretta ai francescani. Non
si può dunque fare un bilancio negativo della riforma degli Ordini religiosi
che rappresentò la sua più notevole iniziativa, anche se la minuziosità e la
secchezza dei testi non erano certo adatte a un rinnovamento profondo di queste
istituzioni.
La Chiesa che B. XII
voleva più austera non era però diversa, fondamentalmente, da quella che si era
andata configurando dall'inizio del sec. XIV. La dominano i Francesi e tra
questi quelli della Francia meridionale che parlavano la lingua d'Oc: nel 1342
essi contano quindici cardinali di fronte a tre italiani e a un castigliano, e
hanno la maggioranza delle cariche nell'amministrazione centrale. Per converso,
il regno di Francia ha il 60% dei benefici e versa le imposte corrispondenti;
in sette anni una diocesi francese ricorre in media 24 volte, contro 9 per una
diocesi del regno di Arles, 6 per una diocesi della penisola iberica, 5 per una
diocesi tedesca o inglese; all'Italia sono state inviate soltanto 550 lettere
riguardanti i benefici sulle 4002 del registro.
Furono perfezionati i
metodi di governo instaurati da Giovanni XXII, particolarmente attento ai
problemi organizzativi della Chiesa. La Penitenzieria fu regolata dalla
bolla In agro dominico dell'8 apr. 1338; nel 1340 si precisò il
funzionamento del tribunale della Sacra Rota; dal 1341 tre scribi, presi dalla
Camera apostolica e chiamati secretarii, furono incaricati della redazione
dei documenti più importanti.
La rettitudine
amministrativa fu un riflesso della rettitudine personale dei papa, che si
manifestò ancor meglio nel campo in cui Giacomo Fournier aveva dimostrato la
sua particolare competenza: la teologia. Pose fine alla controversia sulla
visione beatifica; richiesti molti pareri, il 29 genn. 1336 promulgò la
costituzione Benedictus Deus: dopo il giudizio, a cui ciascun'anima è
sottoposta dopo la morte, le anime dei dannati vanno all'Inferno, quelle dei
giusti salgono al Cielo, vivono con il Cristo, contemplano l'Essenza divina con
una visione intuitiva e diretta; questa beatitudine continuerà eternamente dopo
il giudizio universale. Era un articolo di fede - Quando gli segnalarono che
gli Armeni, ai quali egli aveva inviato aiuti, professavano dottrine erronee,
B. XII ne fece redigere un elenco comprendente 117 punti e ne reclamò la
ritrattazione. La minaccia dei Turchi ottomani indusse gli imperatori d'Oriente
a lasciar sperare una riunione delle Chiese in cambio degli aiuti di uomini e
di denaro dall'Occidente; ma, avendo il monaco greco Barlaam enumerato le
questioni che avrebbero dovuto essere discusse in un concilio generale, B. XII
rispose che i Bizantini dovevano solo tornare all'ortodossia romana senza
discutere.
Parallelamente il papa
cercava di espandere l'influenza della Chiesa di Roma. Fin dall'inizio del sec.
XIV gli immensi territori dell'impero mongolo, che si stendevano dalla Russia
meridionale alla Cina, parevano sempre offrire un campo per l'evangelizzazione.
In Persia e in Cina era stata costituita una gerarchia cattolica. In risposta a
un'ambasceria del Gran Khan, B. XII nel 1338 inviò una delegazione di religiosi
guidata dal frate minore Nicola Bonet, e in seguito dal suo compagno Giovanni
Marignolli di Firenze; il gruppo, al quale il papa aveva affidato numerose
lettere contenenti tra l'altro un'esposizione della dottrina cristiana, fu
accolta benevolmente da Özbek, Khan di Kiptchak, e attraverso le piste
dell'Asia centrale giunse a Pechino nel 1342; il suo capo tornò dalla missione
soltanto nel 1352, quando cioè cominciava a sfasciarsi l'impero mongolo e con
esso il sogno della conversione dell'Asia.
A queste linee di
politica organizzativa interna e di presenza presso popoli non cristiani faceva
riscontro una politica temporale che ricercava le vie dell'accordo e della
pacificazione. A tal fine B. XII consacrò il 5,6% delle spese a interventi che
avevano assorbito oltre i due terzi del bilancio di Giovanni XXII. Il ritorno
del papa a Roma non doveva né poteva essere per B. XII quello di un sovrano
vittorioso, ma quello di un messaggero pacifico. Nel 1335 egli dichiarò davanti
ad ambasciatori romani la sua intenzione di ritornare nei suoi Stati: pensava
di stabilirsi dapprima a Bologna.
Il giovane Petrarca,
preoccupato, gli indirizzò allora un'epistola in latino in cui Roma,
rappresentata da una vecchia signora, gloriosa ma addolorata, supplicava il suo
sposo pontificio di aver pietà della sua miseria. Al papa vennero confermate la
carica di senatore e la nomina dei principali ufficiali municipali.
Ma ormai da più di
trent'anni risultava ben chiaro che il pontefice non poteVa tornare in Italia
se non fossero maturate certe condizioni di ordine e di sicurezza., dapprima
all'interno degli Stati della Chiesa, quindi all'estemo. Il 6 maggio 1335 fu
inviato nel Patrimonio l'arcivescovo d'Embrun, Bertrando di Déaulx; egli
esaminò l'amministrazione dei rettori, cambiò il personale, promulgò due
costituzioni per eliminare gli abusi. Ma i baroni, feudatari della Chiesa
romana, non furono domati. Essi dominavano in pratica la Romagna e la Marca
Anconitana. Mentre nel sud della penisola il papa cercava di convincere il re
Roberto di Napoli, suo vassallo, ad adattarsi alla vicinanza del re di Trinacria,
invincibile nell'isola di Sicilia, cercò - dal momento che ai suoi occhi
l'impero era Vacante e che Ludovico il Bavaro era in quel momento impotente a
far sentire il suo peso nel nord d'Italia - di fare dei signori italiani degli
alleati del papato: i Della Scala furono riconosciuti vicari per Verona e
Vicenza, i Gonzaga per Mantova, gli Este per Modena, i Visconti per Milano, in
cambio del versamento di sussidi o del rifornimento di truppe. Le tracce dello
scisma nel quale le città erano state trascinate da Ludovico il Bavaro furono
cancellate. Ma questa riconciliazione, ottenuta spesso faticosamente, dato che
l'accordo con i Visconti fu concluso solo il 15 maggio 1341, portò al
riconoscimento e al consolidamento delle Signorie. Lo stesso riconoscimento del
fatto compiuto assunse significato più grave a Bologna: la città, che si era
data alla Chiesa nel 1327, nel 1334 aveva cacciato il legato di Giovanni XXII;
mentre B. XII aspettava che essa implorasse perdono, il 28 ag. 1337 si affidava
proprio a uno degli istigatori della ribellione, Taddeo Pepoli. Il papa lanciò
allora la scomunica e l'interdetto, accettando tuttavia in seguito una
conciliazione: nel 1340 i Bolognesi prestarono il giuramento di fedeltà al
rappresentante del papa, impegnandosi a pagare un censo, e Taddeo Pepoli si
tramutò in amministratore dei diritti e dei beni della Chiesa a Bologna.
Quanto al viaggio in
Italia non se ne cominciarono nemmeno i preparativi. B. XII sapeva che Roma era
agitata dalle lotte tra le famiglie dell'aristocrazia, e si limitò a
testimoniare il suo interesse ordinando il rifacimento della copertura della
basilica di S. Pietro, opera molto costosa, ricordata da un'iscrizione.
Convinto che non era ancora giunto il momento del ritorno a Roma, nell'aprile
del 1335 cominciò i lavori agli edifici in cui aveva abitato Giovanni XXII e
nel giugno del 1336 manifestò il suo proposito di costruire ad Avignone
"un palazzo speciale in cui il pontefice romano potrà abitare quando e per
quanto tempo riterrà necessario". Il suo predecessore si era riservato la
casa del vescovo; B. XII diede a quest'ultimo una nuova residenza e,
completamente libero, affidò al suo compatriota Pierre Poisson l'incarico di
sostituire il vecchio edificio con un castello più vasto e meglio difeso,
chiamato ora "Palazzo vecchio" per distinguerlo dal "Palazzo
nuovo", costruito sotto Clemente VI.
La pianta fu tracciata
intorno a un cortile, circondato da una galleria; solamente l'ala orientale si
prolungava verso sud fino a una grande torre dove si trovava l'appartamento
privato del pontefice. All'esterno l'aspetto dell'edificio era quello di una
fortezza, all'interno quello di un monastero. La decorazione, riservata solo ad
alcuni ambienti fu ridotta a tralci di vite o di quercia, con piccoli animali,
su fondo unito. Simone Martini, giunto ad Avignone nel 1340 con numerosi
artisti toscani, non lavorò al palazzo del pontefice: era stato infatti
invitato dai cardinali italiani meno attivi dei loro colleghi nelle faccende
amministrative e più di loro amanti dell'arte.
Le incertezze della
politica italiana non furono i soli motivi del prolungarsi del suo soggiorno
sulle rive del Rodano. La situazione dell'Occidente richiedeva tutta
l'attenzione del pontefice procurandogli tuttavia preoccupazioni e dispiaceri.
La sua elezione aveva indotto Ludovico il Bavaro a tentare un riavvicinamento:
giunsero ad Avignone ambasciatori tedeschi, ma le rimostranze del re di Francia
e del re di Napoli impressionarono B. XII che pose condizioni inaccettabili.
Nel 1338, alla presenza dei principi elettori, dei nobili e dei rappresentanti
delle città, fu proclamata a Rhens e a Francoforte l'indipendenza del potere
imperiale dal papato. Marsilio da Padova e Guglielmo di Occam fornirono le
giustificazioni teoriche del nuovo diritto; i dissidenti francescani,
rifugiatisi a Monaco, denunciarono l'indegnità del papa, facendo appello a un
concilio generale, e l'alto clero, colpito dall'interdetto che pesava sulla
Chiesa tedesca, sostenne Ludovico.
L'ostilità del monarca
francese accellerò il riavvicinamento di Ludovico il Bavaro e di Edoardo III
d'Inghilterra: nel 1337 fu conclusa un'alleanza segreta; nel 1338 l'imperatore
concesse al suo alleato le prerogative di vicario imperiale. Edoardo III poteva
così intraprendere la guerra contro la Francia con il pretesto della confisca
del suo feudo di Guienna e della rivendicazione della Corona di Francia assunta
dai Valois.
B. XII aveva sentito
approssimarsi la tempesta: aveva di placare Edoardo, favorendo la tregua tra
Inglesi e Scozzesi, e facendo poi ritardare l'occupazione della Guienna da
parte di Filippo VI. Una volta iniziate le ostilità, non cessò di mandare
ambasciatori ai belligeranti, per proporre tregue d'armi: nel 1338 e nel 1339
ottenne che fosse differita la prima spedizione inglese, e preparò poi la
tregua di Esplechin del 1340. Ma frattanto Edoardo III era sbarcato; la flotta
francese fu distrutta all'Ecluse presso Bruges e i Fiamminghi si schierarono
con gli Inglesi.
Gli storici hanno spesso
giudicato severamente l'azione di B. XII che avrebbe paralizzato il re di
Francia, suo alleato, senza danneggiare seriamente i suoi nemici. In effetti,
il papa non aveva i mezzi per imporre la pace; intuiva, non senza ragione, la
debolezza della casa di Valois; si cullava in vane speranze, e fu crudelmente
deluso. Il tragico sviluppo del contrasto anglo-francese, che portò alla guerra
dei Cento anni, impedì l'organizzazione di quella crociata, che Filippo VI
aveva accettato di guidare e dal cui impegno, nel 1336, B. XII aveva dovuto
liberarlo. Questi insuccessi furono solo in piccola parte ricompensati dalla
riconciliazione della Castiglia, del Portogallo e della Navarra, e dal
pagamento del censo feudale, dovuto alla Santa Sede, da parte dell'Aragona per
la Corsica e la Sardegna.
B. XII, che nel 1340 era
stato immobilizzato da ulcere alle gambe, morì di cancrena il 25 apr. 1342. La
sua tomba, opera di Jean Lavenier di Parigi, fu posta nella cattedrale di
Avignone.
Si è rimproverato a B.
XII di essere stato uno sciocco, di parlare volgarmente, di ubriacarsi: profilo
tracciato da cronisti italiani, come il Villani, e da francescani ribelli. Egli
ci appare semplice, senza pretese, lavoratore, dedito alle abitudini della vita
monastica. Compose un ampio commentario del Vangelo di s. Matteo ed ebbe
rispetto per la cultura: a lui si deve la fondazione delle università di Verona
e di Grenoble. Il suo buon senso gli dava una visione esatta delle cose, per
cui riuscì, per esempio, a districarsi dall'infelice discussione sulla visione
dei beati tanto che nessuno vi tornò più su. Trasformò la residenza di fortuna
di cui Giovanni XXII si era contentato in una sede più comoda, adatta a
un'amministrazione sempre più oculata, e capì che la centralizzazione era
intollerabile se investita dagli scandali. Ma gli mancarono l'ampiezza di
vedute, lo stile del capo, lo splendore, e, in realtà, la sua opera non
modificò né lo Stato della Chiesa né il corso della politica europea.
Fonti e Bibl.: Per una
bibliogr. completa si rinvia a G. Mollat, Les Papes d'Avignon. 1305-1378, Paris
1965, ad Indicem. Gli studi dedicati al periodo del papato avignonese
chiariscono l'originalità del pontificato di B. XII: E. Déprez, Les
préliminaires de la guerre des Cent Ans. La Papauté, la France et
l'Angleterre (1328-1342), Paris 1902, passim; E. Dupré-Theseider, I papi
di Avignone e la questione romana, Firenze 1939, pp. 76-81 e passim; B.
Guillemain, La cour pontificale d'Avignon. 1309-1376. Etude d'une
société, Paris 1962, ad Indicem; L. H. Labande, Le palais des Papes et
les monuments d'Avignon au XIVème siècle, Aix-Marseille 1925, passim; Y. Renouard, La
Papauté à Avignon, Paris 1954; Les relations des papes d'Avignon et des
compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378, Paris 1941, ad
Indicem; E. Stengel, Avignon und Rhens, Weimar 1930, passim.
Su B. XII ìn particolare
si vedano ancora le seguenti opere: Die Ausgaben der apostolischen Kammer
unter Benedikt XII., Klemens VI. und Innocenz VI (1335-1362), a c. di K.
H. Schäfer, in Vatikanische Quellen zur Geschichte der Päpstlichen Hof-und
Finanzverwaltung, III, Paderborn 19 14, pp. 1 - 170; Die Einnahmen der
Apostol. Kammer unter Benedikr XII., a c., di E. Göller, ibid., IV, ibid.
1920; Bullaire de l'Inquis. franç. au XIVème siècle, a c. di J. M. Vidal,
Paris 1913, pp. 209-278; Benoît XII. Lettres closes, patentes et
curiales se rapport. à la France, a c. di G. Daumet, Paris 1899-1920; Benoît
XII. Lettres closes... intéressant les pays autres que la France, a c. di J. M.
Vidal e G. Mollat, Paris 1913-1952; Benoît XII. Lettres communes, a c. di
J. M. Vidal, Paris 1903-19 11; Le registre d'inquisition de Jacques
Fournier, a c. di J. Duvernoy, Toulouse 1965; S. Baluze, Vitae paparum
Avenionensium (1305-1394) a c. di G. Mollat, Paris 1916-1922, ad
Indices. Vedi fra le biogr.: L. Jadin, in Dict. d'Hist. et de
Géogr. Ecclés., VIII, Paris 1935, coll. 116 ss.; X. Le Bachelet, in Dictionnaire
de Théologie catholique. II, coll. 653-704; P. Fournier, in Histoire
littéraire de la France, XXXVII, Paris 1938, pp. 174-209. Su aspetti
particolari della vita di B. XII, vedi: J. M. Vidal, Notice sur les
oeuvres de Benoît XII, in Revue d'histoire ecclés., VI (1905), pp. 556
ss., 785 ss.; K. Jacob, Studien über Papst Benedikt XII., Berlin
1910; J. B. Mahn, Le pape Benoît XII et les Cisterciens, Paris 1949; B.
Guillemain, La politique bénéficiale du pape Benoît XII, Paris 1952; C.
Schmitt, Un pape réformateur et un défenseur de l'unité de l'Eglise.
Benoît XII et l'ordre des frères Mineurs, Quaracchi 1959; E. Castelnuovo, Un
pittore italiano alla corte di Avignone, Torino 1962, ad Indicem; Enc.
Ital., VI, pp. 611 s.
© Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata
SOURCE : https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-benedetto-xii_(Dizionario-Biografico)/
Henri Auguste César
Serrure, Ritratto di papa Benedetto XII (prima metà del XIX secolo),
olio su tela; Avignone (Francia), Palazzo dei Papi
Henri
Auguste César Serrur (1794–1865), Portrait du pape Benoît XII, Palais des Papes
BENEDETTO XII
di Bernard Guillemain - Enciclopedia dei Papi (2000)
Giacomo Fournier,
originario di Saverdun (dipartimento dell'Ariège, distretto di Pamiers) nella
Contea di Foix (Francia meridionale),
nacque, probabilmente tra il 1280 e il 1285, da una famiglia che non
apparteneva certamente né alla nobiltà né alla borghesia mercantile da cui
erano usciti i suoi due predecessori Clemente V e Giovanni XXII; suo padre era
forse mugnaio.
Destinato alla carriera
ecclesiastica, la sua fortuna fu rappresentata dallo zio materno, Arnaud Novel,
monaco cisterciense, che aveva ricoperto la carica di ufficiale dell'Ordine
a Tolosa. Il
nipote seguì le orme dello zio, fece la professione nell'abbazia di Boulbonne,
poi passò a quella di Fontfroide, in cui Arnaud era divenuto abate. Fu allora
inviato a Parigi al
collegio S. Bernardo, appartenente all'Ordine, a seguire gli studi di teologia;
compì tutta la carriera universitaria fino al grado di "magister" e
insegnò ai pensionanti del suo collegio. Nel frattempo Arnaud Novel era
divenuto uno degli uomini di fiducia di Clemente
V; aveva ricevuto la direzione della Cancelleria e il 19 dicembre 1310 era
divenuto cardinale; domandò subito il privilegio di designare lui stesso il suo
successore a Fontfroide, approfittandone per eleggere il nipote, nel 1311.
Per alcuni anni il
giovane abate si piegò alla vita del chiostro, ma nulla ci è pervenuto di
questo periodo di preghiera e di riflessione. Egli dovette sentire quanto i
compromessi avevano attenuato il rigore della Regola cisterciense, quali
ambizioni si agitavano nella mente dei monaci; forse si formò allora quella
convinzione, che espresse più tardi, che teologia e filosofia fossero le sole
materie che dovevano coltivare gli studenti dell'Ordine. Quando Arnaud Novel
stimò che il suo protetto fosse sufficientemente maturo per iniziare una
carriera più attiva gli fece affidare dal pontefice Giovanni
XXII, il 19 marzo 1317, la sede episcopale di Pamiers. Riuscì a vederlo ancora
alla Corte di Avignone,
ma venne a morte sei giorni prima che il nuovo vescovo fosse consacrato.
Giacomo Fournier non poteva contare ormai più che sulle proprie capacità. La
sua diocesi di montagna serviva di rifugio a eretici, Valdesi o Albigesi, e il
vescovo ne iniziò la ricerca e la persecuzione, ciò che l'Inquisizione di Carcassonne non
era riuscita a ottenere. Si è calcolato che in sette anni egli presiedette il
suo tribunale per trecentosettanta giorni. Girava per la diocesi, ascoltava i
testimoni, interrogava i sospetti; i processi verbali delle sedute, che sono
arrivati a noi lo mostrano attento ai dettagli della procedura, preciso,
severo, ma pronto a esporre lungamente la dottrina cattolica per convincere gli
avversari; ottenute le confessioni, allentava il suo rigore: in novantotto
processi condannò al rogo soltanto cinque eretici recidivi. Si dedicò anche
all'istruzione dei suoi fedeli: la maggior parte dei trentuno sermoni, che si
sono tramandati in forma schematica, risalgono al periodo del suo vescovato.
Giovanni XXII apprezzò
questo zelo, e chiamò il vescovo a partecipare al processo del celebre frate
minore Bernardo Délicieux; ebbe poi da lui la giustificazione dei suoi
interventi nella dibattuta questione della povertà che divideva l'Ordine dei
Minori: Giacomo Fournier dimostrò infatti che un pontefice non era legato alle
costituzioni dei suoi predecessori in materia di disciplina. Il 3 marzo 1326 il
papa lo trasferì a Mirepoix, nella stessa regione di Pamiers, nei Pirenei,
perché riprendesse qui la lotta contro gli eretici, ma ben presto ritenne più
utile averlo stabilmente presso di lui: il 18 dicembre 1327 lo nominò cardinale
prete del titolo di S. Prisca.
Giacomo Fournier divenne
così il teologo della Curia pontificia, colui che esaminava le dottrine
sospette. Partecipava ai processi, confutava gli "errori" degli
Spirituali, dei Gioachimiti, di Meister Eckhart; risalgono a questo periodo i
suoi trattati che si sono conservati.
La questione principale
nella quale intervenne fu quella provocata dalle dichiarazioni di Giovanni XXII
sulla visione beatifica. L'opinione tradizionale era che le anime dei giusti,
dopo la morte, godessero della contemplazione diretta di Dio, anche prima del
giudizio universale, ma il papa, in una serie di sermoni, iniziati nel 1331,
l'aveva messa in dubbio, suscitando viva emozione; i nemici che Giovanni XXII
aveva tra i Francescani intensificarono i loro attacchi. Il pontefice si
rivolse allora a tre riprese a Giacomo Fournier, che spiegò come il capo della
Chiesa avesse il
diritto di esprimersi a titolo personale e come fossero infondate le
accuse di Michele da
Cesena, Guglielmo di Occam e Bonagrazia da Bergamo; confutò le proposizioni di
Durand di St-Pourçain (Durando di S. Porciano con le Decem questiones in
Durandum, intraprese uno studio De statu animarum sanctarum ante generale
iudicium che, pur confermando le opinioni correnti, andava tuttavia incontro,
non senza coraggio, a quelle del pontefice.
La fama non aveva mutato
le abitudini austere di Giacomo Fournier, che conservò tra l'altro l'abito dei
Cisterciensi, come aveva fatto Arnaud Novel, e fu soprannominato per questo il
"cardinale bianco". Il 4 dicembre 1334 moriva Giovanni XXII. Dopo un
pontificato di diciotto anni la successione si presentava difficile per molti
motivi: conflitto con Ludovico il Bavaro, che il papa si era rifiutato di
riconoscere come re e imperatore; fallimento di una politica di potenza
in Italia per
la preparazione del ritorno della Santa
Sede a Roma; progetto
di una crociata; lamentele contro la centralizzazione dell'amministrazione e la
colonizzazione della Corte pontificia da parte dei Francesi; confusione negli
Ordini religiosi, specialmente in quello dei Frati
Minori; turbamento suscitato dalle polemiche sulla visione beatifica. I
cardinali, che entrarono in conclave il 13 dicembre 1334, erano incerti e
divisi. Il 20 elessero Giacomo Fournier, che assunse il nome di Benedetto XII.
Sembra che la scelta
rappresentasse una sorpresa: il nuovo papa non aveva alcuna esperienza di
questioni politiche, ma la sua competenza teologica, la sua attività pastorale,
la sua austerità erano atte a produrre un serio sforzo di rettitudine dottrinale,
morale e amministrativa. Il nome di Benedetto mostra come l'eletto intendesse
ispirarsi all'esempio del "patriarca dei monaci d'Occidente"; fin dal
suo primo Concistoro segreto invitò i cardinali che lo avevano eletto ad
aiutarlo a "rendere produttiva la vigna del Signore".
L'incoronazione del nuovo
pontefice ebbe luogo l'8 gennaio 1335 nella chiesa dei Domenicani di
Avignone. B. si adoperò immediatamente per eliminare gli abusi che erano
stati introdotti nel governo della Chiesa. Non si limitò solo a ordinare
un'inchiesta sulle esazioni di cui si rendevano colpevoli gli ufficiali, a
riorganizzare la polizia curiale, a stabilire il salario dei funzionari, ma si
rifiutò anche di esaminare le innumerevoli domande di favori che gli venivano
presentate e ordinò ai prelati e ai chierici che abitavano ad Avignone, senza
tuttavia avervi un incarico, di ritornare alle loro chiese. Successivamente
revocò le commende e, alla fine del 1335, le aspettative, vale a dire le
concessioni di benefici, fatte quando chi ne godeva al momento della
concessione ad altra persona era ancora in vita. Impose inoltre l'obbligo di un
esame per i candidati ai benefici. Ma era la Chiesa intera che egli desiderava
riformare. Designò alcuni commissari per l'accertamento dello stato del clero secolare;
limitò l'importo delle tasse che i prelati ricevevano in occasione delle visite
nelle loro circoscrizioni; e, soprattutto, formatosi lui stesso in un
monastero, volle dedicarsi alla riorganizzazione degli Ordini religiosi. In
pochi mesi si succedettero le disposizioni al riguardo: il 17 giugno 1335, con
la bolla Pastor bonus, ordinava ai monaci vaganti di entrare in qualche
convento, i cui superiori erano invitati ad accoglierli benevolmente; il 4
luglio la bolla Regolarem vitam proibiva il passaggio da un Ordine all'altro;
il 12 luglio la bolla Fulgens sicut stella imponeva ai Cisterciensi, di cui il
papa conosceva per esperienza personale il modo di vita, un ritorno alle
disposizioni disciplinari male applicate e definiva un insieme di norme sulla
gestione delle proprietà, l'ammissione dei novizi e lo studio dei monaci; il 20
giugno 1336 la bolla Summi magistri, designata spesso con il nome di "benedettina",
dava al più venerabile degli
Ordini, quello di s. Benedetto, una struttura che esso non aveva mai avuto: i
monasteri venivano suddivisi in trentadue province, gli abati dovevano riunirsi
in Capitolo ogni tre anni, un monaco su venti era autorizzato a frequentare le
Università a determinate condizioni. Il 28 novembre 1336 erano i Frati Minori a
ricevere, con la bolla Redemptor noster, una costituzione in trenta articoli:
tra le molte indicazioni, che non lasciavano in ombra né i dettagli della
disciplina, né gli obblighi dei dignitari, né l'organizzazione dei conventi, né
lo statuto proprio delle Clarisse, una parte importante riguardava gli studi,
preoccupazione dominante nel pensiero del pontefice: la principale innovazione
era costituita dalla istituzione di scuole generali aperte a studenti scelti
dai conventi vicini in cui dovevano insegnare i frati più dotati che
contemporaneamente seguivano la carriera universitaria. Un capitolo
completamente nuovo affidava alle comunità l'elezione dei custodi e dei
guardiani, che fino ad allora erano sempre stati nominati dai provinciali. È
difficile conoscere i risultati ottenuti da queste disposizioni.
Si racconta che B. avesse
dichiarato che il papa, come Melchisedec,
non conosceva parenti; è certo che i membri della sua famiglia, gli amici, i
compatrioti non ottennero quei favori che l'esempio dei precedenti pontefici
avrebbe potuto far loro sperare: egli si lamentò perfino degli onori concessi
dal re di Napoli a un suo nipote, Guglielmo Fournier. Meno severamente si
comportò con i cardinali, che continuarono a usare il sistema della commenda e
a raccomandare i loro clienti.
Eliminato qualche abuso,
continuò tuttavia la distribuzione dei benefici e delle dispense: B. nominò
direttamente i titolari di trecentoventotto vescovati o abbazie e
millecinquecentocinque cariche inferiori, in virtù delle riserve
precedentemente definite, che egli confermò nella bolla Ad regimen, promulgata
fin dal 15 gennaio 1335. Dopo essersi lasciato indurre a concedere
milleduecentoquaranta aspettative durante il primo anno del suo pontificato,
egli le aveva revocate: negli anni seguenti promise tuttavia lo stesso più di
ottocento benefici. Gli si è rimproverato di prolungare deliberatamente la
vacanza delle cariche che ritornavano a lui, per goderne più a lungo le
entrate, ma questi ritardi si possono anche spiegare con la preoccupazione
della scelta dei candidati adatti. Più sensibile alle debolezze umane di quanto
non si potesse pensare, il papa concesse numerose dispense a illegittimi e a
figli di preti, perché ottenessero cariche ecclesiastiche. La sua
preoccupazione di maggior rigore e austerità nel governo della Chiesa è in
fondo dimostrata dal numero degli atti emanati dalla Cancelleria, notevolmente
minore di quello del pontificato precedente. Parallelamente le entrate, basate
soprattutto sullo sfruttamento dei benefici, diminuirono, abbassandosi dalla
media annua di 228.000 fiorini di Firenze a
166.000. Ma le spese, più che dimezzate, non oltrepassarono i 100.000 fiorini,
tanto che nel 1342 il Tesoro pontificio ammontava a 1.117.000 fiorini.
L'amministrazione di B. si dimostrò dunque prospera.
Presso i Regolari
l'azione del papa non poteva esercitarsi in maniera così diretta come sulla
Curia: bisognava fare i conti con la buona volontà dei superiori e
l'attaccamento di ciascun Ordine ai propri usi. B. ebbe l'accortezza di
chiedere consigli e di inserire nella sua legislazione molte delle antiche
norme, ottenendo così dei risultati che la malafede dei suoi avversari è
riuscita a nascondere anche agli occhi degli storici moderni. I Benedettini e i
Canonici Regolari di S. Agostino accettarono durevolmente l'istituzione dei
Capitoli; i Frati Minori, nonostante alcune reticenze e nonostante le dispense
da loro richieste dopo la morte del papa riformatore, applicarono la maggior
parte delle norme della bolla Redemptor noster, che si ritrovano infatti nelle
loro successive costituzioni. Con i Cisterciensi il papa fu costretto a imporre
la propria autorità su qualche abate ribelle. Presso i Domenicani, invece,
incontrò tanti ostacoli che rinunciò a dar loro un regolamento che aveva poca
probabilità di essere rispettato. Lasciò semplicemente che adottassero alcune
delle norme della bolla da lui diretta ai Francescani. Non si può dunque fare
un bilancio negativo della riforma degli Ordini religiosi che rappresentò la
sua più notevole iniziativa, anche se la minuziosità e la secchezza dei testi
non erano certo adatte a un rinnovamento profondo di queste istituzioni.
La Chiesa che B. voleva
più austera non era però diversa, fondamentalmente, da quella che si era andata
configurando dall'inizio del XIV secolo. La dominano i Francesi e tra questi
quelli della Francia meridionale che parlavano la lingua d'oc: nel 1342 essi
contano quindici cardinali di fronte a tre italiani e a un castigliano, e hanno
la maggioranza delle cariche nell'amministrazione centrale. Per converso, il
Regno di Francia ha il 60% dei benefici e versa le imposte corrispondenti: in
sette anni una diocesi francese ricorre in media ventiquattro volte, contro
nove per una diocesi del Regno di Arles,
sei per una diocesi della penisola iberica, cinque per una diocesi tedesca o
inglese; all'Italia sono state inviate soltanto cinquecento lettere riguardanti
i benefici sulle quattromiladue del registro. Furono perfezionati i metodi di
governo instaurati da Giovanni XXII, particolarmente attento ai problemi
organizzativi della Chiesa. La Penitenzieria fu regolata dalla bolla In agro
dominico dell'8 aprile 1338; nel 1340 si precisò il funzionamento del Tribunale
della Sacra Rota; dal 1341 tre scribi, presi dalla Camera
apostolica e chiamati "secretarii", furono incaricati della
redazione dei documenti più importanti. La rettitudine amministrativa fu un
riflesso della rettitudine personale del papa, che si manifestò ancor meglio nel
campo in cui Giacomo Fournier aveva dimostrato la sua particolare competenza:
la teologia. Pose fine alla controversia sulla visione beatifica; richiesti
molti pareri, il 29 gennaio 1336 promulgò la costituzione Benedictus Deus: dopo
il giudizio, a cui ciascun'anima è sottoposta dopo la morte, le anime dei
dannati vanno all'Inferno, quelle dei giusti salgono al Cielo, vivono con il
Cristo, contemplano l'Essenza divina con una visione intuitiva e diretta;
questa beatitudine continuerà eternamente dopo il giudizio universale. Era un
articolo di fede. Quando gli segnalarono che gli Armeni, ai quali egli aveva
inviato aiuti, professavano dottrine erronee, B. ne fece redigere un elenco
comprendente centodiciassette punti e ne reclamò la ritrattazione. La minaccia
dei Turchi ottomani indusse gli imperatori d'Oriente a lasciar sperare una
riunione delle Chiese in cambio degli aiuti di uomini e di denaro
dall'Occidente; ma, avendo il monaco greco Barlaam enumerato le questioni che
avrebbero dovuto essere discusse in un concilio generale, B. rispose che i
Bizantini dovevano solo tornare all'ortodossia romana senza discutere.
Parallelamente il papa
cercava di espandere l'influenza della Chiesa di Roma. Fin dall'inizio del sec.
XIV gli immensi territori dell'Impero mongolo, che si stendevano dalla Russia meridionale
alla Cina, parevano sempre offrire un campo per l'evangelizzazione. In
Persia e in Cina era stata costituita una gerarchia cattolica. In risposta a
un'ambasceria del Gran khan, B. nel 1338 inviò una delegazione di religiosi
guidata dal frate minore Nicola Bonet, e in seguito dal suo compagno Giovanni
Marignolli di Firenze; il gruppo, al quale il papa aveva affidato numerose
lettere contenenti tra l'altro un'esposizione della dottrina cristiana, fu
accolto benevolmente da Özbek, khan di Qinciāq, e attraverso le piste dell'Asia
centrale giunse a Pechino nel 1342; il suo capo tornò dalla missione soltanto
nel 1352, quando cioè cominciava a sfasciarsi l'Impero mongolo e con esso il
sogno della conversione dell'Asia.
A queste linee di
politica organizzativa interna e di presenza presso popoli non cristiani faceva
riscontro una politica temporale che ricercava le vie dell'accordo e della
pacificazione. A tal fine B. destinò il 5-6% delle spese a interventi che
avevano assorbito oltre i due terzi del bilancio di Giovanni XXII. Il ritorno
del papa a Roma non doveva né poteva essere per B. quello di un sovrano
vittorioso, ma quello di un messaggero pacifico. Nel 1335 egli dichiarò davanti
ad ambasciatori romani l'intenzione di ritornare nei suoi Stati: pensava di
stabilirsi dapprima a Bologna.
Il giovane Petrarca,
preoccupato, gli indirizzò allora un'epistola in latino in cui Roma,
rappresentata da una vecchia signora, gloriosa ma addolorata, supplicava il suo
sposo pontificio di aver pietà della sua miseria. Al papa vennero confermate la
carica di senatore e la nomina dei principali ufficiali municipali.
Ma ormai da più di
trent'anni risultava ben chiaro che il pontefice non poteva tornare in Italia
se non fossero maturate certe condizioni di ordine e di sicurezza, dapprima
all'interno degli Stati della Chiesa, quindi all'esterno. Il 6 maggio 1335 fu
inviato nel Patrimonio l'arcivescovo d'Embrun, Bertrando di Déaulx; egli
esaminò l'amministrazione dei rettori, cambiò il personale, promulgò due
costituzioni per eliminare gli abusi. Ma i baroni, feudatari della Chiesa
romana, non furono domati. Essi dominavano in pratica la Romagna e
la Marca Anconetana. Mentre nel Sud della penisola il papa cercava di
convincere il re Roberto di Napoli, suo vassallo, ad adattarsi alla vicinanza
del re di Trinacria, invincibile nell'isola di Sicilia, cercò
- dal momento che ai suoi occhi l'Impero era vacante e che Ludovico il Bavaro
era in quel momento impotente a far sentire il suo peso nel Nord d'Italia - di
fare dei signori italiani degli alleati del papato: i Della Scala furono
riconosciuti vicari per Verona e Vicenza,
i Gonzaga per Mantova, gli
Este per Modena, i
Visconti per Milano,
in cambio del versamento di sussidi o del rifornimento di truppe. Le tracce
dello scisma nel quale le città erano state trascinate da Ludovico il Bavaro
furono cancellate. Ma questa riconciliazione, ottenuta spesso faticosamente,
dato che l'accordo con i Visconti fu concluso solo il 15 maggio 1341, portò al
riconoscimento e al consolidamento delle Signorie. Lo stesso riconoscimento del
fatto compiuto assunse significato più grave a Bologna: la città, che si era
data alla Chiesa nel 1327, nel 1334 aveva cacciato il legato di Giovanni XXII;
mentre B. aspettava che essa implorasse perdono, il 28 agosto 1337 Bologna si
affidava proprio a uno degli istigatori della ribellione, Taddeo Pepoli.
Il papa lanciò allora la scomunica e l'interdetto, accettando tuttavia in
seguito una conciliazione: nel 1340 i Bolognesi prestarono il giuramento di
fedeltà al rappresentante del papa, impegnandosi a pagare un censo, e Taddeo
Pepoli si tramutò in amministratore dei diritti e dei beni della Chiesa a
Bologna. Quanto al viaggio in Italia non se ne cominciarono nemmeno i
preparativi. B. sapeva che Roma era agitata dalle lotte tra le famiglie
dell'aristocrazia, e si limitò a testimoniare il suo interesse ordinando il
rifacimento della copertura della basilica di S. Pietro, opera molto costosa,
ricordata da un'iscrizione. Convinto che non era ancora giunto il momento del
ritorno a Roma, nell'aprile del 1335 cominciò i lavori agli edifici in cui
aveva abitato Giovanni XXII e nel giugno del 1336 manifestò il suo proposito di
costruire ad Avignone "un palazzo speciale in cui il pontefice romano
potrà abitare quando e per quanto tempo riterrà necessario". Il suo
predecessore si era riservato la casa del vescovo; B. diede a quest'ultimo una
nuova residenza e, completamente libero, affidò al suo compatriota Pierre
Poisson l'incarico di sostituire il vecchio edificio con un castello più vasto
e meglio difeso, chiamato ora "Palazzo vecchio" per distinguerlo dal
"Palazzo nuovo", costruito sotto Clemente
VI.
La pianta fu tracciata
intorno a un cortile, circondato da una galleria; solamente l'ala orientale si
prolungava verso sud fino a una grande torre dove si trovava l'appartamento
privato del pontefice. All'esterno l'aspetto dell'edificio era quello di una
fortezza, all'interno quello di un monastero. La decorazione, riservata solo ad
alcuni ambienti, fu ridotta a tralci di vite o di quercia, con piccoli animali,
su fondo unito. Simone
Martini, giunto ad Avignone nel 1340 con numerosi artisti toscani, non
lavorò al palazzo del pontefice: era stato infatti invitato dai cardinali italiani,
meno attivi dei loro colleghi nelle faccende amministrative e più di loro
amanti dell'arte.
Le incertezze della
politica italiana non furono i soli motivi del prolungarsi del soggiorno di B.
sulle rive del Rodano. La situazione dell'Occidente richiedeva tutta
l'attenzione del pontefice procurandogli tuttavia preoccupazioni e dispiaceri.
La sua elezione aveva indotto Ludovico il Bavaro a tentare un riavvicinamento:
giunsero ad Avignone ambasciatori tedeschi, ma le rimostranze del re di Francia
e del re di Napoli impressionarono B. che pose condizioni inaccettabili. Nel
1338, alla presenza dei principi
elettori, dei nobili e dei rappresentanti delle città, fu proclamata a
Rhens e a Francoforte l'indipendenza del potere imperiale dal papato. Marsilio
da Padova e Guglielmo da Occam fornirono le giustificazioni teoriche del nuovo
diritto; i dissidenti francescani, rifugiatisi a Monaco, denunciarono
l'indegnità del papa, facendo appello a un concilio generale, e l'alto clero,
colpito dall'interdetto che pesava sulla Chiesa tedesca, sostenne Ludovico.
L'ostilità del monarca
francese accelerò il riavvicinamento di Ludovico il Bavaro e di Edoardo III
d'Inghilterra: nel 1337 fu conclusa un'alleanza segreta; nel 1338 l'imperatore
concesse al suo alleato le prerogative di vicario imperiale. Edoardo III poteva
così intraprendere la guerra contro la Francia con il pretesto della confisca
del suo feudo di Guienna e
della rivendicazione della Corona di Francia assunta dai Valois.
B. aveva sentito
approssimarsi la tempesta: aveva cercato di placare Edoardo, favorendo la
tregua tra Inglesi e Scozzesi, e facendo poi ritardare l'occupazione della
Guienna da parte di Filippo VI. Una volta iniziate le ostilità, non cessò di
mandare ambasciatori ai belligeranti, per proporre tregue d'armi: nel 1338 e
nel 1339 ottenne che fosse differita la prima spedizione inglese, e preparò poi
la tregua di Esplechin del 1340. Ma frattanto Edoardo III era sbarcato; la
flotta francese fu distrutta all'Ecluse presso Bruges e
i Fiamminghi si schierarono con gli Inglesi.
Gli storici hanno spesso
giudicato severamente l'azione di B. che avrebbe paralizzato il re di Francia,
suo alleato, senza danneggiare seriamente i suoi nemici. In effetti, il papa
non aveva i mezzi per imporre la pace; intuiva, non senza ragione, la debolezza
della casa di Valois; si cullava in vane speranze, e fu crudelmente deluso. Il
tragico sviluppo del contrasto anglo-francese, che portò alla guerra dei Cento
anni, impedì l'organizzazione di quella crociata che Filippo VI aveva accettato
di guidare e dal cui impegno, nel 1336, B. aveva dovuto liberarlo. Questi
insuccessi furono solo in piccola parte ricompensati dalla riconciliazione
della Castiglia, del
Portogallo e della Navarra, e
dal pagamento del censo feudale, dovuto alla Santa Sede, da parte dell'Aragona
per la Corsica e
la Sardegna.
Si è rimproverato a B. di
essere stato uno sciocco, di parlare volgarmente, di ubriacarsi: profilo
tracciato da cronisti italiani, come il Villani, e da Francescani ribelli. Egli
ci appare semplice, senza pretese, lavoratore, dedito alle abitudini della vita
monastica. Compose un ampio commentario del vangelo di s.
Matteo ed ebbe rispetto per la cultura: a lui si deve la fondazione delle
Università di Verona e di Grenoble. Il
suo buon senso gli dava una visione esatta delle cose, per cui riuscì, per
esempio, a districarsi dall'infelice discussione sulla visione beatifica tanto
che nessuno vi tornò più su. Trasformò la residenza di fortuna di cui Giovanni
XXII si era contentato in una sede più comoda, adatta a un'amministrazione sempre
più oculata, e capì che la centralizzazione era intollerabile se investita
dagli scandali. Ma gli mancarono l'ampiezza di vedute, lo stile del capo, lo
splendore, e, in realtà, la sua opera non modificò né lo Stato della Chiesa né
il corso della politica europea.
Per una bibliografia
completa si rinvia a G. Mollat, Les papes d'Avignon (1305-1378),
Paris 196510, ad indicem.
Gli studi dedicati al
periodo del papato avignonese chiariscono l'originalità del pontificato di
B.: E. Déprez, Les préliminaires de la guerre des Cent Ans. La
Papauté, la France et l'Angleterre (1328-1342), ivi 1902, passim; L.H.
Labande, Le palais des papes et les monuments d'Avignon au XIVe siècle,
Aix-Marseille 1925, passim; E. Stengel, Avignon und Rhens, Weimar 1930,
passim; E. Dupré-Theseider, I papi di Avignone e la questione romana,
Firenze 1939, pp. 76-81 e passim; Y. Renonard, Les relations des
papes d'Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378,
Paris 1941, ad indicem; Y. Renouard, La Papauté à Avignon, ivi
1954; B. Guillemain, La Cour pontificale d'Avignon (1309-1376). Étude
d'une société, ivi 1962, ad indicem; F. Giunta, Benedetto XII e la
crociata, "Anuario de Estudios Medievales", 3, 1966, pp.
215-34; P. Amargier, Nullus in jureperitus in utroque: Benoît
XII-Urbain V. Aux origines de l'État moderne. Le fonctionnement de la papauté
d'Avignon, Roma 1990, pp. 33-9; B. Guillemain, Les papes d'Avignon
1359-1376, Paris 1998.
Su B. in partic. v.
ancora le seguenti opere: Benoît XII. Lettres closes, patentes et curiales
se rapportant à la France, a cura di G. Daumet, Paris 1899-1920; Benoît
XII. Lettres communes, a cura di J.M. Vidal, ivi 1903-11; J.M.
Vidal, Bullaire de l'Inquisition française au XIVe siècle [...], ivi 1913,
pp. 209-78; Benoît XII. Lettres closes, patentes et curiales intéressant
les pays autres que la France, a cura di J.M. Vidal-G. Mollat, ivi
1913-52; Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter Benedikt XII.,
Klemens VI. und Innocenz VI. (1335-1362), a cura di K.H. Schäfer, Paderborn 1914,
pp. 1-170; É. Baluze, Vitae paparum Avenionensium [...], a cura di G.
Mollat, I-IV, Paris 1914-28, ad indices; Die Einnahmen der Apostolischen
Kammer unter Benedikt XII., a cura di E. Göller, Paderborn 1920; Le
registre d'inquisition de Jacques
Fournier, a cura di J. Duvernoy, Toulouse 1965; B.
Schimmelpfenning, Zisterzensierideal und Kirchenreform-Benedikt
XII. (1334-42) als Reformpapst, Berlin 1976, pp. 11-43; L.
Boehm, Papst Benedikt XII. (1334-1342) als Förderer der Ordensstudien.
Restaurator - Reformator - oder Deformator
regulärer Lebensform?, in Secundum regulam vivere. Festschrift für P.
Norbert Backmund O. Praem., a cura di G. Melville, Windberg 1978, pp. 281-310.
V. fra le
biografie: L.
Jadin, Benoît XII, in D.H.G.E., VIII, coll. 116 ss.; Dictionnaire
de théologie catholique, II, Paris 1910, s.v., coll. 653-704; P.
Fournier, in Histoire littéraire de la France, XXXVII, Paris 1938, pp.
174-209; E. Sabbadini, Un pontefice avignonese riformatore della
Chiesa: Benedetto XII (Cistercense), "Rivista Cistercense", 2, 1985,
pp. 19-30; Benedictus XII, "Medioevo Latino. Bollettino
Bibliografico", 13, 1992, pp. 66-7.
Su aspetti particolari
della vita di B., v.: J.M. Vidal, Notice sur les oeuvres de Benoît
XII, "Revue d'Histoire Ecclésiastique", 6, 1905, pp. 556 ss., 785
ss.; K. Jacob, Studien über Papst Benedikt XII., Berlin
1910; J. B. Mahn, Le pape Benoît XII et les Cisterciens, Paris
1949; B. Guillemain, La politique bénéficiale du pape Benoît XII, ivi
1952; C.
Schmitt, Un pape réformateur et un défenseur de l'unité de l'Église.
Benoît XII et l'ordre des frères Mineurs, Quaracchi 1959; E. Castelnuovo, Un
pittore italiano alla corte di Avignone, Torino 1962,
ad indicem; F.J. Felten, Die Ordensreformen Benedikts XII. unter
institutionen-geschichtlichem Aspekt, in Institutionen und
Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterliche Befunde, a cura di
G. Melville, Köln 1992, pp. 369-435.
G.
Falco, Benedetto XII, in Enciclopedia Italiana, VI, Roma 1930,
pp. 611 s.; New Catholic Encyclopaedia, II, Washington 1967,
s.v., pp. 275-76; Lexikon für Theologie und Kirche, II, Freiburg 1994³,
s.v., coll. 207-08; Dizionario storico del Papato, a cura di Ph.
Levillain, I, Milano 1996, s.v., pp. 162-63.
SOURCE : http://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-xii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/
Jean Duvernoy, « Benoît XII
et le pays de Foix », Cahiers
de Fanjeaux Année 1991 26 pp.
19-37 Fait partie d'un numéro thématique : La
papauté d'Avignon et le Languedoc : https://www.persee.fr/doc/cafan_0575-061x_1991_act_26_1_1517
Pope Benedict XII
91334-1342), The Guardian of Orthodoxy, edited by Irene Bueno : https://assets.ctfassets.net/4wrp2um278k7/53PvCheqRiCYWceYAiq48m/db8d907c7bccd1ddb119551ce5aede4c/9789048538140_ToC___Intro.pdf
Benedetto XII, 197° Papa della Chiesa Cattolica : https://www.vatican.va/content/benedictus-xii/it.html

.jpg)