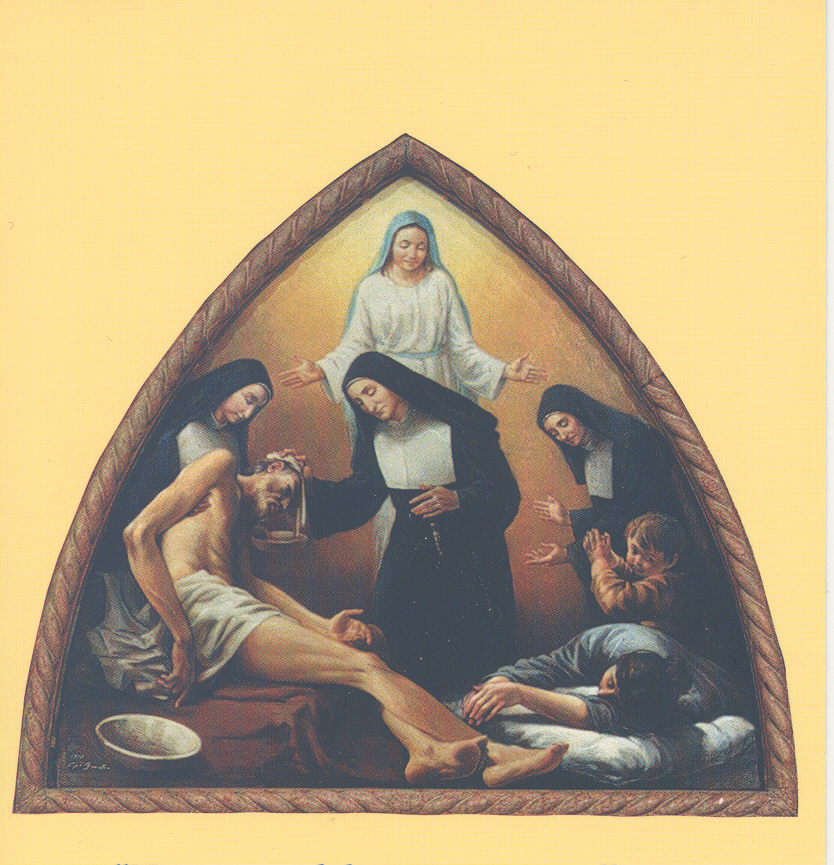Bienheureuse Vincenza Maria Poloni
Fondatrice
des religieuses de la Miséricorde de Vérone (✝ 1855)
Fondatrice des
Sœurs de la Miséricorde de Vérone, Vincenza Maria Poloni (1802-1855), a été
béatifiée le 21 septembre 2008.
Blessed Luigia Poloni
Also
known as
- Mother
Vincenza Maria
- 11 November
- 10 September (Sisters of Mercy of Verona as the anniversary of the
profession of the first Sisters)
Profile
Baptized on the day of her birth, the youngest of the twelve children, she was raised in a
pious family, the daughter of a small businessman who ran a combination pharmacy and grocery in the heart of Verona, Italy. When her fathers died, Luigia took over the
family finances. Spiritual student of Blessed Charles Steeb. Nun. Co-founder, with Blessed Charles Steeb of the Sisters of
Mercy of Verona to work with
the elderly and with abandoned girls; the first group of
sisters organized on 2 November 1840, and made their first
profession on 10 September 1848. The Sisters continue their good work today in Italy, Germany, Portugal, Albania, Tanzania, Angola, Burundi, Argentina, Brazil, Chile, and have been joined
by the affiliated Laity of
Mercy.
Born
- 26 January 1802 in Verona, Italy
- 11 November 1855 in Verona, Italy of cancer
- 28 April 2006 by Pope Benedict XVI (decree on heroic virtues)
- Sunday 21 September 2008 by Pope Benedict XVI
- beatification recognition celebrated at Verona, Italy presided by Cardinal Angelo Amato
BEATA VINCENZA MARIA POLONI
(1802-1855)
Il
26 gennaio 1802, a Verona, all’attuale numero civico 8 di Piazza delle Erbe,
nasceva la Serva di Dio Vincenza Maria Poloni da Gaetano e Margherita Biadego.
Nel pomeriggio dello stesso giorno veniva battezzata nella Parrocchia di S.
Maria Antica presso le Arche Scaligere col nome di Luigia Francesca Maria.
Ultima
di dodici fratelli dei quali nove morirono in tenera età, Luigia crebbe in un
clima familiare permeato da solidi principi religiosi e da uno stile di
solidarietà verso i più deboli. Dai genitori assorbì il senso della fede, della
preghiera e della laboriosità e ricevette un grado di istruzione adeguato alla
sua condizione sociale.
Giovane
di aperto e di vivace ingegno, divenne il braccio destro della mamma nella cura
della casa, il sostegno insostituibile nell’educazione dei numerosi nipoti,
l’assistente premurosa di una cognata spesso malata e l’aiuto principale nel
negozio del padre. Anche Il fratello Apollonio, trovò nella sorella Luigia un
valido appoggio per la gestione e amministrazione della complessa attività
agricola in località Palazzina (Verona).
Sotto
la direzione spirituale del Beato Carlo Steeb il suo cuore andava assecondando
i richiami dello Spirito Santo che la conduceva con sempre maggior trasporto a
dedicare tempo ed attenzione alle persone anziane e malate croniche presso il
Pio Ricovero cittadino. Nel 1836, durante una terribile epidemia di colera,
diede prova di incondizionata abnegazione nel reparto detto “sequestro”
mettendo a repentaglio la sua stessa vita.
Intanto
la volontà di Dio andava facendosi sempre più chiara: gli anziani e i malati
costituivano il corpo di Cristo sofferente a cui si donava generosamente e al
quale voleva attrarre altre compagne.
Superate
le non poche resistenze poste dai famigliari che ritenevano ancora
indispensabile la sua presenza in famiglia, il 2 novembre 1840 la Poloni si
stabilì con tre compagne in due stanzette presso il Pio Ricovero per dedicarsi
a tempo pieno al servizio degli anziani e malati.
Gli
inizi delle opere di Dio sono sempre caratterizzati dallo zelo del donarsi e da
una generosa povertà scelta consapevolmente. Quelle quattro persone assunsero
subito lo stile di vita di una comunità religiosa scandita da un orario severo,
da fervente preghiera, e da un totale servizio di carità verso gli altri. Ben
presto si aggiunsero altre compagne, fu acquistata una casa, si ottennero le
autorizzazioni civili e canoniche e così il 10 settembre 1848 Luigia Poloni
insieme ad altre dodici sorelle emise i voti religiosi di povertà, castità ed
obbedienza assumendo il nome di Vincenza Maria.
L'Istituto
Sorelle della Misericordia di Verona diventava una realtà. Una nuova sorgente
di luce e di amore sgorgava in Verona, città di santi e beati.
Madre
Vincenza Maria, nei quindici anni da lei vissuti dopo la fondazione
dell’Istituto, esercitò con zelo ammirabile la sua missione di assistenza agli
anziani, malati e fanciulli orfani. Con la saggezza che derivava dal suo
temperamento, dall'esperienza di vita in famiglia e soprattutto dalla fedeltà
allo Spirito, reggeva la Comunità che, nel frattempo andava espandendosi
raggiungendo - alla sua morte - il numero di 48 sorelle.
Con
l’esempio della vita e con l’insegnamento, raccomandava alle sue figlie la
rettitudine nell’agire, la tenerezza verso le ammalate, la pazienza nelle
tribolazioni, l’umiltà nel riconoscere i propri errori, la carità verso il
prossimo, soprattutto verso i poveri. Era solita dire: “I poveri sono i
nostri padroni: amiamoli e serviamoli come serviremmo Gesù Cristo stesso in
persona”.
Sopportò
con fede e con fiducia nella divina Provvidenza difficoltà e sacrifici. Coltivò
la preghiera, l’amore all’Eucaristia, la devozione all’Addolorata, ai
Sacratissimi Cuori di Gesù e di Maria. Nutrì, inoltre, una particolare
devozione nei confronti di San Vincenzo De’ Paoli, il santo cui il Beato Carlo
Steeb si ispirò nello stendere le Regole per l’Istituto che stava per sorgere.
La
fama del nuovo Istituto si diffondeva anche fuori Verona e a Madre Vincenza
Maria giungevano ben presto richieste di sorelle per un servizio di
misericordia da altre città e paesi. Le prime comunità furono aperte a Cologna
Veneta, Montagnana, Zevio, Este e Monselice.
Negli
ultimi anni della sua vita, Madre Vincenza Maria venne colpita da un tumore
che, lentamente ma inesorabilmente, la consumava. Sopportò il dolore con
cristiana fortezza e in silenzio per non essere di peso alle sorelle. Si
sottopose all'intervento chirurgico e alla cura ancor più dolorosa del
'caustico' senza anestesia.
Trascorse
gli ultimi dieci giorni di vita in edificante preparazione alla morte,
confortata dalla presenza del suo direttore spirituale, don Carlo Steeb, che le
somministrò il sacramento degli infermi.
Entrò
nell'eternità alle ore 9 dell’11 novembre 1855 lasciando alle sue Figlie
il tesoro dei suoi esempi ed un mirabile testamento spirituale nel quale
raccomandava con tutte le forze la carità. Quelle parole sembrano scritte con
il suo sangue ed hanno ancor oggi il fascino di un eroismo raggiunto dal suo
impegno di conformità a Cristo. La sua figura costituisce una fulgida luce che
ci addita il cammino sicuro della santità.
Questa
perla non poteva rimanere nascosta per cui diciamo il nostro grazie alla Chiesa
che, dopo scrupoloso esame storico e teologico, ha riconosciuto ufficialmente
il 28 aprile 2006 l'esercizio delle virtù eroiche di madre Vincenza Maria
Poloni e il 17 dicembre 2007 la guarigione miracolosa di suor Virginia
Agostini avvenuta per sua intercessione nel 1939.
Oggi
la nostra gioia è piena perché madre Vincenza Maria è ufficialmente proclamata
Beata dalla Chiesa. Una nuova sorella ci viene offerta come esempio e come
protettrice.
BEATA VINCENZA MARIA POLONI
I testi che seguono
approfondiscono aspetti della vita, della spiritualità e della carità della beata Vincenza Maria Poloni che
hanno caratterizzato il suo modo di incarnare il carisma della misericordia.
Omelia alla beatificazione di Vincenza Maria Poloni di Mons. Angelo Amato.
Omelia alla beatificazione di Vincenza Maria Poloni di Mons. Angelo Amato.
Personalità e spiritualità della Poloni dalla Positio Poloni, Parte II, cap. XX
Serve una carezza Conferenza di A. Pronzato
Vincenza M. Poloni presentata all’USMI-CISM di VR relazione di sr. Annapia Paro
Vincenza M. Poloni Relazione di madre Teresita Filippi al ritiro
dei sacerdoti di Verona
Le virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza in Vincenza Maria Poloni Positio Poloni
Beata Vincenza Maria (Luigia)
Poloni Religiosa
Verona, 26 gennaio 1802 – 11 novembre 1855
Quando le prime Sorelle
della Misericordia giunsero a Mantova, verso la fine del 1800, avevano
sicuramente ancora vivo il ricordo di Madre Vincenza che nel 1855, dopo aver
inutilmente combattuto contro la malattia, le aveva lasciate a don Carlo Steeb,
ormai avanti con l’età, e alla loro forza interiore, la forza che lo Spirito
aveva suscitato in loro con la stessa vocazione alla vita religiosa.
Ma quel seme, che portava impresso in sé più che le parole l’esempio della
madre, fortificato come essa voleva nella preghiera, nell’abbandono alla
Provvidenza, in uno spirito di sacrificio e in uno stile ascetico, non poteva
non crescere forte e solido fino ai nostri giorni.
Ancora oggi le Sorelle della Misericordia sono presenti a Mantova:
nell’educazione con la scuola dell’infanzia “Mons. Martini”, nell’assistenza
agli anziani con la R.S.A. “Casa Pace”, con la comunità “Mons. Martini” di
piazza Stretta, con l’impegno nelle attività di pastorale della parrocchia del
Duomo e con il volontariato presso la Casa Circondariale di Mantova.
Qualche nota biografica
Madre Vincenza, al secolo Luigia Poloni, nacque a Verona, in piazza delle
Erbe, il 26 gennaio 1802 e fu battezzata lo stesso giorno nella vicina chiesa
di Santa Maria Antica alle Arche Scaligere.
Ultima di 12 figli, Luigia cresce in un ambiente cristiano e fervorosamente
impegnato nella carità. Il padre, droghiere, apparteneva alla Fratellanza cioè
a quella che oggi definiremmo una “associazione di volontariato” rivolta in
modo particolare ai concittadini che, a causa dei continui scontri tra
l’esercito francese e quello austriaco che allora si contendevano la città,
versavano nei più diversi bisogni.
L’attenzione agli altri, lo spirito di sacrificio, uno sguardo attento
accompagnato da mani operose, un servizio puntuale ma mai umiliante sono
sicuramente i tratti che Luigia ha acquisito con l’educazione, fondati su “quei
valori che danno credibilità e spessore alla fede”.
Nulla di eclatante e molta “ferialità” nei gesti di Luigia: la carità ha mille
nomi e altrettanti volti; come i cerchi di un’onda, si espande ovunque in ugual
misura ed è proprio per questo che tutti coloro che ne sono toccati
percepiscono che il cuore della carità è la gratuità.
Nella giovinezza Luigia, che aiuta il papà nelle attività caritative, conosce
don Carlo Steeb. Questi, proveniente dal luteranesimo, era divenuto cattolico
tutto d’un pezzo: sacerdote zelante soprattutto in campo caritativo. A lui, la
giovane Luigia confida le sue aspirazioni profonde, i desideri che la animano e
soprattutto quella costante ricerca della volontà di Dio che è il presupposto
di ogni cammino di santità.
Sarà proprio don Carlo a proporle, dopo averla messa a lunga prova nel servizio
alle persone anziane e ammalate del ricovero cittadino, di diventare
“Fondatrice” di un Istituto religioso che si prendesse cura dei “poveri e
bisognosi di aiuto”. “Mani pietose” - la chiamava don Carlo - quella famiglia
di Sorelle della Misericordia che da molto tempo era il suo desiderio per
concretizzare e rendere visibile la sua esperienza interiore: la misericordia.
A questo si è sentita chiamata Luigia che dice il suo sì a Dio con la
professione religiosa il 10 settembre 1848 in cui assume il nome di Vincenza
Maria.
Il carisma della misericordia
Don Carlo Steeb, scrivendo la regola per le religiose dell’Istituto, evidenzia
nel mistero dell’Incarnazione e della Redenzione, il modello più alto per
coniugare la misericordia. Gesù Cristo “l’unigenito Figlio di Dio” per amore
dell’umanità si fa “carne” e risolleva l’uomo portandolo alla piena comunione
con Dio.
Misericordia è proprio un movimento di discesa e di ascesa, un “annullare le
distanze”, un farsi “tutto a tutti pur di salvare a ogni costo qualcuno” -
usando le parole dell’apostolo Paolo -, quel rendersi “prossimi” che permette di
comprendere fino in fondo la vita dell’altro per rivelargli la profonda dignità
dell’essere “figli di Dio” che è la grandezza della persona umana. Misericordia
è appassionarsi all’uomo; è “curvarsi” su di lui nella certezza che il servizio
è rivolto a Cristo stesso.
Una santità a misura d’uomo
Una straordinaria ordinarietà. “Un giorno di ordinaria follia” l’avrebbe
chiamato il regista Joel Schumacher… solo che la follia dei giorni di madre
Vincenza, il cui regista era solo Dio, non era che l’amore in “frammenti”. Una
carità spicciola, concreta, fatta più di gesti che di parole, obbediente alla
parola evangelica: “l’avete fatto a me”.
Un percorso, quello di madre Vincenza, che conosce solo tre “segnaletiche”: una
profonda vita interiore che fa di Cristo il perno della ruote della sua vita;
un grande amore a Dio e all’Eucaristia, per cui la preghiera scandisce le ore
del suo donarsi come il sole le ore di un giorno; e infine uno stile di umiltà,
semplicità e carità che orienta l’agire solo a Dio, amato e servito nel
prossimo sofferente.
Oggi le Sorelle della Misericordia, oltre che in Italia sono presenti in
Germania, Portogallo, Albania, Tanzania, Angola, Burundi, Argentina, Brasile,
Cile. Accanto alle religiose, ormai da alcuni anni sta crescendo anche la famiglia
dei Laici della Misericordia: uomini e donne che traducono la tenerezza di Dio
nella famiglia, nei luoghi di lavoro e di impegno sociale secondo la comune
logica di sempre: il qui e ora.
Il Rito di Beatificazione della
Venerabile Serva di Dio ha avuto luogo a Verona domenica 21 settembre 2008.
Rappresentante del Santo Padre è stato il Prefetto della Congregazione delle
Cause dei Santi.
La Congregazione delle Sorelle della Misericordia di Verona la festeggia il 10
settembre.
Madre
Vincenza M. Poloni
Madre Vincenza Maria Poloni, al secolo Luigia, nasce
a Verona il 26 gennaio 1802. La sua casa è situata in Piazza delle Erbe,
cuore della città, dove i genitori gestiscono una drogheria-farmacia. La
famiglia, ispirata a profondi principi cristiani e provata da parecchi eventi
dolorosi, è per Luigia l’ambiente stimolante e formativo. E’ la madre la sua
prima formatrice. Il padre, droghiere e farmacista, assieme alla moglie, dà
esempio di virtù cristiane e sociali, prestandosi come membro stimato e
influente del gruppo di coloro che sostengono la Pia Casa di Ricovero.
L’intelligenza pratica, concreta e perspicace di Luigia, la riservatezza e la
cortesia che le sono proprie, favoriscono in lei l’attitudine al servizio
attento e gratuito. Negli anni più belli della sua giovinezza essa lo offre ai
fratelli in seria necessità e ai numerosi nipoti che la considerano come una
“mamma”.
Dopo la morte del padre, gravi problemi economici scuotono l’equilibrio della
famiglia, per cui Luigia mette in atto anche le sue capacità amministrative e
direttive senza trascurare la frequenza, come volontaria, alla Pia Casa di
Ricovero, dove assiste le malate croniche nelle infermerie. Nel 1836, presta il
suo servizio volontario anche alle colerose accolte nell’ambiente d’isolamento
a loro destinato.
E’ guidata spiritualmente da don Carlo Steeb, suo confessore, al quale confida
il suo desiderio di consacrarsi totalmente al Signore. Lui la fa attendere a
lungo e, alla fine, le rivela: “Figlia mia, il Signore vi vuole
fondatrice di un Istituto di Sorelle della Misericordia, nessuna difficoltà vi atterrisca
o arresti; a Dio nulla è impossibile”. Luigia accoglie con timore
la proposta e, con semplicità e confidenza filiale nel Padre misericordioso,
risponde: “Io sono la più inetta delle creature, ma il Signore si serve, alle
volte, di strumenti debolissimi per le opere sue: sia fatta dunque la sua
volontà”.
Il 2
novembre 1840, sostenuta e accompagnata da don Carlo Steeb,
Luigia con alcune altre compagne dà inizio all’Istituto Sorelle
della Misericordia. Il 10 settembre 1848 esse emettono la
professione religiosa: ricevono l’abito religioso, il crocefisso, la corona del
rosario e la Regola. A ciascuna è dato un nome nuovo, simbolo della nuova vita
consacrata a Dio.
Il suo servizio, umile e prezioso, presso le persone anziane e le ragazze
abbandonate, trova la sua più alta espressione in quello di madre e maestra di
numerose giovani che, alla sua scuola, imparano a consacrare, in umiltà, semplicità e carità la loro vita a Dio come sorelle della
misericordia.
Madre Vincenza Maria Poloni muore l’11 novembre 1855 lasciando come suo Testamento spirituale, espressione del suo affetto per
le sorelle, una sola cosa: la carità.
Viene dichiarata beata il 21 settembre 2008 con decreto di papa Benedetto XVI.
La sua festa
liturgica si
celebra il 10 settembre, giorno della prima professione di madre Vincenza Maria
Poloni e di 12 sue sorelle nel 1848.
Preghiera di intercessione alla beata Vincenza Maria Poloni, fondatrice delle
Sorelle della Misericordia, per ottenere grazie
Beata Vincenza María
(Luigia) Poloni
«Solidaridad
y fe al servicio de los débiles»
MADRID,
domingo 11 noviembre 2012 (ZENIT.org).- Ofrecemos el santo
del día por nuestra colaboradora Isabel Orellana Vilches. Esta vez es la beata
italiana Vicenta María, oriunda de Verona, fundadora de las Hermanas de la
Misericordia.
Nació en
Verona (Italia) el 26 de enero de 1802. Creció en medio del infortunio alentada
por la robusta fe de sus padres. Inteligente y capaz, sensible ante las
adversidades, supo ser motivo de descanso para su generosa familia cuando de
doce hijos habidos en el seno de su hogar, fueron muriendo uno tras otro
sobreviviendo tres, y sostuvo los negocios familiares con gran talento y
agudeza.
De su padre,
integrado en una asociación benéfica, aprendió la riqueza que esconde el
desprendimiento acogiéndolo para sí. Su discreción y espíritu de servicio
fueron apreciados tanto en el comercio que regentaba como en el asilo de Verona
donde realizaba labores de voluntariado con los ancianos. Conocía en carne propia
el zarpazo del sufrimiento, su valor purificativo, el cúmulo de enseñanzas que
conlleva humanas y espirituales, y había adquirido el sentimiento de
solidaridad universal que aglutina a quienes han pasado por él. Sus entrañas de
misericordia serían manifiestas de forma singular en la obra que le aguardaba y
de la que sería artífice.
Fue Carlos
Steeb, su director espiritual, quien se percató de la grandeza humana y
espiritual de la joven que tenía en la oración uno de los pilares de su vida, y
entrevió la misión a la que estaba destinada. Atento a los signos, como es
propio de los grandes apóstoles, la alentaba a seguir el sendero de la
perfección a la espera de que se manifestase la voluntad divina sobre ella.
Durante la epidemia de cólera fue evidente que la acción de la futura fundadora
no era un acto solidario, sino que iba acompañada de un cariz de ternura con
los damnificados en el que latía el amor divino.
Carlos Steeb
que conocía su valía y era sabedor de las virtudes que le adornaban, le propuso
fundar el Instituto de Hermanas de la Misericordia, que ella emprendió
humildemente en 1840, sintiendo el peso de su indigencia y confiada en la
gracia de Dios: «… El Señor se
sirve, a veces, de los instrumentos más débiles para llevar a cabo sus designios:
que se cumpla su voluntad», hizo notar. Volcada
durante quince años en niños, ancianos y enfermos, desahuciados y abandonados,
culminó su vida, tras un cáncer de mama que no superó, el 11 de noviembre de
1855.
El beato P.
Steeb no dejó abandonadas a las religiosas sino que sostuvo la obra hasta su
muerte. Vicenza fue beatificada el 21 de septiembre de 2008.
NOVIEMBRE 11, 2012 00:00ESPIRITUALIDAD Y ORACIÓN