Ambito
calabrese, Gioacchino da Fiore con l'aureola (1573), affresco;
Santa Severina, Concattedrale di Sant'Anastasia
Gioacchino da Fiore, fresco, 1573, Cathedral of Santa Severina, Calabria, Italy
Ambito
calabrese, San Francesco da Paola e Gioacchino da Fiore con
l'aureola (1573), affresco; Santa Severina, Concattedrale di Sant'Anastasia
Bienheureux Joachim de
Flore
Abbé (+ 1202)
- site de la famille cistercienne
"Né en Calabre, Joachim fut d'abord page à la cour de Roger de Sicile. Après un voyage en Terre Sainte, il se fit prédicateur ambulant.
Il entra chez les Cisterciens de Sambucina, puis devint abbé de Corazzo en 1177. Il quitta sa charge et devint solitaire non loin de l'abbaye.
En 1183, il s'installa à Flore avec quelques compagnons. La règle de vie qu'il rédigea était plus rigoureuse que celle des cisterciens, et en 1194 il se sépara pour créer un l'Ordre de Flore. Les Constitutions furent approuvées par le pape Célestin III en 1196. On estime qu'il initia ainsi le premier mouvement de réforme que connut l'Ordre Cistercien dans sa longue existence."
- texte envoyé par Jean Devriendt, thèse de théologie 2001
"...Il a aussi pris part aux querelles de son temps au sujet de la
Trinité. Sa théologie trinitaire fut condamnée et jugée hérétique par le
Concile de Latran IV en 1215, cependant, pour ses vertus et la qualité de sa
vie monastique, Honorius III le déclara 'bienheureux' en 1223..."
SOURCE : https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1242/Bienheureux-Joachim-de-Flore.html
Bienheureux Joachim de
Flore.
Né en Calabre, Joachim
fut d'abord page à la cour de Roger de Sicile. Après un voyage en Terre Sainte,
il se fit prédicateur ambulant.
Il entra chez les
Cisterciens de Sambucina, puis devint abbé de Corazzo en 1177. Il quitta sa
charge et devint solitaire non loin de l'abbaye.
En 1183, il s'installa à
Flore avec quelques compagnons. La règle de vie qu'il rédigea était plus
rigoureuse que celle des cisterciens, et en 1194 il se sépara pour créer un
l'Ordre de Flore. Les Constitutions furent approuvées par le pape Célestin III
en 1196. On estime qu'il initia ainsi le premier mouvement de réforme que
connut l'Ordre Cistercien dans sa longue existence.
Après sa mort en 1202,
l'Ordre continua à prospérer et à fonder de nouvelles maisons, mais uniquement
dans la péninsule italienne. Cette vitalité extraordinaire fit que l'ordre
compta jusqu'à 40 maisons et quelques monastères féminins vers 1250.
Malheureusement, suite à
l'instabilité politique consécutive à la mort de Frédéric II en 1250, suite à
l'apparition des ordres mendiants comme les Franciscains, suite à la commende
qui fut introduite dans certains monastères... nombre de monastères vécurent
une lente agonie avant leur extinction définitive.
Les quelques communautés
qui survécurent se rattachèrent à l'Ordre de Cîteaux en 1570, avec
l'approbation du pape Saint Pie V.
Seules Flore et Fonte
Laureato subsistèrent à la fin du XVIIIème siècle. Elles disparurent à
leur tour sous le régime napoléonien d'Italie (1806-1809).
SOURCE : http://www.abbayes.fr/histoire/cisterciens/joachim_de_flore.htm
Medieval engraving of Joachim of Fiore (also known as Joachim of Flora), a benedictine monk and milenarist philosopher. 15th-century woodcut
Bienheureux Joachim de
Flore Abbé (env.1130-1202)
Le 30 mars 1202 meurt
dans l’ermitage calabrais de Saint Martin à Pietrafitta Joachim de Flore, moine
cistercien, puis fondateur d’un Ordre qui porta son nom.
Joachim naquit à Celico,
en Calabre, vers 1130. À 30 ans environ, il quitta sa profession pour se rendre
en Terre Sainte, où il se mit à approfondir ce goût des Écritures qu’il
n’abandonna plus jamais.
De retour dans sa patrie,
après un temps passé en ermitage, il entra chez les cisterciens de Corazzo, où
il devint abbé en 1177. Mais bien vite, Joachim se convainquit du fait que le
monachisme traditionnel n’était plus en mesure de faire face à la crise que
traversait alors la société civile autant que le monde ecclésiastique. C’est la
raison qui le poussa à créer, avec quelques compagnons et la protection des
empereurs normands de Sicile, un Ordre nouveau, dépendant du monastère de San
Giovanni in Fiore. Attaqué par les cisterciens, qui se sentaient trahis par
leur abbé calabrais, mais défendu par des papes et des empereurs, Joachim
mourut dans l’ermitage où il avait décidé de vivre ses derniers jours : il
laissait un trésor inestimable et particulièrement original de commentaires
bibliques.
Témoin d’une radicale
pauvreté évangélique, prédicateur d’une Église humble et « servante du Seigneur
» au milieu de la violence des Croisades, Joachim entra dans l’histoire pour sa
théologie animée d’un grand souffle trinitaire, et surtout pour ses prophéties
sur l’imminence de « l’époque de l’Esprit », qui inspireront bien des
mouvements de réforme religieuse au XIII è siècle.
Lecture
Mais nous qui sommes les
derniers quant aux mérites et dans le temps, que pouvons-nous offrir de plus
quand la grande abondance des dons de celui qui nous a précédés est déjà
anticipée ? Rien à dire à cet égard, aucun besoin ne nous menace ; il reste,
toutefois, une sorte de poids que nous aussi, les derniers, nous avons à
porter. Il nous revient la charge d’exhorter l’Église à l’écoute ; de
l’exhorter à ouvrir les yeux ; de l’exhorter à faire retour sur elle-même, pour
chercher l’unité puisque, absorbée par de multiples distractions, elle a perdu
de son élan. Il faut l’exhorter, dis-je, à faire retour sur soi, à être
vigilante et à demeurer en son sein, pour qu’elle tourne son oreille vers les
épithalames.
Car il est proche le
temps des noces : qu’elle oublie son peuple et la maison de son père ! Ses
lampes allumées, qu’elle ouvre la cérémonie nuptiale !
(Joachim de Flore,
Prologue du Manuel sur l’Apocalypse)
SOURCE : http://jubilatedeo.centerblog.net/6573255-Les-saints-du-jour-29-Mai
Deux erreurs de Joachim
de Flore (†1202)
Première erreur : l'idée
d'un rythme trinitaire de l'histoire. Cette erreur a été corrigée par saint
Bonaventure (†1274).
« A l'époque de
saint Bonaventure, un courant de Frères mineurs, dits "spirituels",
soutenait qu'avec saint François avait été inaugurée une phase entièrement
nouvelle de l'histoire, et que serait apparu l'"Evangile éternel",
dont parle l'Apocalypse, qui remplaçait le Nouveau Testament. [...]
A la base des idées de ce
groupe, il y avait les écrits d'un abbé cistercien, Joachim de Flore, mort en
1202. Dans ses œuvres, il affirmait l'existence d'un rythme trinitaire de
l'histoire. Il considérait l'Ancien Testament comme l'ère du Père, suivie par
le temps du Fils et le temps de l'Eglise. Il fallait encore attendre la
troisième ère, celle de l'Esprit Saint. [...] Joachim de Flore avait suscité
l'espérance que le début du temps nouveau aurait dérivé d'un nouveau
monachisme.
Il est donc
compréhensible qu'un groupe de franciscains pensait reconnaître chez saint
François d'Assise l'initiateur du temps nouveau et dans son Ordre la communauté
de la période nouvelle - la communauté du temps de l'Esprit Saint, qui laissait
derrière elle l'Eglise hiérarchique, pour commencer la nouvelle Eglise de
l'Esprit, qui n'était plus liée aux anciennes structures.
Il existait donc le
risque d'un très grave malentendu sur le message de saint François, de son
humble fidélité à l'Evangile et à l'Eglise, et cette équivoque comportait une
vision erronée du christianisme dans son ensemble.
Saint Bonaventure, qui,
en 1257, devint ministre général de l'Ordre franciscain, se trouva face à une
grave tension au sein de son Ordre même, précisément en raison de ceux qui
soutenaient le courant mentionné des "Franciscains spirituels", qui
se référait à Joachim de Flore. [...]
Saint Bonaventure
repousse l'idée du rythme trinitaire de l'histoire. Dieu est un pour toute l'histoire
et il ne se divise pas en trois divinités. En conséquence, l'histoire est une,
même si elle est un chemin et - selon saint Bonaventure - un chemin de progrès.
Jésus Christ est la
dernière parole de Dieu - en Lui Dieu a tout dit, se donnant et se disant
lui-même. Plus que lui-même, Dieu ne peut pas dire, ni donner. L'Esprit Saint
est l'Esprit du Père et du Fils. Le Seigneur dit de l'Esprit Saint:
"...il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit" (Jn 14, 26);
"il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître" (Jn 16,
15). Il n'y a donc pas un autre Evangile, il n'y a pas une autre Eglise à
attendre. L'Ordre de saint François doit donc lui aussi s'insérer dans cette
Eglise, dans sa foi, dans son organisation hiérarchique.
Cela ne signifie pas que
l'Eglise soit immobile, fixée dans le passé et qu'il ne puisse pas y avoir de
nouveauté dans celle-ci. "Opera Christi non deficiunt, sed proficiunt",
les œuvres du Christ ne reculent pas, ne disparaissent pas, mais elles
progressent", dit le saint dans la lettre De tribus quaestionibus. »[1]
Deuxième erreur : l'usage
de ce qui est commun aux trois personnes divines (par exemple l'essence) pour
désigner en particulier une de ces personnes. Cette erreur a été corrigée par
saint Thomas d'Aquin (†1274).
« L'abbé Joachim est
tombé dans l'erreur; il affirmait que, si l'on dit: "Dieu engendre
Dieu", on peut tout aussi bien dire "L'Essence engendre
l'essence". Il considérait, en effet, qu'en raison de la simplicité divine,
Dieu n'est pas autre chose que l'essence divine. En cela, il s'abusait [...] Ce
qui est propre aux personnes peut ainsi s'attribuer au sujet "Dieu",
et l'on peut dire: "Dieu est engendré ou engendre", comme on l'a vu
précédemment. Mais le terme d'essence ne possède pas, par son mode de
signifier, d'aptitude à désigner la personne, car il signifie l'essence comme
une forme abstraite. »[2]
« Pour exprimer l'unité
entre l'essence et la personne, les saints Docteurs ont parfois forcé leurs
expressions au-delà des limites requises pour la propriété du langage. De
pareilles formules ne sont pas à généraliser, mais plutôt à expliquer;
c'est-à-dire qu'on expliquera les termes abstraits par des termes concrets, ou
même par des noms personnels.»[3]
[1] Benoit
XVI, audience du 10 mars 2010
[2] Saint
Thomas d'Aquin, Somme Théologique, I Qu.39 a.5, r
[3] Saint
Thomas d'Aquin, Somme Théologique, I Qu.39 a.5, s1
Extraits présentés par F.
Breynaert
SOURCE : http://it.mariedenazareth.com/17916.0.html?&L=0
ad
comprehensionem trina figura Trinitatis secundum Ioachim abbatum Fiorensis
Explication
du triangle trinitaire de Joachim de Flore
Bienheureux Joachim de Flore (+
1202)
Joachim naquit à Celico,
en Calabre, vers 1130. À 30 ans environ, il quitta sa profession pour se rendre
en Terre Sainte, où il se mit à approfondir ce goût des Écritures qu’il
n’abandonna plus jamais. De retour dans sa patrie, après un temps passé en
ermitage, il entra chez les cisterciens de Corazzo, où il devint abbé en 1177.
Mais bien vite, Joachim se convainquit du fait que le monachisme traditionnel
n’était plus en mesure de faire face à la crise que traversait alors la société
civile autant que le monde ecclésiastique. C’est la raison qui le poussa à
créer, avec quelques compagnons et la protection des empereurs normands de
Sicile, un Ordre nouveau, dépendant du monastère de San Giovanni in Fiore.
Attaqué par les cisterciens, qui se sentaient trahis par leur abbé calabrais,
mais défendu par des papes et des empereurs, Joachim mourut dans l’ermitage où
il avait décidé de vivre ses derniers jours : il laissait un trésor inestimable
et particulièrement original de commentaires bibliques. Témoin d’une radicale
pauvreté évangélique, prédicateur d’une Église humble et « servante du Seigneur
» au milieu de la violence des Croisades, Joachim entra dans l’histoire pour sa
théologie animée d’un grand souffle trinitaire, et surtout pour ses prophéties
sur l’imminence de « l’époque de l’Esprit », qui inspireront bien des
mouvements de réforme religieuse au XIII è siècle.
SOURCE : http://www.religion-orthodoxe.eu/article-bienheureux-joachim-de-flore-1202-75033599.html
Tabla XII del manuscrito "Liber Figurarum", "Libro de las Figuras" del Abad Joaquin de Fiore (1135-1202) con la "Disposición simbólica del Nuevo Orden -Monástico- en la Tercera Edad", "La Era del Espíritu Santo". Manuscritos en el Tiempo Liber Figurarum Tabla XII
L'Ordre du Troisième Âge, Liber Figurarum
L'Arbre de l'Humanité, Liber Figurarum
Libro
de las Figuras del Abad Joaquin de Fiore (1135-1202) con el "Arbol
de la Humanidad: De Adán a la Segunda Venida de Jesús Cristo".
Les Temps de l'Histoire, Liber Figurarum
Pagina Liber Figurarum, Drago dalle sette teste
Tabla XIb del manuscrito "Liber Figurarum", "Libro de las Figuras" del Abad Joaquin de Fiore(1135-1202) simbolizando en tres círculos la "Santísima Trinidad". El círculo de color verde simboliza al "Padre", el círculo de color azul simboliza al "Hijo",el círculo de color rojo simboliza al "Espíritu Santo". Las Cuatro Letras "IEVE", trasnscripción en latín del divino "Tetragrammaton", hacen referencia a: La "I" al "Padre", la "V" al "Hijo" y la "E" al "Espíritu Santo". La duplicidad de la "E" corresponde a que "El Espíritu Santo" procede del "Padre" y del "Hijo".
Joachim de Flore
Joachim de Flore
(Gioacchino da Fiore), né à Celico (Calabre) vers 1132/1135, du notaire Mauro
et de son épouse Gemma, est page du roi Roger II de Sicile, avant d'être, à son
tour, notaire à Palerme (1156).
Vers 1159, au cours d'un
pèlerinage en Terre Sainte, il guérit miraculeusement d'une maladie épidémique
et reçoit une révélation sur le mont Thabor ou sur le Mont des Oliviers, ce qui
le décide à se faire prédicateur ambulant. En 1168, après une retraite dans
divers ermitages, il devient prêtre cistercien à la Sambucina au nord de
Cosenza.
En 1177, il est abbé du
monastère de Corazzo qu’il fait passer sous la règle de Cîteaux.
En 1186, il se trouve
avec le pape Urbain
III dans Vérone assiégée par l’empereur Frédéric Barberousse.
En 1188, Clément
III le relève de sa charge, à sa demande, pour qu'il puisse se consacrer
à ses études.
Devenu ermite à
Pietralata, Joachim est rejoint par des disciples avec lesquels il fondera
l'abbaye de San Giovanni in Fiore (Saint-Jean-de-Flore) en 1189, puis l'ordre
de Flore en 1191 dont les constitutions seront approuvées par Célestin
III en 1196. L'ordre, protégé par l’empereur Frédéric II (1220-1250),
comptera 40 maisons et quelques monastères féminins vers 1250.
En 1198, le pape Innocent
III nomme le vieil abbé "prêcheur de la croisade (4e) pour le Sud
de l’Italie".
En 1200, Joachim soumet
publiquement tous ses écrits à Innocent III.
La vision prophétique de
Joachim de Flore se fonde sur la correspondance entre les trois personnes de
la Trinité,
trois périodes historiques et trois types d’hommes :
- l’âge du Père (de la
création à la naissance du Christ) correspond au règne des laïcs mariés, de la
Loi, de la matière ;
- l’âge du Fils
correspond à celui des clercs et de la Foi ;
- bientôt viendra l’âge
de l’Esprit, où régnera sur terre un nouvel ordre monacal (règne des saints).
Libérés de la lettre (Loi) et de la doctrine (Foi) et convertis à la pauvreté
évangélique (Joachim de Flore dénonce la simonie des clercs et l’invasion du
Temple par les marchands), les hommes vivront selon l’Esprit. L’Eglise
charnelle "dite de Pierre" (Ecclesia carnalis) se convertira en
Eglise spirituelle "dite de Jean" (Ecclesia spiritualis). Joachim,
qui croit au symbolisme des nombres et des figures géométriques, fixe à 1260 le
début de cet âge : 1260 = 42 générations de 30 ans depuis la naissance de
Jésus. Il prend au pied de la lettre les signes des temps dont il est question
dans l'Apocalypse de saint Jean. Au douzième chapitre de la Révélation, il est
question d'un dragon à sept têtes ; Joachim voit en Saladin qui enlève
Jérusalem aux Croisés en 1187, la sixième tête du dragon (la septième devant
être l'antéchrist, le
dernier persécuteur de l'âge du Fils). 1
Joachim de Flore meurt à
San Martino di Giove (Canale) le 30 mars 1202.
L’influence de Joachim de
Flore est immense dès le XIIIe siècle.
En 1215, le concile
de Latran IV condamne son Livre sur la Trinité mais ne
censure pas sa pensée dans son ensemble.
La doctrine de ses
disciples (appelés joachimites), formulée notamment dans l’Introduction à
l’Évangile éternel (1254) du franciscain Gherardo (Gérard) de Borgo San
Donnino (une compilation des oeuvres de Joachim), est interdite.
La commission d’Anagni,
en 1255, ne condamne pas les œuvres de Joachim de Flore, mais seulement
l’interprétation de San Donnino qui effraie l’institution ecclésiastique et
jette le discrédit sur la pensée de Joachim suspecté d'être un juif converti.
Les ordres mendiants
nouvellement constitués, et surtout les franciscains, croient se reconnaître
dans les moines de l’âge annoncé et, à l’approche de 1260, un mouvement
apocalyptique secoue l’Europe.
En cette année 1260,
donnée par Joachim de Flore comme début du règne des Saints, Gherardo Segarelli
fonde à Parme le groupe des apostoliques convaincu d’être le véritable ordre
mendiant qui ouvrira les portes du troisième âge. Une partie des spirituels
franciscains, que la papauté condamnera sous le nom de "fraticelles" 3,
leur est acquise.
En 1263, le concile
d'Arles, présidé par Florentin, archevêque d'Arles, condamne la doctrine de
l'Evangile éternel de Joachim de Flore.
En 1286, Honorius
IV ordonne de poursuivre la secte des apostoliques de Parme et
interdit de leur accorder l’aumône.
En 1287, le concile de
Würzburg condamne les apostoliques et les bégards.
Vers 1295, le franciscain
languedocien, Pierre de Jean Olivi (ou Olieu), reprend les conceptions de
Joachim dans "Lectura super Apocalypsim".
Le 18 juillet 1300,
Gherardo Segarelli, fondateur du groupe des apostoliques de Parme, est conduit
sur le bûcher.
Un de ses partisans,
Dolcino Tornielli de Novare, radicalise le mouvement apostolique. Il reprend la
prophétie joachimite et la rectifie. Trois périodes se sont partagé le passé :
- la première comprend
tout l’Ancien Testament ;
- la deuxième, qui va de
la venue du Christ jusqu’au pape Sylvestre
Ier, est marquée par la pénitence ;
- la troisième s’étend de
Sylvestre à Segarelli : c’est la phase de décadence de l’Église.
Une quatrième période
verra la chute de l’Église corrompue, la destruction des prêtres et des moines
et le triomphe des humbles qui ont en eux l’Esprit saint.
En 1307, les apostolici
(apostoliques), retranchés dans le Valsesia depuis 1304, sont finalement
capturés par l'armée conduite par les évêques de Novare et de Verceil : le 23
mars, Fra Dolcino (Dulcin) Tornielli est pris ; condamné comme hérétique, il
sera brûlé le 1er juin.
Adversaire des vaudois
[groupe des Pauvres du Christ ou Pauvres de Lyon fondé par Pierre Valdo (ou
Valdès ou Vaudès) dit Pierre de Vaux] qu'il trouvait aussi dangereux que
les patarins (cathares
d'Italie), Joachim n’aurait certainement pas approuvé les fraticelles (moines
franciscains hérétiques et schismatiques), les béguins de Provence et les
compagnons de Fra Dolcino (dulcinistes ou dolciniens) qui fondèrent sur ses
écrits une véritable révolte contre la Babylone romaine. Ses moines du
troisième âge ne sont ni les frères prêcheurs de Dominique ni
les frères mineurs de François,
mais de purs contemplatifs.
Quand l’ordre de Flore
s’éteint au XVIe siècle, la tentation millénariste resurgit chez les anabaptistes.
Les communautés sont rattachées à l'Ordre de Cîteaux en 1570, avec l'approbation
du pape Pie
V. Seules celles de Fiore et de Fonte Laureato subsistent à la fin du
XVIIIème siècle avant de disparaître sous le régime napoléonien d'Italie
(1806-1809).
Il nous reste de l'abbé
Joachim un certain nombre d'écrits :
- Ceux qui ont été
imprimés ont pour titre : Concordia Novi et Veteris Testamenti (Concordance
de l'Ancien et du Nouveau Testament),"Expositio in Apocalypsim (Commentaire
sur l'Apocalypse), Psalterium decem cordarum (Psautier décacorde)
et Tractatus supra quatuor Evangelia (Le traité sur les quatre
Evangiles) laissé inachevé ; les Commentaires sur Isaïe et sur Jérémie qui
lui ont été attribuées à tort au Moyen Âge, sont postérieurs et donc
apocryphes.
- Parmi ses opuscules
manuscrits, citons : Genealogia [une note, datée "1176",
dans laquelle Joachim présente l’une de ses idées maîtresses en philosophie de
l’histoire : celle de la concordance (concordia). L’histoire y est conçue comme
un arbre double : un figuier, représentant l’Ancien Testament, est greffé sur
une vigne, représentant le Nouveau Testament. Le figuier pousse durant
quarante-deux générations, d’Abraham à Azarias. La vigne greffée se prolonge, à
son tour, en se superposant au figuier le long de vingt et une générations qui
correspondent au segment de l’histoire qui court d’Azarias à Jésus Christ.
Ensuite, elle monte seule durant quarante-deux autres générations, de la
première venue du Christ jusqu’à son retour à la fin des temps 2], Prophetiae
et expositiones sibyllarum, Excerptiones e libris Joachimi de mundi fine, Epistolae
Joachimi de suis prophetiis et Revelationes.
Thomas
d'Aquin (1225-1274) réfute les théories de Joachim de Flore dans
sa Somme théologique.
L'écrivain italien, Dante
Alighieri (1265-1321), situe au "ciel du Soleil" dans la
"deuxième couronne de lumière, la flamme de l'abbé calabrais Joachim en
qui souffla l'esprit de prophétie". (La Divine Comédie, Paradis, XII,
139-141)
Joachim de Flore, dont le
culte, à un rang équivalent à celui de bienheureux, a été autorisé, au sein des
ordres de Cîteaux et de Flore, le 2 mars 1223, par le pape Honorius
III, est fêté le 29 mai.
Citations
L'argument fondamental de
sa doctrine (la doctrine de Joachim de Flore, ndlr), était que l'ère chrétienne
devait finir vers l'année 1260 et qu'une ère nouvelle devait alors commencer,
sous les auspices d'un autre révélateur, qui viendrait apportant aux peuples un
autre Evangile. Ainsi, disait-il, les trois personnes divines se sont partagé
le gouvernement des siècles : à l'empire du Père appartiennent les temps qui
ont précédé la venue du Christ ; l'empire du Fils comprend les douze siècles et
demi que doit clore l'année 1260, et à cette date les peuples passeront sous
l'empire de l'Esprit. Il ajoutait qu'on verrait alors s'opérer dans les
consciences, et simultanément dans les institutions religieuses et civiles, un
changement, un progrès semblable à celui qui avait signalé la substitution du
nouveau Testament à l'Ancien. Ainsi l'homme avait eu trois états : sous
l'empire du Père, il avait été charnel ; spirituel et charnel à la fois sous
l'empire du Fils, et devait être. entièrement spirituel sous l'empire de
l'Esprit. De là trois sociétés diverses ou la prépondérance devait tour à tour
appartenir aux guerriers, aux clercs séculiers et aux moines. (Jean-Barthélemy
Hauréau 1812-1896)
Le moine bénédictin
Joachim de Flore donne ses lettres de noblesse au millénarisme. On a dit de ses
prédictions qu’elles constituaient le système prophétique le plus influent que
l’Occident ait connu avant Marx. Fervent lecteur de l’Apocalypse, Joachim eut
une vision telle que, non seulement il mieux le passé de l’humanité, mais
s’estima en mesure de prédire son avenir. Le paradis se
trouvait au terme de cet avenir, et non plus hors du temps, dans une autre
dimension. Dans sa marche vers ce paradis, l’humanité devait franchir trois
stades correspondant aux trois personnes de la trinité. Le premier stade, celui
de Père, il l’appela ordo conjugatorium. Il était caractérisé par la famille et
l’état conjugal. Le second stade, celui du Fils, était appelé ordo monachorum.
Il avait été inauguré par saint Benoît, fondateur du premier monastère. Le
troisième stade, correspondant à l’Esprit, était celui des viri spirituales, une
petite élite de mâles, apparentée aux Parfaits cathares, constituant la sainte
avant-garde de l’humanité rachetée. Joachim croyait que l’humanité était déjà
entrée dans le troisième stade et il situait la fin du monde, c’est-à-dire
l’entrée dans le millénaire bienheureux, en l’an 1260. À ses yeux, le
développement des arts mécaniques était un excellent moyen de préparer
l’humanité aux lendemains qui chantent. (Jacques Dufresne, Après l'homme,
le cyborg ?, Multimonde, Québec, 1999)
Pour Joachim, l'histoire
constituait une véritable énigme qu'il s'agissait de déchiffrer à l'aide de
clefs, lesquelles ne pouvaient être trouvées que dans les textes sacrés.
Ceux-ci, en effet, étaient réputés issus de la main de Dieu lui-même dont il
s'agissait justement de comprendre le plan secret puisque l'histoire passée et
à venir ne pouvait qu'en découler. Dans la tradition chrétienne, ces textes
sacrés étaient répartis en deux grandes composantes qui divisaient elles-mêmes
l'histoire en deux grandes époques, soit l'Ancien Testament dominé par les
interventions d'un Dieu représenté sous la figure du Père Éternel et le Nouveau
Testament qui correspond essentiellement à la période chrétienne dominée par la
figure du Christ, le Fils du Père. Or, l'un des dogmes centraux du
christianisme est celui de la Trinité qui affirme qu'il y a trois personnes en
Dieu, soit le Père et le Fils, bien sûr, mais aussi l'Esprit-Saint. Dès lors,
puisqu'un premier « état » de l'humanité, évoqué par l'Ancien Testament, se
présente comme celui du Père et qu'un autre associé au Nouveau Testament peut
être placé sous l'égide du Fils, pourquoi n'y aurait-il pas place pour un
troisième état dans l'histoire de l'humanité qui serait celui de l'Esprit-Saint
? Bien que Joachim se soit défendu d'associer trop directement chacun de ces
états à telle ou telle personne de la Trinité, l'idée de faire ainsi appel à la
troisième personne de cette Trinité ouvrait pour lui la possibilité d'aller
au-delà du message chrétien ou, plus précisément, de le dépasser sans le renier
pour autant. En cela, il n'était que l'un de ceux qui furent ou qui devaient
être séduits par les perspectives spirituelles inépuisables offertes par
l'Esprit-Saint dont le rôle dans l'économie du salut avait, en quelque sorte,
l'avantage d'être encore à définir. Joachim, qui mettra d'ailleurs ce nouvel
état de l'humanité sous le patronage des moines, y verra l'occasion d'un
dépassement spirituel qui peut paraître bien inoffensif, mais l’idée d’un
légitime dépassement du message chrétien devait faire son chemin au sein de la
théologie puis de la philosophie de l’histoire. (Maurice Lagueux, Actualité
de la philosophie de l'histoire, p 62, Presses de l'Université Laval, Québec
2001)
Notes
1 http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Joachim_de_Flore
2 http://oliviana.revues.org/document39.html
3 Dans sa
bulle Sancta Romana du 7 octobre 1317, Jean XXII désigne les "spirituels" franciscains,
apostoliques, bégards et tenants du Libre-Esprit, sous la dénomination
officielle de "Fraticelles" :
les "fraticelles" (de l’italien "fraticelli" = petits
frères) sont les membres des ordres religieux fondés en Italie au cours du
XIIIe siècle, et tout particulièrement les franciscains ; ce nom est aussi
porté par les groupes qui se sont séparés des franciscains aux XIVe et XVe
siècles, accusant ces derniers d’avoir des vues erronées sur la notion de
pauvreté. Les spirituels (ou célestins) franciscains, qui ont été les premiers
à faire dissidence, pratiquaient un ascétisme rigoureux. De petits groupes de
fraticelles poursuivirent leurs activités pendant plus d’un siècle mais la
répression que l’Eglise exerça à leur encontre au cours du XVe siècle et la
baisse de leur popularité les firent disparaître à jamais.
Auteur : Jean-Paul
Coudeyrette
Référence publication
: Compilhistoire ;
toute reproduction à but non lucratif est autorisée.
Date de mise à jour :
23/03/2017
SOURCE : http://compilhistoire.pagesperso-orange.fr/JoachimFlore.htm
Joachim
in seinem Studierzimmer, Holzschnitt aus: Joachim von Fiore: Expositio in librum
Cirilli de magnis tribulationibus & statu sancte matris ecclesie cum
compilatione Theolosphori de Cusentia (u. a. Schriften), Venedig, B.
Benali, (1516)
Also
known as
Joachim de Floris
Joachim of Flora
Joachim the Prophet
Joachim von Fiore
Gioacchino….
Profile
Born to a middle class
family; his father was
a notary.
Page to the court of
the Norman King Roger
of Sicily. Pilgrim to Palestine. Priest. Benedictine Cistercian monk at Santa
Maria della Sambucina Abbey near Luzzi, Italy,
where he tried to reform the Order. Abbot at
Santa Maria di Corazzo Abbey in Calabria, Italy in 1176. Hermit at
Pietro Alto in 1183.
Left the Cistercian order
and founded a congregation at Fiore, Italy c.1190.
Mentioned by Dante in the Paradiso as being in heaven. Never
officially beatified,
he was been referred to as Beatus since his death.
Prolific writer on ascetics,
clerical reform, and biblical studies, including treatises on the Gospels, an
exposition on Revelations, and a concordence of the Old and New Testaments that
were based on a moment of insight he was given upon waking one Easter morning.
After his death,
his works were used to bolster the arguments of some heretics (the
Joachimites) who believed that the year 1260 would
usher in the era of the Holy
Spirit, replacing the era of Christ, a teaching condemned by the Lateran
Council of 1215.
Born
c.1130 at Celico, Calabria,
Kingdom of Naples (in
modern Italy)
30 March 1202 at Fiore, Calabria, Italy of
natural causes
Additional
Information
Saints
of the Day, by Katherine Rabenstein
books
Our Sunday Visitor’s Encyclopedia of Saints
other
sites in english
Frontline by Bernard McGinn
Lateran
IV Council at Fordham
images
fonti
in italiano
Vatican: Occasione delle Celebrazioni per l’VIII
Centenariodella Morte dell’Abate Gioacchino da Fiore
MLA
Citation
“Blessed Joachim of
Fiore“. CatholicSaints.Info. 29 March 2023. Web. 31 March 2025.
<https://catholicsaints.info/blessed-joachim-of-fiore/>
SOURCE : https://catholicsaints.info/blessed-joachim-of-fiore/
Joachim
of Flora - Vatican Library
Gioacchino
da Fiore, miniatura sec. XIV, Codice Chigiano, Biblioteca Apostolica Vaticana
Joachim of Flora
Cistercian abbot and
mystic; b. at Celico, near Cosenza, Italy,
c. 1132; d. at San Giovanni in Fiore, in Calabria, 30 March, 1202.
His father, Maurus de
Celico (whose family name is said to have been Tabellione), a notary holding
high office under the Norman kings of Sicily,
placed him at an early age in the royal Court. While on a pilgrimage to
the Holy Land, Joachim was converted from the world by the sight of some great
calamity (perhaps an outbreak of pestilence). He passed the whole of Lent in
contemplation on Mount Thabor, where he is said to have received celestial
illumination for the work of his life. Returning to Italy,
he retired to the Cistercian Abbey
of Sambucina, probably in 1159, and for some years devoted himself to lay
preaching, without taking the religious habit or receiving any orders.
The ecclesiastical
authorities raising objections to his mode of life, he took the Cistercian habit
in the Abbey of Corazzo, and was ordained priest,
apparently in 1168. He now applied himself entirely to Biblical study, with a
special view to the interpretation of the hidden meaning of the Scriptures. A
few years later, much against his will, he was elected abbot.
Finding the duties of
his office an intolerable hindrance to what he deemed his higher calling, he
appealed, in 1182, to Pope Lucius III, who relieved him of the temporal care of
his abbey,
and warmly approved of his work, bidding him continue it in whatever monastery he
thought best. He spent the following year and a half at the Abbey of Casamari,
engaged upon his three great books, and there a young monk,
Lucas (afterwards Archbishop of Cosenza),
who acted as his secretary, tells us of his amazement at seeing so famous and
eloquent a man wearing such rags, and of the wonderful devotion with which he
preached and said Mass.
The papal approbation was
confirmed by Urban
III, in 1185, and again, more conditionally, by Clement
III, in 1187, the latter exhorting him to make no delay in completing his
work and submitting it to the judgment of the Holy
See. Joachim now retired to the hermitage of Pietralata, and finally
founded the Abbey of Fiore (or Flora) among the Calabrian mountains, which
became the center of a new and stricter branch of the Cistercian
Order approved by Celestine
III in 1198. In 1200 Joachim publicly submitted all his writings to
the examination of Innocent
III, but died before any judgment was passed. It was held to be in answer
to his prayers that
he died on Holy
Saturday, "the Saturday on which Sitivit is sung, attaining
the true Sabbath,
even as the hart panteth after the fountains of waters." The holiness of
his life is unquestionable; miracles were
said to have been wrought at his tomb,
and, though never officially beatified,
he is still venerated as
a beatus on 29 May.
Dante voiced
the general opinion of his age in declaring Joachim one "endowed with
prophetic spirit." But he himself always disclaimed the title of prophet.
The interpretation of Scriptural prophecy, with reference to the history and
the future of the Church,
is the main theme of his three chief works: "Liber Concordiae Novi ac
Veteris Testamenti," "Expositio in Apocalipsim," and
"Psalterium Decem Cordarum." The mystical basis of his teaching is
the doctrine of
the "Eternal Gospel," founded on a strained interpretation of the
text in the Apocalypse (14:6).
There are three states of the world, corresponding to the three Persons of
the Blessed
Trinity. In the first age the Father ruled, representing power and
inspiring fear, to which the Old
Testament dispensation corresponds;
then the wisdom hidden through the ages was revealed in the Son, and we have
the Catholic Church of
the New
Testament; a third period will come, the Kingdom of the Holy Spirit, a
new dispensation of
universal love,
which will proceed from the Gospel of Christ,
but transcend the letter of it, and in which there will be no need for
disciplinary institutions. Joachim held that the second period was drawing to a
close, and that the third epoch (already in part anticipated by St. Benedict)
would actually begin after some great cataclysm which he tentatively calculated
would befall in 1260. After this Latins and Greeks would be united in the new
spiritual kingdom, freed alike from the fetters of the letter; the Jews would
be converted, and the "Eternal Gospel" abide until the end of the
world.
Although certain
doctrines of Joachim concerning the Blessed
Trinity were condemned by the Lateran Council in 1215, his main
teaching does not seem to have excited suspicion until the middle of the
century. Many works had meanwhile come into being which were wrongly attributed
to Joachim. Among these the "De Oneribus Prophetarum," the
"Expositio Sybillae et Merlini," and the commentaries on Jeremias and
Isaias are the most famous. The sect of
the "Joachists" or "Joachimists" arose among the
"spiritual" party among the Franciscans,
many of whom saw Antichrist already
in the world in the person of Frederick
II, nor was their faith shaken
by his death in 1250. One of their number, Fra Gherardo of Borgo San Donnino,
wrote a treatise entitled "Introductorium in Evangelium Aeternum", of
which the contents are now known only from the extracts made by the commission
of three cardinals who
examined it in 1255. From these it is clear that the Joachists went far beyond
what the abbot himself
had taught. They held that, about the year 1200, the spirit of life had gone
out of the two Testaments and that Joachim's three books themselves constituted
this "Eternal Gospel," which was not simply to transcend but to
supersede, the Gospel of Christ. The Catholic priesthood and
the whole teaching of the New
Testament was to be rendered void in a few years.
This work was solemnly condemned
by Alexander
IV, in 1256, and the condemnation involved the teaching of Joachim himself.
His central doctrine was
confuted by St.
Thomas in the Summa Theologica (I-II, Q. cvi, a. 4), and its Franciscan exponents
were sternly repressed by St.
Bonaventure. Another blow was given to the movement when the fatal year
1260 came, and nothing happened. "After Frederick
II died who was Emperor," writes Fra
Salimbene of Parma,
"and the year 1260 passed, I entirely laid aside this doctrine,
and I am disposed henceforth to believe nothing save what I see." It was
revived in a modified form by the later leader of the spiritual Franciscans,
Pier Giovanni Olivi (d. 1297), and his follower, Ubertino da Casale, who left
the order in 1317. We hear a last echo of these theories in the letters of
Blessed Giovanni dalle Celle and the prophecies of Telesphorus
of Cosenza during the Great Schism, but they were no longer taken
seriously.
Sources
Divini vatis Abbatis
Joachim Liber Concordiae novi ac veteris Testatmenti (Venice, 1519);
Expositio magni prophetae Abbatis Joachim in Apocalipsim: Eiusdem
Psalterium Decem Cordarum opus prope divinum (Venice, 1527); REUTER, Geschichte
der religiösen Aufklärung im Mittelalter, II (Berlin, 1877); TOCCO, L'Eresia
nel Medio Evo (Florence, 1884); DENIFLE, Das Evangelium aeternum und die
Commission zu Anagni in Archiv fur Litteratur- und Kirchen-Geschichte, I
(Berlin, 1885): HOLDER-EGGER, Cronica Fratris Salimbene de Adam Ordinis
Minorum (Hanover, 1905-08); WICKSTEED, The Everlasting Gospel in The
Inquirer (London, 1909); FOURNIER, Études sur Joachim de Flore et ses
doctrines (Paris, 1909). The only contemporary account is the
sketch, Virtutum B. Joachimi synopsis, by LUCAS OF COSENZA, his secretary:
but the fuller Vita by JACOBUS GRAECUS SYLLANAEUS, written in 1612,
is professedly drawn from an ancient manuscript then preserved at Fiore. Both
are printed by the Bollandists, Acta SS., May, VII.
Gardner, Edmund.
"Joachim of Flora." The Catholic Encyclopedia. Vol. 8. New York:
Robert Appleton Company, 1910. 30 Mar. 2015
<http://www.newadvent.org/cathen/08406c.htm>.
Transcription. This
article was transcribed for New Advent by Alison S. Britton. For the
Triumph of the Immaculate Heart of Mary.
Ecclesiastical approbation. Nihil
Obstat. October 1, 1910. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John
Cardinal Farley, Archbishop of New York.
Copyright © 2023 by Kevin Knight.
Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.
SOURCE : http://www.newadvent.org/cathen/08406c.htm
Joachim, Abbot of Floris
Joachim, Abbot Of Floris,
was born at Celico, in the diocese of Cosenza, about 1130. After a short
residence at the court of Roger of Sicily, he journeyed to Jerusalem, and on
his return joined the Cistercians, and became abbot of Corace (Curatium), in Calabria.
This office he resigned, however, some time after, and founded himself a
monastery at Floris, near Cosenza. Joachim died between 1201 and 1202. He
enjoyed great reputation during his life: he was reverenced by many as a
prophet, and stood in high consideration with popes and princes, but since his
day he has been very variously judged. Praised as a prophet by J.G. Syllanaeus,
and defended by the Jesuit Papebroch, he was accused of heresy by Bonaventura,
and called a pseudo-prophet by Baronius. His partisans claimed that he worked
miracles, but it appears better proved that he wrote prophecies, and denounced
in the strongest terms the growing corruption of the Romish hierarchy. He
endeavored to bring about a reformation. His character has perhaps been best
delineated by Neander (Ch. Hist. 4, 220), who says of him: "Grief
over the corruption of the Church, longing desire for better times, profound
Christian feeling, a meditative mind, and a glowing imagination, such are the
peculiar characteristics of his spirit and his writings." He complained of
the deification of the Roman Church, opposed the issue of indulgences,
condemned the Crusades as antagonistic to the express purpose of Christ, who
had himself predicted only the destruction of Jerusalem, decried the simonious
habits of the clergy, and even argued against the bestowal of temporal power on
the pope, fearing that the contentions in his day for temporal power might
ultimately result, as they eventually did, in the assumption of "spiritual
things which do not belong to him." Joachim's doctrines, however, are
somewhat peculiar. His fundamental argument is that the Christian era closes
with the year 1260, when a new era would commence under another dispensation.
Thus the three persons of the Godhead divided the government of ages among
them: the reign of the Father embraced the period from the creation of the
world to the coming of Christ; that of the Son, the twelve centuries and a half
ending in 1260, and then would commence the reign of the Holy Spirit. This
change would be marked by a progress similar to that which followed the
substitution of the new for the old dispensation. Thus man, after having been
carnal under the Father, half carnal and half spiritual under the Son, would,
under the Holy Ghost, become exclusively spiritual. So there have been three
stages of development in society, in which the supremacy belonged successively
to warriors, the secular clergy, and monks (comp. Neander, Church History,
4, 229 sq.). As Joachim found many adherents, the third Lateran Council, at the
request of Alexander III, condemned Joachim's "mystical extravagances
;" Alexander IV was still more severe in opposition to Joachim; and in
1260 the Council at Arles finally pronounced all followers of Joachim heretics.
Joachim's ideas were chiefly presented in the form of meditations on the N.T.
He strongly opposed the scholastic theology, which aimed at establishing the
principles of faith dialectically, and also the manner in which Peter Lombard
explained the doctrine of the Trinity. Towards the middle of the 13th century
these views had gained a large number of adherents. Among the many works
attributed to Joachim some are undoubtedly spurious, while others have probably
been subjected to additions, etc., in consequence of his popularity (compare
Neander, 4, 221, note). The Expositio super Apocalypsim (Venice,
1517, 4to, often reprinted), Concordioe Veteris ac Novi Testamenti libri
v (Venice, 1519, 8vo), and the Psalterium decem Chordarum appear
to be genuine. Among the others bearing his name are commentaries on Jeremiah,
the Psalms, Isaiah, parts of Nahum, Habakkuk, Zechariah, and Malachi; also a
number of prophecies concerning the popes, and predicting the downfall of the
papacy. All these were published at Venice (1519-1524) and Cologne (1577). His
Life was written by Gregory di Lauro (Naples, 1660, 4to). Among the MS. works
attributed to him, Prophetioe et Expositiones Sibyllarum; Excerptiones e
libris Joachimi de Mundi fine, de Terroribus et AErumnis, seu de pseudo-Christis;
Prophetioe de Oneribus Provinciarum; Epistoloe Joachimni de suis
Prophetiis; and Revelationes, are to be found in the public libraries
of Paris. See Hist. Litter. de la France, vol. 20; Dom Gervaise, Histoire
de l'abbé Joachim; Tiraboschi,
Storia della letter. Ital. vol. 5, 2d ed. Gregoire Laude, Vie de l'abbé Joachim; Hoefer, Nouv. Biog. Générale, 26, 718; Neander, Ch. History, 4, 215 sq. Herzog, Real-Encyklop. 6, 713 sq.; Engelhardt, Joachim, etc., in Kirchengesch. Abhandlungen (Erl. 1832).
SOURCE : https://www.biblicalcyclopedia.com/J/joachim-abbot-of-floris.html
Blessed Joachim of Fiore,
OSB Cist. Abbot (PC)
(also known as Joachim de
Floris)
Born at Celico, Calabria,
Italy, c. 1130; died 1202. Joachim was a visionary and prophet who, early in
life, adopted an ascetic life. After a pilgrimage to Palestine, he entered the
Cistercian abbey at Sambucina. In 1176, he became abbot of Corazzo, and about
1190, founded his own monastery at Fiore--a new Cistercian Congregation. His
life was marked with great piety and simplicity. He looked for a new age of the
Spirit, when the papal Church would be superseded by a spiritual Church in
which popes, priests, and ceremonies would disappear, and the Holy Spirit would
fill the hearts of all Christ's followers.
Thus, his heart was
Franciscan and, in a way, he anticipated the reforming zeal and simple faith of
the Quakers. It is not surprising that doubts were sometimes thrown upon his
orthodoxy and that many were disturbed by his original and even startling
views.
Nevertheless, he opened
the way for others to follow, and kindled a hope that ran through the medieval
world and stirred the intellect of the Church. Reformation was in the air, and
many things which he foresaw or foretold came to birth in the century that
followed, in the great days of Dominic, Francis of Assisi, and Ignatius Loyola.
A new emphasis was placed
on the work of the Holy Spirit, and after the gloom which preceded, there burst
upon the world fresh and radiant visions of saintliness and virtue, and with
them a new warmth and glow of religious life. A wave of exhilaration swept
across Europe, and in that golden age of art and genius men looked beyond the
outward forms and found in their own hearts a living and personal experience of
God.
Joachim helped to give
birth to this new mood of feeling and spontaneity, which later found song in
such words as "O Jesus, King Most Wonderful" and "Jesu, the very
thought of Thee." It was Pentecost set to music:
When once Thou visitest
the heart,
Then truth begins to
shine,
Then earthly vanities
depart,
Then kindles love divine.
O Jesus, Light of all
below!
Thou Fount of living
fire,
Surpassing all the joys
we know,
And all we can desire.
With this inner fire went
a consuming love that burned in the heart of Saint Francis and his friars, that
sent Dominic and his preachers out of their churches into the hills and
highways, and that in a thousand monasteries set up Christian communities to
care for the welfare of the people.
He was a prolific
ascetical writer. His commentary on the Book of Revelation gave his the title
"the Prophet" by which he was described by Dante: "the Calabrian
abbot Joachim, endowed with prophetic spirit" (Paradiso, XII). Thus
Joachim was among the enthusiasts, who turned for inspiration to the Bible. Unfortunately,
after his death the Franciscan Spirituals used his books to uphold their
heretical tendencies. Nevertheless, Joachim has always been given the title of
beatus, because, as a mystic and a prophet, he refreshed the life of the Church
(Benedictines, Encyclopedia, Gill).
SOURCE : http://www.saintpatrickdc.org/ss/0330.shtml
Beato Gioacchino da Fiore Abate
cistercense
Celico, Cosenza, 1130 c.
- Fiore, Cosenza, 30 marzo 1202
Gioacchino da Fiore nacque a Célico (Cosenza) intorno al 1130, da un'umile famiglia d'agricoltori o, secondo altri, da un notaio. Dopo aver visitato la Palestina, si fece frate cistercense e in seguito fu nominato abate. Tra i vari monasteri di cui fu ospite si ricorda l'abbazia di Casamari. In seguito ad una crisi spirituale, abbandonò l'ordine e dopo un periodo di eremitaggio fondò la congregazione florense, che prende titolo dal monastero di san Giovanni in Fiore, sulla Sila, dove ebbe sede, e che nel 1570 confluì nell'ordine dei cistercensi. Gioacchino morì intorno al 1202, secondo alcuni a Pietralta o Petrafitta, secondo altri a Corazzo o S. Martino di Canale o S. Giovanni in Fiore. La sua morte avvenne quando san Francesco, nella malattia della prigionia a Perugia, concepiva i primi germi della conversione tutta basata sul principio di povertà. A Gioacchino è attribuita la predizione degli ordini francescano e domenicano, nonché dei colori dei relativi abiti. Nell'ordine francescano si videro praticamente realizzate le aspettative di Gioacchino; e i francescani rigorosi (veri e propri gioachimiti) si dissero "spirituali" con tipico termine gioachimita dedotto dalla profezia relativa alla Terza Età, da lui detta "dello Spirito Santo", un'Età di rigenerazione della Chiesa e della società, col ritorno alla primigenia povertà e umiltà.
Gioacchino da Fiore può essere definito monaco, abate, teologo, esegeta, apologeta, pensatore, riformatore, mistico, filosofo, veggente, asceta, profeta. Da un lato scriveva e predicava, dall'altro si macerava in incredibili penitenze. Nel 1215 il Concilio Lateranense IV condannò una sua opinione relativa al teologo Pietro Lombardo, ma salvaguardò la persona di Gioacchino, perché egli aveva ribadito più volte la sua adesione alla dottrina cattolica e aveva chiesto d'essere corretto dai suoi confratelli o dalla Chiesa stessa, ordinando che tutti i suoi scritti venissero sottoposti al vaglio della S. Sede e dichiarando di ritenere validi solo quelli che la Chiesa stessa avrebbe approvato. Fra le sue opere è molto importante il Liber figurarum, in cui egli spiega la dottrina cattolica per mezzo di figure simboliche (due delle quali -- quella del drago a sette teste e quella dei tre cerchi trinitari -- sono presentate in questo sito, accanto alla miniatura di Gioacchino con l'aureola di santo presente nel manoscritto Chigi A.VIII.231 della biblioteca vaticana). Tale Liber è notevole anche dal punto di vista artistico: lo stesso Gioacchino, infatti, fu ritenuto bravo pittore, tanto che sono attribuite a lui l'ideazione e la realizzazione dei mosaici della basilica veneziana di S. Marco. Subito dopo la sua morte, la vox populi lo proclamò santo e i seguaci inviarono alla S. Sede la documentazione dei numerosi miracoli, ora ripubblicati da Antonio Maria Adorisio. Ciò al fine d'avviare il processo di canonizzazione.
Se da una parte la memoria della santità di Gioacchino fu inquinata da errate interpretazioni della sua dottrina, dovute sia ad avversari sia a seguaci troppo zelanti, nonché dall'attribuzione a lui di false profezie ed opinioni teologiche, dall'altra il papa Onorio III con una bolla del 1220 lo dichiarò perfettamente cattolico e ordinò che questa sentenza fosse divulgata nelle chiese. Il fervido culto popolare di Gioacchino da Fiore si diffuse presto a largo raggio. Dante Alighieri lo collocò fra i beati sapienti con queste parole: "E lucemi da lato / il calabrese abate Gioacchino / di spirito profetico dotato" (Par. XII). Inoltre Gioacchino è presentato col titolo di beato negli Acta Sanctorum compilati e pubblicati dai gesuiti bollandisti nel 1688, nonché in dizionari ed enciclopedie varie. E nel rituale dei monaci florensi esisteva la messa in onore del beato Gioacchino che veniva celebrata il 30 marzo (giorno della sua morte), il 29 maggio e in altre occasioni, come pure esisteva un'antifona dei vespri in cui si esaltava il suo spirito profetico (frase poi tradotta da Dante nella Divina Commedia). Ciò ha fatto sì che -- a quanto scrivono Emidio De Felice e Orietta Sala nei loro dizionari d'onomastica -- si deve al suo carisma la diffusione in Italia del nome personale Gioacchino.
Le sue spoglie -- di cui recentemente è stata fatta una ricognizione -- si
trovano nella cripta dell'abbazia di S. Giovanni in Fiore, comune che ha preso
il nome proprio da tale abbazia. Nel 2001 l'arcivescovo di Cosenza-Bisignano
mons. Giuseppe Agostino ha riaperto il processo di canonizzazione per portare
presto Gioacchino da Fiore alla piena gloria degli altari e -- si ritiene --
anche al titolo di "dottore della Chiesa".
Scritti di Carmelo Ciccia su Gioacchino da Fiore:
· Dante e Gioachino da Fiore, in "La sonda", Roma, dic. 1970, poi incluso nel libro: C. Ciccia, Impressioni e commenti, Virgilio, Milano, 1974
· Attualità di Gioacchino da Fiore, in "Silarus", Battipaglia (SA), genn.-febbr. 1995
· Dante e le figure di Gioacchino da Fiore, in Atti della "Dante Alighieri" a Treviso, vol. II, Ediven, Venezia-Mestre 1996
· Dante e Gioacchino da Fiore, Pellegrini Editore, Cosenza, 1997, pagg. 160
· Gioacchino da Fiore, "Avvenire", Roma, 22.XI.1997
· Un'opera di giustizia storica da parte della Chiesa ! L'auspicata beatificazione di Gioacchino da Fiore, "Parallelo 38", Reggio Calabria, genn. 1998
· Dalla parte degli studiosi / Il veltro di Dante e Gioacchino da Fiore, "Parallelo 38", Reggio Calabria, mag. 1998
· Padre Pio e l'abate Gioacchino, "Il corriere di Roma", 30.I.1999
· Recensione a Gioacchino da Fiore, invito alla lettura di Gian Luca Potestà, "La voce del CNADSI", Milano, 1.I.2000
· Pio IX e Gioacchino da Fiore, "Il corriere di Roma", 29.II.2000
· Utinam Ioachimus de Flore quam primum beatus declaretur, "Latinitas", Città del Vaticano, sett. 2000
· È ingiusto emarginare Gioacchino da Fiore, "Il gazzettino", Venezia, 29.XI.2000
· La santità di Gioacchino da Fiore, "Talento", Torino, apr.-giu. 2001, poi incluso nel libro: C. Ciccia, Allegorie e simboli nel Purgatorio e altri studi su Dante
Autore: Carmelo Ciccia
Note: Per
approfondire: www.centrostudigioachimiti.it
SOURCE : http://www.santiebeati.it/dettaglio/47825
Teca
contenente i resti di Giocchino da Fiore, fondatore dell'Ordine florense, Abbazia
Florense, San Giovanni in Fiore
Überreste
von Joachim von Fiore, Gründer des Florenser-Ordens
Eccellenza
Reverendissima,
l'Arcidiocesi
di Cosenza-Bisignano, affidata alle sue cure pastorali, si appresta a celebrare
l'VIII centenario della pia morte dell'Abate Gioacchino da Fiore, che illustrò
la sua terra di origine e l'intera Chiesa con una singolare testimonianza di
fede. Il Santo Padre, informato dell'iniziativa, desidera unirsi spiritualmente
al comune rendimento di grazie al Signore per il dono da Lui fatto alla Chiesa
nella persona di questo sacerdote umile e pio, ed auspica che le celebrazioni
centenarie suscitino nei fedeli di codesta Arcidiocesi e dell'intera Calabria
un più consapevole attaccamento alle proprie radici cristiane per un rinnovato
slancio di fedeltà a Cristo e di amore ai fratelli.
Il
30 marzo 1202, presso la grangia di S. Martino di Canale, Gioacchino, abate di
Fiore, terminava il corso della propria esistenza terrena. Commentando
l'evento, Luca di Casamari, Arcivescovo di Cosenza, scriveva che nel sabato in
cui si cantava il Sitientes gli fu concesso, raggiunto il vero sabato, di
affrettarsi come un cervo alle sorgenti delle acque (cfr Memorie, p. 192).
Gioacchino
nacque a Celico, in Calabria, intorno al 1135 e, ordinato sacerdote, a circa 35
anni entrò dapprima nel monastero cistercense di Santa Maria della Sambucina
nei pressi di Luzzi e poi in quello di Corazzo, divenendone Abate già nel 1177.
In tale veste, tra il 1182 ed il 1183 si recò a Casamari e lì rimase per circa
un anno e mezzo. Il periodo trascorso in tale monastero gli permise di lavorare
alla redazione delle sue opere maggiori. Ritornato a Fiore, dette vita ad una
nuova famiglia monastica, le cui Costituzioni risultano oggi perdute.
A
motivo dei suoi incarichi e delle sue molteplici competenze, Gioacchino si
trovò ad intrattenere numerosi contatti con la Sede apostolica. Nel maggio del
1184 lo troviamo a Veroli, presso il Papa Lucio III e la Curia. Qualche anno
più tardi egli è a Roma presso Clemente III, e il 25 agosto 1196 ottiene dal
Papa Celestino III la Lettera bollata Cum in nostra, con la quale viene
approvata la famiglia monastica da lui fondata.
È
vero che successivamente il Concilio Lateranense IV dovette correggere certi aspetti
della sua dottrina trinitaria e che la sua dottrina del ritmo trinitario della
storia creò gravi problemi nella prima fase della storia francescana; tuttavia
lo stesso Concilio Lateranense IV difese la sua integrità personale, comprovata
dalla sua lettera a Papa Innocenzo III ("Protestatio") e dal Commento
all'Apocalisse. Tra i suoi lettori ed estimatori Gioacchino annoverò il Papa
Innocenzo III, che più volte ebbe a citarlo nei suoi documenti. L'Abate di
Fiore professò sempre fedeltà e obbedienza alla Sede di Pietro, a cui sottopose
con umiltà le proprie opere. Nel Commento all'Apocalisse così ne espone il
motivo: se san Paolo "portò i suoi scritti agli apostoli che lo
precedevano, nel dubbio di correre o di aver corso invano (cfr Gal 2, 2),
quanto a maggior ragione io, che sono niente, non voglio essere giudice di me
stesso, ma dev'esserlo piuttosto il Sommo Pontefice, che giudica tutti ed egli
stesso non è giudicato da nessuno" (fol. 224ra-b). Affermazioni riproposte
anche nell'Epistola prologale, che viene ritenuta il suo
"testamento".
Negli
scritti come nella sua vicenda terrena, Gioacchino appare una persona
innamorata di Dio, un apostolo ardente di zelo, un predicatore appassionato.
Egli fu soprattutto uomo della Parola. La sua opera esegetica - nonostante i
problemi che pone - merita attento studio e può essere fonte di conoscenze
utili, anche a motivo del suo spirito ecumenico.
Dalla
continua meditazione della Parola rivelata, Gioacchino trasse l'energia
spirituale per additare agli uomini le vie di Dio. Ricorda il suo
biografo: "Nel tempo dell'ira, come un altro Geremia, Gioacchino è
stato fatto riconciliazione, intercedendo soprattutto per i poveri" (Vita,
p. 190). Non ebbe timore di affrontare a viso aperto i potenti della terra,
come l'imperatore Enrico VI, che invitò a recedere dal suo comportamento
indegno, se non voleva subire l'ira divina (cfr ibid., p. 189). Fermezza mostrò
pure nei confronti dell'imperatrice Costanza (cfr Memorie, p. 195).
Gioacchino,
che considerò scopo e passione della sua esistenza l'amore della Parola di Dio,
ricorda all'uomo di oggi, inondato di parole e spesso affascinato da
pseudo-valori, che "una sola è la cosa di cui c'è bisogno" (Lc 10,
42), e che occorre vivere di "ogni parola che esce dalla bocca di
Dio" (Mt 4, 4). Egli testimonia, altresì, che la Scrittura va letta con la
Chiesa e nella Chiesa, "credendo integralmente ciò in cui essa crede,
accettando le sue correzioni riguardo sia alla fede che ai costumi, rifiutando
ciò che essa rifiuta e accogliendo ciò che essa accoglie, e credendo fermamente
che le porte dell'inferno non possono prevalere contro di essa" (Epistola
prologale).
Egli
ebbe in gran conto la preghiera e la contemplazione, vissute nel silenzio e
nella quiete, in continua ricerca di Dio, "Padre della luce, nel quale non
c'è variazione né ombra di cambiamento" (Gc 1, 17). La sua singolare
esperienza costituisce per il credente del nostro tempo un potente richiamo a
non temere la solitudine, ma a costellare l'esistenza di spazi di raccoglimento
e di orazione per ritrovare nell'incontro con Dio la possibilità di
un'esistenza più piena e più autentica.
L'Abate
di Fiore visse in grande povertà e considerò unica vera ricchezza il possesso
di Dio. Incurante del prestigio che gli veniva dalla sua carica e della stima
dei potenti del tempo, mantenne sempre un atteggiamento umile, e fu tenace e
gioioso imitatore del Figlio di Dio che, da ricco qual era, si fece povero per
noi (cfr 2 Cor 8, 9) sino a non avere dove posare il capo (cfr Mt 8, 20). Il
suo continuo riferirsi a Cristo "mite ed umile di cuore" (cfr Mt 11,
29) è ricordato dall'Arcivescovo Luca di Casamari che, riferendo come l'Abate
si recasse frequentemente a pulire "con le proprie mani tutta
l'infermeria" (Memorie, p. 195), aggiunge: "Mi meravigliavo che
un uomo di tanta fama, dalla parola tanto efficace, portasse vesti vecchie e
logoratissime, in parte corrose nelle frange" (ibid., p. 191). Questo
singolare anelito alla povertà e al nascondimento fa di Gioacchino un potente
richiamo a considerare i perenni valori evangelici come la via migliore offerta
agli uomini di ogni tempo per costruire un mondo giusto,
fraterno e solidale.
Considerando
le testimonianze di virtù autenticamente cristiane offerte dall'Abate di Fiore,
il Sommo Pontefice esprime l'auspicio che la ricorrenza dell'VIII centenario
della sua morte costituisca per l'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, la quale
gli dette i natali e ne conserva le spoglie mortali, come anche per il Popolo
di Dio che è in Calabria, una preziosa occasione di riflessione e di spirituale
edificazione. Con questi voti, Sua Santità invia una speciale Benedizione
Apostolica a Vostra Eccellenza Reverendissima, ai fedeli dell'Arcidiocesi di
Cosenza-Bisignano ed a quanti, animati da sincero desiderio di verità, si
accosteranno alla figura di quest'insigne figlio della Calabria nel corso delle
celebrazioni giubilari.
Unisco
il mio personale augurio di pieno successo delle celebrazioni programmate,
mentre mi valgo della circostanza per confermarmi con sensi di distinto
ossequio
dell'Eccellenza
Vostra Reverendissima
dev.mo
ANGELO Card. SODANO
Segretario di Stato
Messaggio
Papa Francesco: Giornata mondiale creato, cita Gioacchino da Fiore, “non scoraggiarsi davanti alla barbarie umana”
27 Giugno 2024 @ 11:32
“La speranza è la
possibilità di rimanere saldi in mezzo alle avversità, di non scoraggiarsi nel
tempo delle tribolazioni o davanti alla barbarie umana”. Lo spiega il Papa, nel
messaggio per la Giornata mondiale del creato, che si celebra il 1° settembre
sul tema: “Spera e agisci con il creato”. “La speranza cristiana non delude, ma
anche non illude”, osserva Francesco: “se il gemito della creazione, dei
cristiani e dello Spirito è anticipazione e attesa della salvezza già in
azione, ora siamo immersi in tante sofferenze che San Paolo descrive come
tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, nudità, pericolo, spada”. In questa
prospettiva, “la speranza è una lettura alternativa della storia e delle vicende
umane: non illusoria, ma realista, del realismo della fede che vede
l’invisibile. Questa speranza è l’attesa paziente, come il non-vedere di
Abramo”. A questo proposito, il Papa cita “quel grande visionario credente che
fu Gioacchino da Fiore, l’abate calabrese ‘di spirito profetico dotato’,
secondo Dante Alighieri, il quale “in un tempo di lotte sanguinose, di
conflitti tra Papato e Impero, di Crociate, di eresie e di mondanizzazione
della Chiesa, seppe indicare l’ideale di un nuovo spirito di convivenza tra gli
uomini, improntata alla fraternità universale e alla pace cristiana, frutto di
Vangelo vissuto”. “Questo spirito di amicizia sociale e di fratellanza
universale ho proposto in Fratelli tutti”, ricorda Francesco, secondo il quale
“questa armonia tra umani deve estendersi anche al creato, in un
antropocentrismo situato, nella responsabilità per un’ecologia umana e
integrale, via di salvezza della nostra casa comune e di noi che vi abitiamo”.
Gioacchino da Fiore
Enciclopedia on line
Monaco cistercense,
esegeta (Celico 1145 circa - San Giovanni in Fiore, secondo altre fonti
Pietrafitta, 1202). Secondo i dati tradizionali, G. era figlio d'un notaio
e, dopo un viaggio in Terrasanta, ove prese piena coscienza della sua vocazione
monastica, entrò nell'ordine
cistercense, all'abbazia della
Sambucina. Dopo esser passato per varî monasteri fu abate a Corazzo fino al
1187, quando da papa Clemente III fu esonerato dai suoi doveri di abate perché
potesse liberamente attendere ai suoi studî. Ritiratosi in meditazione sulla
Sila, in vita eremitica, raccolse intorno a sé dei seguaci con i quali costruì
l'eremo di S. Giovanni in Fiore e costituì l'ordine, poi detto florense,
approvato da Celestino III con una bolla del 1196.
Combattuto dai cistercensi, ma appoggiato dall'imperatore Enrico VI di
Hohenstaufen e da sua moglie Costanza, poté tuttavia dedicare le sue energie
alla redazione delle proprie opere e al consolidamento dell'ordine. Tra le sue
opere teologiche: il De articulis fidei e il De unitate seu
essentia Trinitatis, contro Pietro Lombardo,
opera condannata poi nel Concilio Lateranense del 1215 e oggi dispersa
(un Liber contra Lombardum di analogo contenuto, giunto fino a noi, è
di scuola gioachimita); tra le esegetiche: Concordia Novi ac Veteris
Testamenti, la Expositio in Apocalipsim e il Psalterium decem
chordarum e, incompiuto, il Tractatus super quattuor Evangelia; una
raccolta di sermoni; una biografia di s. Benedetto e infine una polemica contro
gli Ebrei,
il Contra Iudeos. Assai discussa l'autenticità di un compendio delle
dottrine di Gioacchino, con illustrazioni esplicative coeve, noto come Liber
figurarum. Fulcro di tutto il pensiero di G. è la considerazione dell'unità e
trinità di Dio, pensate non solo nell'interiorità del processo divino, ma
anche, e più, nel loro esplicarsi nella realtà storica, che va perciò intesa
come il manifestarsi di una economia provvidenziale, in cui a ogni persona della Trinità corrisponde
un'era storica: così al Padre corrisponde l'epoca precedente la venuta di
Cristo e il relativo Libro sacro, il Vecchio
Testamento; al Figlio l'epoca appunto di Cristo e della Chiesa con il Nuovo
Testamento; allo Spirito Santo, un'epoca ancora futura, l'età dello Spirito. Ma
come le tre persone trinitarie costituiscono l'unità divina, così le tre epoche
sono legate tra loro da una corrispondenza proporzionale, per cui ogni
personaggio storico della prima epoca ha l'equivalente, sempre, nella seconda:
per es., Abramo e
Zaccaria, Sara ed Elisabetta, Isacco e Giovanni
Battista, i dodici patriarchi e i dodici apostoli. Questa corrispondenza,
chiamata da G. concordia, gli permette poi d'intravedere le linee
fondamentali della terza età, che sarà età di suprema libertà, di
perfetta carità,
di completa spiritualità. Guida del genere umano nella terza età sarà un ordine
religioso perfetto (pensò ai suoi florensi? Certo i francescani pensarono al
proprio ordine), che assorbirà in sé laici, clero e la stessa
gerarchia ecclesiastica, avviando tutti i fedeli alla perfezione cristiana. Una
Chiesa così costituita, nella terza età, può certo attendere senza timore la
venuta dell'Anticristo,
con le terribili persecuzioni che l'accompagneranno, e poi il giudizio di Dio.
Profeta di questa nuova Chiesa, sottile ed entusiasta esegeta, G. esercitò
grande influenza sui suoi contemporanei, che o lo avversarono fieramente o ne
furono ardenti seguaci (gioachimiti).
© Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata
SOURCE : https://www.treccani.it/enciclopedia/gioacchino-da-fiore/
Gioacchino da Fiore
Vita e opere. Gioacchino
da Fiore nacque in Calabria nel 1145. Dal 1191 fu abate del chiostro da lui
fondato in San Giovanni in Fiore e qui morì nel 1202. Venne collocato da Dante
nel cielo del Sole per la sapienza del suo spirito profetico. Gioacchino
scrisse tre grandi opere per molti versi complementari: Concordia Novi et
Veteris Testamenti, Expositio in Apocalypsim, Psalterium decem chordarum.
Scrisse anche uno scritto teologico polemico contro Pietro
Lombardo, oggi perduto, il De unitate seu essentia Trinitatis; uno scritto
contro gli ebrei, l’Adversus Iudaeos; il De articulis fidei; i Tractatus super
quattuor Evangelia. È discussa l’autenticità del Liber figurarum, un albo
composto di figure e grafici.
La filosofia della
storia. A partire da una rigorosa esegesi del testo biblico, Gioacchino formulò
una filosofia della storia imperniata sulla corrispondenza delle tre
età della Storia alle tre persone della Trinità. Elementi analoghi alla
visione gioachimita della storia sono presenti anche nelle visioni di Ildegarda
di Bingen, strutturate su una ossatura biblica profetica e apocalittica; e,
come gli scritti di Ildegarda, anche quelli di Gioacchino sono caratterizzati
dalla presenza di immagini e diagrammi non puramente esornativi, ma
indispensabili per cogliere il significato più profondo delle sue intuizioni.
Secondo Gioacchino da Fiore all'era del Padre, caratterizzata dalla rigidità
della Legge veterotestamentaria, è succeduta quella del Figlio, "l'era
media" contrassegnata dalla centralità della Chiesa romana; ad essa succederà
l'età dello Spirito, i "tempi nuovi" in cui il mondo sarà
trasfigurato dalla venuta dello Spirito della gioia. Il succedersi delle
ere è indipendente dai comportamenti degli uomini, che possono soltanto
cogliere i segni dei tempi e adattarsi ad essi: è del resto lo stesso piano di
Dio che porta gli uomini dallo stato animale a quello psichico a quello
pneumatico o spirituale. Il segno dell'età dello Spirito che viene saranno
proprio gli "uomini nuovi", di fronte ai quali la Chiesa proverà un
invincibile terrore; gli sconvolgimenti descritti nell'Apocalisse segneranno
il momento del passaggio. Secondo la tradizione semitica, lo Spirito Santo
corrisponde al principio femminile di Dio. Questo aspetto in qualche misura
traspare anche nell'accostamento operato a Chartres dello
Spirito Santo con l'anima del mondo e la natura, e nell'esegesi di Gen. I, 2,
"sulle acque aleggiava lo Spirito di Dio".
L'Ecclesia spiritualis.
Nel Liber concordiae Novi et Veteris Testamenti, Gioacchino precisa il suo
punto di vista: modifica la visione della storia trasmessa da Agostino alla
teologia medievale. La teoria agostiniana proponeva un’interpretazione cristocentrica
della storia. Il monaco florense la rifiuta a favore di quella trinitaria che
implica una trasformazione del ruolo della gerarchia ecclesiastica e della
funzione dei sacramenti e della Bibbia. La nuova chiesa che Gioacchino attende
è l’Ecclesia spiritualis. Le dottrine di Gioacchino da Fiore vennero condannate
in quello stesso Concilio Lateranense del 1215 che stabilì l'impossibilità di
creare nuovi ordini monastici e impose l'obbligo della clausura alle donne che
abbracciavano la vita religiosa. Dopo la morte furono attribuiti a Gioacchino
molti commenti esegetici, profezie e vaticini. Fra questi è piuttosto noto il
Tractatus super Hyeremiam, risalente al 1230 circa e proveniente da ambienti
florensi o francescani. La dottrina di Gioacchino diede vita ad un vasto
movimento denominato gioachimismo, che ebbe seguito soprattutto fra i
francescani spirituali, specialmente Gerardo di Borgo San Donnino, Pier
di Giovanni Olivi e Ubertino da Casale che si ispirarono all’abate per
delineare i caratteri della “terza età” nella storia della salvezza
caratterizzata dalla piena e rigorosa attuazione della regola francescana in
opposizione con la chiesa corrotta. Altri temi propriamente gioachimiti quello
del papa angelico e dell’imperatore degli ultimi tempi, che ha il ruolo di
unire il mondo. (E.C.)
Bibliografia:
Edizioni
Super quattuor Evangelia, Torino 1960
Scritti minori. De articulis fidei, ed. Bonaiuti, Roma 1936
Adversus Iudaeos, ed. A. Frugoni, Roma 1957
Traduzioni italiane
Gioacchino da Fiore, Sull’Apocalisse (testo lat. a fronte), a cura di A. Tagliapetta, Feltrinelli, Milano 1994
Gioacchino da Fiore. Un maestro della civiltà europea. Antologia di testi, a cura di F. D’Elia, Rubbettino, Soneria Mannelli 1991
Gioacchino da Fiore Agli Ebrei (Adversus Iudaeos) M. Iiritano (trad. comm.); presentazione di B. Forte, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino 1998
Gioacchino da Fiore Commento a una profezia ignota a cura di M. Kaup, Roma, Viella 1999
Gioacchino da Fiore Dialoghi sulla prescienza divina e la predestinazione degli eletti, a cura di G.L. Potestà, Roma, Viella 2001
Gioacchino da Fiore Introduzione all’Apocalisse, a cura di G.L. Potestà, Roma, Viella 1995
Gioacchino da Fiore: invito alla lettura, di G.L. Potestà, Milano, San Paolo, 1999 (raccolta di testi).
Gioacchino da Fiore. Un maestro della civiltà europea. Antologia di testi, a cura di F. D’Elia, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino 1991.
Gioacchino da Fiore Trattati sui quattro Vangeli, a cura L. Pellegrini;
revisione e commento di G.L. Potestà; premessa di C. Leonardi, Roma,Viella 1999
Risorse on-line
http://www.uan.it/alim/testi/xii/AlimIoachFloreIudeosXIIteopro1.htm
http://www.centrostudigioachimiti.it/Gioacchino/GF_vita.asp
Studi
L’età dello Spirito e la
fine dei tempi in Gioacchino da Fiore e nel Gioachimismo medievale, 2 voll.,
Centro di Studi Gioachimiti, S. Giovanni in Fiore 1986
E. Buonaiuti, Gioacchino da Fiore. I tempi, la vita. Il messaggio, Giordano, Cosenza 1984
H. Grundmann, Studi su Gioacchino da Fiore, trad. it., Marietti, Genova 1989
B. McGinn, L’abate calabrese. Gioacchino da Fiore nella storia del pensiero
occidentale, trad. it., Marietti, Genova 1990Università di Siena - Facoltà di
lettere e filosofia
Manuale di Filosofia
Medievale on-line
|
Index | |La Filosofia nel Medioevo | | Caratteri fondamentali | | Interpretazioni |
| Medioevo e Filosofia Moderna| | Studio del Medioevo|
SOURCE : http://www3.unisi.it/ricerca/prog/fil-med-online/autori/htm/gioacchino.htm
GIOACCHINO da Fiore
di Mario Niccoli
Enciclopedia Italiana
(1933)
Profeta calabrese, una
delle figure più notevoli della spiritualità cristiana durante il Medioevo.
Scarsissimi i dati
biografici che si possono ricavare dagli scritti di G. stesso, mentre le
biografie "canoniche" di G. - quella di Luca arcivescovo di Cosenza e
già segretario del profeta (in Acta Sanctorum, maggio, VII, pp. 89-143),
l'altra pubblicata da Giacomo Greco (cosenza 1612), di su documenti esistenti
nella badia di S. Giovanni in Fiore, e quella di Gregorio da Lauro (Napoli
1660) - non sono che un'eco malsicura di quel vasto fiorire di leggende di cui
fu oggetto la persona di G. quasi all'indomani della sua morte. Né valore
maggiore hanno le attestazioni dei cronisti britannici Ruggero di Hoveden,
Benedetto di Peterborough e Raul di Coggeshall che, con lievi differenze,
mostrano G. profetizzare a Riccardo Cuor di Leone la vittoria delle armi
cristiane sul Saladino e annunciare l'avvento già verificatosi dell'Anticristo
in persona del pontefice. D'altra parte le polemiche suscitate dalla propaganda
gioachimita rendono comunque poco attendibili i primi biografi gioachimiti.
Sembra probabile che G.
nascesse circa il 1130 a Celico; egli stesso si qualifica "homo agricola a
iuventute mea", smentendo così i suoi biografi che lo vogliono figlio di
un notaio e cortigiano di Ruggero II. Un accenno dei Tractatus super
quatuor Evangelia (p. 93, ed. Buonaiuti) parrebbe confermare i dati
tradizionali che lo vogliono pellegrino, nei suoi anni giovanili, a
Costantinopoli, nella Tebaide e a Gerusalemme, ma la questione presenta,
nonostante ciò, delle difficoltà. Fra il 1150 e il 1155 G. dovette essere accolto
nel monastero cisterciense di Sambucina per poi passare nell'abbazia di
Corazzo, dove forse avvenne la sua professione monastica e dove in breve,
ordinato prete, fu eletto abbate (1177). Desideroso di proporre per iscritto
una sua interpretazione della Scríttura, G. si sarebbe, secondo le fonti
canoniche, recato a chiedere l'autorizzazione per la sua opera presso Lucio
III, allora (1182-1183) a Veroli, e avrebbe scelto, come sua residenza,
Casamari. Ivi G. avrebbe condotto a termine la Concordia Veteris et Novi
Testamenti, e, in parte, lo Psalterium decem cordarum. Tre anni dopo
(1186) G. si sarebbe recato a Verona presso Urbano III che l'avrebbe
sollecitato a intraprendere l'Expositio in Apocalipsim. Ma queste notizie, come
l'Admonitorium col quale Clemente III l'8 giugno 1188 avrebbe sollecitato
G. al compimento della sua opera, appaiono di assai dubbia autenticità. Certo
G. fu a Casamari, in epoca non precisabile, ove conobbe il suo segretario, e
futuro biografo, Luca. Nel 1191 G. abbandonava i cisterciensi e il monastero
per ritirarsi con un solo compagno nell'eremo di Pietralata, donde in seguito
passò sulla Sila ove fondò il monastero di S. Giovanni in Fiore (il nome è
affatto misterioso) organizzando i monaci accorsi intorno a lui secondo una regola
monastica, oggi perduta, che rappresentava un inasprimento della regola
cisterciense. Il capitolo dei cisterciensi tentò di richiamare G., ma non pare
che questi obbedisse. Una bolla di Celestino III del 25 aprile 1196
regolarizzava la posizione di G. e approvava la regola dei florensi.
Il Buonaiuti ha fatto
l'ipotesi che uno schema della perduta regola sia tracciato nel capo 23 del
libro V della Concordia. Alcuni atti ufficiali (bolla di Innocenzo III del
21 gennaio 1204; atti del IV concilio lateranense deì 1215; 2 bolle di Onorio
III del 2 dicembre 1216 e del 27 dicembre 1220) e i documenti di una lunga
controversia fra i basiliani del Patirion e i florensi a proposito dei pascoli
della Sila (primo quarto del secolo XIII) mostrano che la posizione dei
florensi fu, anche dopo la morte e la condanna delle dottrine di G.,
canonicamente regolare. Ma a ogni modo l'ordine florense non ebbe mai grande
diffusione e nel sec. XIV se ne perdono le tracce.
Gli ultimi anni della
vita di G. (morto nel 1201, probabilmente il 30 marzo) non possono certo per
noi essere illuminati dai racconti, assolutamente incontrollabili, di Giacomo
Greco, che ci presentano G. minacciare a Napoli Enrico VI che assediava la
città (1191) o imporre a Costanza di prostrarsi ai suoi piedi a remissione
delle sue colpe. Da alcuni diplomi sappiamo di privilegi concessi all'abbazia
florense nel 1195 e 1198 rispettivamente da Enrico VI e da Costanza. Il
testamento nel quale G., nel 1200, fa aperta professione di ortodossia, ricorda
i suoi scritti e raccomanda ai suoi monaci di sottoporre le sue opere alla
revisione ecclesiastica, non può essere considerata (l'autenticità del
testamento è però difesa da H. Grundmann) se non come un pio falso dei
florensi. Ammessa l'autenticità di esso, come delle altre notizie che ci
mostrano tre papi solleciti nello spingere G. a portare a termine la sua opera,
questa verrebbe ad assumere un carattere ufficiale che contrasterebbe col suo
contenuto intimamente sovversivo nei riguardi della Chiesa ufficiale.
La visione profetica di
G. parte dal presupposto di un "vivens ordo" esistente nella storia,
per cui i fatti che ne segnano lo sviluppo avvengono secondo cicli paralleli,
in modo che l'osservazione di questi rende possibile interpretare nel loro
significato gli avvenimenti presenti e intuire il fine cui sono diretti. E
poiché il cammino dell'umanità si compendia per G., esclusivamente nella
rivelazione cristiana, G., che di questa ha un concetto tutto dinamico come di
cosa non ancora giunta alla sua pienezza, è portato a interpretare cose, fatti
e persone - le stesse realtà sacramentali - in cui si concretano le due tappe
già concluse di questa rivelazione, l'economia del Vecchio e quella del Nuovo
Testamento, non nel loro valore storico e sostanziale, ma come simboli atti a
farci intendere la realtà futura in essi adombrata; come valori transitorî destinati
a cadere di fronte a quelli, essenziali, che essi preannunciano. Anche se
l'esegesi tipologico-storica, alla quale G. assoggetta ogni fatto e personaggio
dei due Testamenti, è sostanzialmente fedele (H. Grundmann) alle forme
esegetiche tradizionali e specialmente alle Formulae spiritalis
intelligentiae di Eucherio di Lione (sec. V), l'originalità di G. è nella
visione arditissima di rinnovamento religioso cui asserve la sua esegesi.
G. non è un teologo:
mentre Abelardo, i Vittorini e Pier Lombardo, prospettavano il mistero
trinitario come esempio tipico della possibilità di coesistenza fra l'Uno e il
Molteplice, G. difende una concezione del dogma trinitario tutta economica e
pragmatica. Nella storia dell'evoluzione spirituale dell'umanità vi è, per G.,
un mistero profondo di cui il mistero trinitario non è che manifestazione
tipica e simbolistica. Se nella Trinità vi è molteplicità di ipostasi
nell'unità di sostanza, generazione del Figlio dal Padre, processione dello
Spirito dal Padre e dal Figlio, anche nella manifestazione dell'unica grande
realtà spirituale vi è, secondo G., una triplice molteplicità di epoche,
filiazione della seconda dalla prima e processione della terza da entrambe. Nel
primo stadio del mondo, iniziatosi con Mosè, ha manifestato la sua gloria il
Padre; nel secondo, il Figlio; ma la rivelazione è destinata a esaurirsi solo
con il ritorno di Elia che inaugurerà il terzo stadio nel quale lo Spirito sarà
chiamato a manifestare completamente la sua gloria. E poiché lo Spirito non procede
isolatamente dal Figlio, ma principalmente dal Padre, questi, presentandosi col
Figlio stesso agl'inizî del secondo stadio, fece anche allora sfolgorare in
parte quella gloria che rilucerà in pieno col ritorno di Elia.
Per G. l'economia del
Figlio è ormai tramontata: egli già intravvede i segni preannuncianti l'alba
del terzo stadio e non si arresta di fronte all'affermazione di essere lui il
profeta e l'iniziatore della nuova, definitiva epifania divina. Il significato
di G. è, tutto, in questa sua visione escatologica e nelle ragioni profonde che
la suggeriscono, a illuminare le quali è necessario, per riflesso, tener
presente la pittura che G. dà della nuova economia religiosa in via di
manifestarsi. In essa la Chiesa ufficiale non potrà conservare il suo compito
di amministratrice dei carismi. Alla Chiesa della gerarchia e dei simboli
succederà, e il momento della rivelazione è prossimo, la Chiesa delle realtà
spirituali. Dominio di un monachismo purificato; reame che avrà per cardini la
contemplazione, la carità, la libertà, la pace: questi i tratti distintivi
della Ecclesia Spiritus annunciata da Gioacchino.
A intendere questo
annuncio nella sua genesi, è errato ricollegare G. alle tradizioni della chiesa
greca o riavvicinare l'esperienza di G. a fonti tedesche. Ma è necessario
invece tenere presente che G., con tutta probabilità servo della gleba per
nascita, è giunto al suo riscatto e alla formulazione del suo messaggio
attraverso l'iniziazione in una riforma monastica, quella cisterciense, di origine
e caratteristiche squisitamente latine, la cui importanza sul terreno sociale
come fattore di disgregamento dei superstiti istituti feudali - anche
nell'Italia Meridionale - si palesa oggi sempre più evidente. Sarà infine
necessario tener presente che il ciclo fattivo della vita di G. coincide con
quello della maggior fortuna del regno normanno in Italia: tendenze,
aspirazioni e crisi del quale, studî recenti hanno mostrato riflettentisi sulla
complessa esperienza di Gioacchino.
Se nel movimento francescano
e nelle sètte mendicanti moltiplicatesi intorno all'anno 1260, da G. designato
come l'anno fatale (v. francescanesimo; spirituali; e voci ivi
citate), è facile cogliere l'eco più risonante dell'annuncio profetico di G.,
le ripercussioni di questo (non arrestato nella sua diffusione palese e
sotterranea dalla condanna formulata dal concilio lateranense del 1215 contro
le affermazioni trinitarie di G., né da quella formulata ad Anagni il 23
ottobre 1255 contro l'Introductorius di Gerardo da Borgo S. Donnino) si
rivelano sempre meglio come il fatto più saliente nella storia della
spiritualità cristiana nei secoli seguenti, fino agli albori del Rinascimento e
al Savonarola.
Opere: Delle
numerosissime opere che vanno sotto il nome di G. si possono, con E. Buonaiuti,
ritenere autentiche o quanto meno (H. Grundmann allunga sensibilmente questo
elenco) fondamentali: la Concordia Veteris et Novi Testamenti (Venezia
1519); l'Expositio in Apocalipsim (Venezia 1627); i Tractatus super
quatuor evangelia (ed. da E. Buonaiuti in Fonti per la storia
d'Italia, LXVII, Roma 1930; l'autenticità di questa opera è ora fuori
discussione); lo P. salterium decem cordarum (Venezia 1527).
Sono ancora inediti un Adversum Iitdaeos e un De articulis fidei.
Perduto è il De unitate seu essentia trinitatis contro Pier Lombardo,
condannato dal concilio lateranense del 1215. Un manoscritto Liber de vera
philosophia contro Ugo da S. Vittore e Pier Lombardo è stato, senza
fondamento, attribuito a G. da P. Fournier. Le tre grandi opere esegetiche di
G. (il titolo ne rivela il contenuto): Concordia, Expositio, Tractatus,
debbono avere avuto la loro origine in corsi di predicazione monastica.
Lo Psalterium espone (misticamente speculando su due strumenti
musicali, il salterio esacordo e la cetra) l'interpretazione gioachimitica del
dogma trinitario. Expositio e Concordia furono redatte
contemporaneamente (l'Expositio era a metà nel 1196). A questi due scritti
deve essere seguito lo Psalterium. Ultimi, cronologicamente, sono i Tractatus,
rimasti incompiuti forse per la morte dell'autore.
Bibl.: Oltre all'introd.
all'ed. cit. dei Tractatus, v.: H. Grundmann, Studien über J. von F.,
Lipsia 1927; id., Papsrprophetien des Mittelalters, in Archiv für
Kulturgeschichte, XIX (1928); id., Liber de Flore; eine Schrift der
Franziskaner-Spiritualen aus dem Anfang des XIV. Jahr., in Historisches
Jahrbuch, XLIV (1929); id., Kleine Beiträge über J. von F., in Zeitschr.
für Kirchengesch., XLVIII (1929); E. Buonaiuti, La modernità di G. da F.,
in Ricerche religiose, VI (1930); id., G. da F., San Bonaventura e
San Tommaso, in Ricerche religiose, VI (1930); id., G. da F. ed Elia
da Cortona, in Ricerche religiose, VII (1931); G. da F.: i tempi, la
vita e il messaggio, Roma 1931; id., G. da F., in Rivista storica
italiana, XLVIII (1931); H. Bett, J. of F., Londra 1931; E.
Anitchkof, J. de F. et les milieux courtois, Roma 1931; G. La Piana, J.
of F., in Speculum, 1932 (ottima rassegna degli studî gioachimiti, alla
quale si rimanda per la letteratura anteriore agli scritti del Grundmann e del
Buonaiuti).
© Istituto della Enciclopedia
Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata
SOURCE : https://www.treccani.it/enciclopedia/gioacchino-da-fiore_(Enciclopedia-Italiana)/
Beato Gioacchino da Fiore, Abbazia
Florense (cripta)
Holzgeschnitzte
Statue von Joachim von Fiore
Wooden carved statue of Joachim of Fiore
GIOACCHINO da Fiore
di Raniero Orioli
Dizionario Biografico
degli Italiani - Volume 55 (2001)
Nacque a Celico, presso
Cosenza, sesto di otto fratelli, tra il 1130 e il 1135 da Gemma e Mauro, tabellio e
forse publicus notarius di Sanzio, arcivescovo di Cosenza.
Le notizie sulla vita di
G., soprattutto per il periodo che precede la sua più matura attività, sono
scarse e presentano non poche difficoltà. Ragguagli autobiografici sono contenuti
all'interno delle sue stesse opere, tuttavia in forma estremamente sintetica e
non sempre di facile lettura, tanto che si è spesso equivocato su di una sua
possibile origine contadina oppure su di una eventuale ascendenza ebraica. Nel
primo caso a indurre in equivoco è lo stesso G., il quale, nel rifiutare
strenuamente il ruolo di profeta che già i contemporanei tendevano ad
attribuirgli, si autodefinisce, per contrapposizione, "homo agricola a
iuventute mea"; mentre su una probabile appartenenza all'ebraismo non poco
hanno giocato sia il ruolo che egli fa assumere a tale popolo all'interno del
suo sistema esegetico sia un non celato disappunto dei cistercensi nei
confronti di G. che essi considerarono, mentre era ancora in vita, un transfuga
dell'ordine.
Con cautela vanno inoltre
accolte le notizie contenute nelle vite che di G. ci sono pervenute. La più
attendibile è senz'altro quella di Luca da Cosenza, dal 1202 arcivescovo di
Cosenza e che fu suo scriba nel periodo in cui G. risiedette nell'abbazia di
Casamari (1183-85), alla quale si aggiunge un'ulteriore biografia scritta prima
del 1209 da un anonimo discepolo: sono quindi opere di uomini che lo conobbero,
ma esse ci sono tuttavia pervenute soltanto attraverso rifacimenti e
interpolazioni del XVI secolo. Per una loro disanima ed edizione critica, si
veda H. Grundmann, Zur Biographie Joachims von F. und Rainers von Ponza,
in Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, XVI (1960), pp.
528-544.
Avviato alla carriera di
funzionario nella Cancelleria di Guglielmo I re di Sicilia, dove acquisì una
formazione che si rivelò quanto mai proficua negli anni seguenti nei rapporti
con le corti e la Curia, nel 1167 si recò in Terrasanta, da dove ritornò
animato dal desiderio di rinunciare a quella carriera che il padre aveva
previsto per lui. Dapprima si ritirò presso un monastero greco alle pendici
dell'Etna e successivamente fu accolto dall'abbazia cistercense di Sambucina
(Cosenza). La scelta eremitico-monastica non si configurò tuttavia quale forma
di totale rinuncia a vivere nel mondo. Iniziò infatti in questi anni
un'attività di predicatore nella valle del Crati, attività che fu legittimata
dalla consacrazione a sacerdote di G. da parte del vescovo di Catanzaro.
La scelta monastica si
concretizzò ulteriormente nel 1172, quando venne accolto nel monastero di
ispirazione cistercense di S. Maria di Corazzo (Catanzaro), che nel 1177 lo
elesse abate. In questa nuova veste G. si trovò impegnato su due fronti: nel
dicembre 1179 era a Palermo, alla corte di Guglielmo II, per difendere la
proprietà di alcuni terreni rivendicati dal monastero e, nello stesso tempo, si
adoperava affinché la piccola comunità cui apparteneva fosse affiliata
dall'abbazia cistercense di Sambucina. Il rifiuto oppostogli da questa e, successivamente,
dalla stessa Casamari, a motivo della povertà in cui versava Corazzo, non
impedì a G. di mantenere costanti rapporti con l'Ordine cistercense. Luca da
Cosenza racconta infatti che per un anno e mezzo a partire dal gennaio 1183 G.
risiedette a Casamari; un soggiorno che risultò essere, se non il periodo più
prolifico, certo quello che informò di sé la sua futura attività.
È G. stesso a darcene
notizia nella sua Expositio in Apocalypsim, quando narra di due distinte
rivelazioni avute nel giorno di Pasqua e, successivamente, in occasione della
Pentecoste; rivelazioni grazie alle quali "mi accadde di cogliere con gli
occhi della mente qualcosa di una così grande chiarezza d'intelligenza (intelligentiae
claritate) a proposito di questo libro dell'Apocalisse e di tutta la
concordia dell'Antico e del Nuovo Testamento" (trad. Tagliapietra, 1994,
p. 61). Ed è proprio durante la permanenza a Casamari che G. diede inizio alla
stesura pressoché contemporanea di tre distinte opere: la Concordia Novi
ac Veteris Testamenti, l'Expositio in Apocalypsim e lo Psalterium
decem chordarum.
Il modo di procedere di
G. nell'elaborazione delle sue opere rende difficile fissare una loro
cronologia certa. Clemente III, con una lettera andata perduta dell'8 giugno
1188, sollecitava G. a proseguire e concludere la stesura dell'Expositio e
della Concordia. Nella sua lettera-testamento del 1200 G., nel ribadire
l'intenzione di sottoporre ogni suo scritto all'autorità papale, dichiarava che
entrambe le opere erano finalmente concluse e nello stesso tempo si apprestava
alla stesura del Tractatus super quattuor Evangelia, rimasto incompiuto.
Nell'arco dei vent'anni compresi tra il soggiorno a Casamari e la sua morte si
registrano "due grandissime opere molto complesse, altre cinque di medie
dimensioni e un'intera serie di scritti minori" nonché il Tractatus
super quattuor Evangelia, senza escludere, in considerazione che G. quando si
trovava a Casamari aveva all'incirca cinquant'anni, "che tra il materiale
manoscritto anonimo del XII secolo si possa nascondere un qualche testo uscito
dalla penna di Gioacchino durante la prima fase della sua produzione"
(Selge, 1990, p. 91). Alla luce della fortuna e dei significati, spesso
contraddittori, che nei secoli successivi sono stati attribuiti al pensiero di
G., ne consegue come ineludibile la necessità innanzitutto di discernere tra
opere autentiche e opere spurie, per poi delle prime determinare con
un'approssimazione accettabile sia la datazione, sia un testo critico, tale
cioè che risulti purgato da interpolazioni più o meno coeve all'autore. Per
quelle spurie invece si presenta un compito più complesso, dal momento che
esse, forse ancor più di quelle autentiche, sono all'origine di una distorta
risonanza del pensiero gioachimita che ha fatto sì che - come è stato detto -
G. sia l'autore italiano su cui più si è scritto dopo Dante Alighieri. Un
lavoro di acribia, quindi, che iniziato nella prima metà del Novecento può
dirsi concluso, grazie ai contributi di studiosi quali Grundmann, Buonaiuti,
Reeves, McGinn e Selge, per citare i più significativi, per quanto attiene la
determinazione del canone delle opere di G., nonostante il singolare modus
scribendi dell'autore, che sottopose alcune di esse a continui e
procrastinanti momenti di scrittura, come testimonia la stessa lettera di papa
Clemente III. Ciò spiega il rinnovarsi dell'interesse verso G. e soprattutto
l'urgenza ineludibile di approntare un'edizione critica delle sue opere,
un'impresa non realizzabile da un solo soggetto (l'esperienza del Grundmann e
del Buonaiuti ne sono una riprova), ma che sembra attualmente concretizzarsi
grazie allo sforzo congiunto di tre istituzioni: il Centro Internazionale di
studi gioachimiti di San Giovanni in Fiore, l'Istituto storico italiano per il
Medio Evo di Roma e i Monumenta Germaniae Historica di Monaco di Baviera.
Una delle opere di G. più
facilmente databili è il De prophetia ignota, concepita a Veroli nel
maggio del 1184, in occasione di una visita dell'abate calabrese a papa Lucio
III.
All'origine del lavoro si
trova una profezia, altrimenti nota come Sibilla Samia, rinvenuta tra le carte
del defunto cardinale Matteo d'Angers, i cui toni drammatici dovevano aver
provocato non pochi timori nell'ambiente curiale. Richiesto di fornirne una
interpretazione, G., pur disinteressato per principio nei confronti di testi
che non fossero scritturistici, applica e essa lo stesso criterio esegetico che
utilizza per tali testi, ricorrendo all'analogia tra le sette tribolazioni di
cui furono vittime gli Ebrei nel Vecchio Testamento alle altrettante
persecuzioni di cui egli vede oggetto la Chiesa. In particolare egli intravede
nel conflitto in corso tra Papato e Impero l'approssimarsi della quinta
tribolazione e preconizza per il prossimo futuro, in parallelo con la quinta
tribolazione veterotestamentaria che si risolse nella cattività babilonese, la
necessità per la Chiesa di non opporsi al potere temporale, anzi di subirlo
come fatto necessario e necessitato.
Abbandonata l'ipotesi che
vuole il De prophetia ignota una sorta di ballon d'essai proposto
da Lucio III a G. prima di concedergli la licentia scribendi, appare certo
che con quest'opera G. si rivelava abile esegeta, in grado di porsi in
singolare assonanza con la linea politica adottata dallo stesso pontefice,
alieno da azioni di forza come dimostra il tentativo, sia pur abortito, di
pervenire nello stesso anno a un accordo con Federico I Barbarossa. È indubbio
che G. con la sua singolare capacità esegetica ottenne un significativo
apprezzamento che non venne meno anche quando salì al soglio pontificio Urbano
III, la cui politica sembrava indirizzarsi su posizioni ben più intransigenti
di quelle del suo predecessore. Infatti, nonostante il mutato clima, Urbano nel
1186 accolse a Verona G. che, lasciata Casamari nel 1185, era ritornato
dapprima a Corazzo per poi recarsi l'anno successivo nella città veneta per
rendere omaggio al nuovo pontefice; questi, come il suo predecessore, sollecitò
G. a continuare nel suo lavoro di esegeta.
Nonostante a Verona si
fosse giunti a un accordo di comune lotta contro gli eretici e di indizione di
una crociata in Terrasanta, G. dovette chiaramente avvertire che la tregua non
avrebbe retto alla distanza, anche perché il matrimonio del figlio del
Barbarossa, Enrico, con l'erede di Guglielmo II di Sicilia, Costanza
d'Altavilla, alla morte del re avrebbe senz'altro riproposto il conflitto,
temporaneamente accantonato, tra il Papato, che rivendicava le proprie
prerogative feudali sul Regno siciliano, e le mire espansionistiche della casata
sveva. G. non poteva certamente aver previsto quanto sarebbe accaduto di lì a
qualche anno; tuttavia la pesante atmosfera di diffidenza avvertita in
occasione della sua permanenza a Verona, lo indusse a una sorta di
accentuazione delle posizioni già presenti nel De prophetia ignota in
merito all'approssimarsi di un periodo di grandi tribolazioni per la Chiesa.
Al suo ritorno G., con
alcuni seguaci, tra cui Rainero da Ponza, decise di lasciare Corazzo e si
ritirò nell'eremo di Petra Lata. In questo periodo, pur continuando a lavorare
alle opere intraprese a Casamari, compose il De vita sancti Benedicti et
de officio divino secundum eius doctrinam, opera nella quale l'esaltazione di
Benedetto funge da contraltare a un monachesimo che nelle sue forme ormai
consolidate G. riteneva inadeguato ad affrontare i turbamenti che si
annunciavano per la Cristianità.
Sordo ai richiami che gli
giungevano da Corazzo, nel 1188 si recò a Roma dal pontefice Clemente III, il
quale da una parte gli rinnovò la stima già accordatagli dai predecessori,
dall'altra lo assecondò nelle sue istanze di maggior severità, liberandolo
dagli obblighi abbaziali e disponendo affinché Corazzo fosse finalmente
affiliato a un'abbazia maggiore, quella cistercense di Fossanova.
Forte di siffatto
appoggio G. ritornò in Calabria e sull'altipiano della Sila andò alla ricerca
di un luogo idoneo alla comunità che aveva aggregato intorno a sé, primo nucleo
di un nuovo ordine che egli intendeva fondare. Grazie alle generose elargizioni
di Tancredi d'Altavilla, nel 1190 realizzò questo suo disegno, fondando il
monastero di S. Giovanni in Fiore, che divenne la sua sede permanente.
Le cure per il nuovo
monastero, significativamente dedicato a s. Giovanni Evangelista, emblema della
vita contemplativa, non gli impedirono di continuare a mantenere rapporti con i
grandi del tempo. Nel 1191 infatti egli si recò dapprima a Messina e poi alla
corte di Enrico VI, impegnato nell'assedio di Napoli, che pur consapevole del
giudizio sostanzialmente negativo espresso da G. nei confronti dell'Impero -
giudizio rinnovato in un'altra composizione dello stesso anno 1191, l'Intelligentia
super calathis -, tuttavia non gli lesinò il suo favore.
La scelta di S. Giovanni
in Fiore non poteva giungere gradita all'Ordine cistercense; ne è prova
l'incontro, divenuto leggendario, che nel 1190 ci sarebbe stato tra G. e
Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra, in procinto di imbarcarsi per la
crociata. In tale occasione G. avrebbe spiegato al monarca inglese il
significato del drago a sette teste dell'Apocalisse, preconizzando a un tempo
l'avvento dell'Anticristo nella figura di un pontefice. A rendere fortemente sospetta
l'attendibilità di siffatto incontro concorrono sia la costante cura di G. di
sottomettere ogni suo scritto all'approvazione pontificia sia il fatto che a
narrarcelo siano tre cronisti inglesi - Benedetto di Peterborough, Ruggero di
Haveden e Rodolfo di Coggeshall - significativamente cistercensi, come
cistercense era quel Goffredo d'Auxerre, già segretario di Bernardo di
Chiaravalle, cui si deve la leggenda dell'origine ebraica di Gioacchino.
L'ordine tuttavia aveva
già provato a reagire in maniera più diretta nei confronti di G. e Rainero da
Ponza intimando loro, nel capitolo generale del settembre 1192, di rientrare a
Corazzo entro un anno, pena la qualifica di fugitivi. Ma la scelta di G.
era ormai definitiva, forte anche della benevolenza che negli anni
immediatamente successivi gli dimostrarono sia Enrico VI, sia Costanza
d'Altavilla, che lo volle il venerdì santo del 1196 quale suo confessore a
Palermo e che col marito garantì con munifiche donazioni la sopravvivenza di S.
Giovanni in Fiore, sia il pontefice Celestino III, che il 25 agosto dello
stesso anno approvò la regola della nuova comunità monastica. Un favore che
venne ulteriormente confermato dalla stessa autorità religiosa ordinaria: nel
1201 infatti l'arcivescovo di Cosenza Andrea donò a G. una chiesa vicino a
Canale (Pietrafitta, presso Cosenza), dove l'abate diede inizio alla
costruzione dell'eremo di S. Martino in Giove.
Mentre sovrintendeva ai
lavori, la morte lo colse il 30 marzo 1202 e il suo corpo fu successivamente
traslato in S. Giovanni in Fiore.
La scomparsa di G. non
segnò tuttavia la fine della sua influenza nel pensiero occidentale, anche se
rimase vittima di un paradosso che lo volle "profeta" nonostante egli
avesse costantemente rifiutato per sé siffatto appellativo. Non v'è dubbio che
la sicurezza esegetica dimostrata nel "rileggere" la storia, unita
tuttavia a una sorta di indeterminatezza nel presagire i possibili sviluppi
futuri, abbiano giocato a favore di coloro che presunsero di determinare ciò
che G., in piena coerenza col proprio pensiero, aveva volutamente lasciato
nebuloso. D'altra parte, in alcune circostanze il suo comportamento sembrò
legittimare effettivamente la nomea di profeta. Basti pensare all'invito che
egli fece a Enrico VI, durante l'assedio di Napoli del 1191, a non infierire
sulla popolazione perché comunque il Regno di Sicilia sarebbe entrato in suo
possesso senza colpo ferire, il che puntualmente si avverò. Enrico, memore e
riconoscente, non cessò di gratificare G. e volle proporsi quale protettore del
nuovo Ordine florense. Ma se questo può in qualche modo dare ragione di una
distorsione del pensiero gioachimita presso i suoi contemporanei, resta
comunque prioritaria la necessità di ritornare sulle sue opere per comprenderne
il reale portato, sia per ciò che di veramente innovativo - o, più
correttamente, di singolare - contengono rispetto all'imperante clima culturale
del tempo, sia per ciò che invece appare per certi versi conforme a una
tradizione che sa più di recupero di antichi stilemi.
G. stesso riconduce alle
due visioni del 1183 il momento informante di tutta la sua produzione
letteraria relativa al mistero della Trinità. Dalla meditazione sui Salmi,
in un momento di grave sconforto e dubbio, nasce "quell'intuizione
geometrica del rapporto di unità della sostanza e della trinità delle
persone", grazie alla quale G. perviene alla "nuova percezione
dell'unità della sostanza o essenza divina, che non esiste separata per sé ma
nella triade delle persone, eterna ed al tempo stesso storica" (Selge,
1991, p. 91). La Trinità nella sua unità e nella distinzione delle tre persone
viene colta come operante nella storia e informante di sé le varie età
storiche, secondo un piano di geometrie parallele che consente di
"leggere" le vicende dell'età cristiana, l'età del Figlio, passata e
presente, in costante parallelismo con quella del popolo ebraico del Vecchio
Testamento, l'età del Padre. Ed è in siffatta corrispondenza che G. viene a
legittimare l'avvento di una terza età, quella dello Spirito Santo, intuibile,
per il parallelismo supposto, nei suoi possibili contenuti. Operando in
siffatta maniera G. rompe con gli schemi della teologia e della escatologia
agostiniane che imperavano al momento, secondo le quali dopo la venuta di
Cristo il mondo ormai senescente era di fatto proiettato verso la futura fine
dei tempi, per inserire invece, prima delle tribolazioni e dell'avvento
dell'Anticristo quali preannunciate nell'Apocalisse, un periodo - mai da G.
determinato né nel suo inizio né nella sua durata - in cui sarà reso possibile
da una parte il conseguimento della pienezza della storia (plenitudo historiae),
dall'altra la piena comprensione delle Sacre Scritture o, meglio, del
mistero della Trinità che attraverso la Bibbia si è manifestata e
inverata nella storia. L'intuizione o illuminazione di cui G. dice di essere
stato oggetto a Casamari - ma potrebbe risultare un tòpos fuorviante
e riduttivo darne una lettura prettamente letterale - consiste non nel rifiuto
dei tradizionali strumenti esegetici, ma nell'acquisizione di quella che egli
chiama intelligentia (o intellectus) spiritalis (o spiritualis)
che consente di cogliere la pienezza del significato delle Sacre Scritture.
G. non rigetta le interpretazioni letterali, allegoriche, anagogiche, morali,
proprie della tradizionale esegesi cristiana, anzi se ne avvale a sua volta con
piena padronanza. Tuttavia le ritiene se non inadeguate certo insufficienti:
altrettanti momenti o gradi di conoscenza che tuttavia non esauriscono e non
possono esaurire la conoscenza. Esse costituiscono una sorta di progressioni
ascendenti verso quell'intellectus che sarà invece patrimonio informante
dell'età dello Spirito. Tale intellectus o intelligentia non
è mai inteso come puro strumento conoscitivo, ma come "condizione" (status),
cioè come patrimonio informante di sé un'intera età, che, a sua volta, per le
analogie e i parallelismi con le età che la precedono, sarà caratterizzata da
resistenze, persecuzioni e lotta da parte del Nemico, sempre pronto a frapporre
ostacoli al raggiungimento da parte dei fedeli di siffatta intelligentia
spiritalis.
Si muovono e sono
riconducibili a siffatta "lettura" del testo biblico quasi tutte le
opere di G., soprattutto di quelle considerate maggiori, quali l'Expositio in
Apocalypsim, la Concordia Novi ac Veteris Testamenti, lo Psalterium
decem chordarum, il Tractatus super quattuor Evangelia ma anche le
minori quali l'Adversus Iudaeos e il De ultimis tribulationibus.
La Concordia… è
il primo lavoro della trilogia dedicata al mistero trinitario; consta di cinque
libri di cui i primi quattro sono una sorta di introduzione alla teoria
esegetica di G., mentre il quinto è un commentario sui libri storici del
Vecchio Testamento. G. vi ripercorre la generalis historia del
racconto biblico a partire dai patriarchi fino alla cattività babilonese per
concludere drammaticamente, rilevando la connessione e specularità della
vicenda ebraica con la realtà contemporanea.
L'Expositio in
Apocalypsim è invece dedicata alla persona del Figlio, così come la Concordia lo
era al Padre, e consta di otto libri più un ulteriore liber introductorius.
È forse l'opera che ha maggiormente segnato la "fortuna" di G. e che
risulta strettamente correlata ad altre opere minori che le sono preparatorie o
corollario. L'Apocalisse viene interpretata come una visione che suddivide
la storia della Chiesa in sette periodi, così come sette sono le parti che la
compongono, cui si aggiunge un'ottava parte "che corrisponde alla
glorificazione metastorica della Gerusalemme Celeste" (Tagliapietra, 1994,
p. 80). Ma soprattutto ciò che più di innovativo presenta quest'opera è l'aver
inteso l'Apocalisse non come espressione profetica del momento finale
della storia umana, ma come "racconto" della storia passata, presente
e futura della Chiesa, tale da far apparire il corpus letterario di
G. non solo "un unico e vasto commento alla Scrittura, bensì anche una
imponente teologia della storia paragonabile come portata e come sistematicità
al De civitate Dei di Agostino" (McGinn, 1985, pp. 171 s.).
Conclude la trilogia
dedicata alla Trinità lo Psalterium decem chordarum, incentrato sulla
figura dello Spirito Santo. Il titolo deriva dallo strumento biblico - a dodici
corde - di forma triangolare in cui il vertice del triangolo isoscele è
occupato dal Padre mentre i due lati uguali sono la rappresentazione del Figlio
e dello Spirito Santo. È G. stesso a fornircene la chiave di lettura:
"Quest'opera è divisa in tre libri perché tre sono le persone della
divinità, in cui risiede la bellezza della nostra fede […] vale a dire, il
primo libro, in cui tratto dello strumento musicale che, con grande proprietà
simbolica, si attribuisce al Padre, da cui tutto proviene. Il secondo in cui si
tratta del numero dei Salmi della sapienza divina per cui tutto passa. Il terzo
in cui si tratta del ritmo del canto dei Salmi e dell'istruzione dei cantanti
per la stessa sacra unzione, in cui tutto risiede e che - quando v'è la gioia
interiore e l'esultanza del Sommo Dio - riempie di sacri doni coloro che rende
lieti e gioiosi" (Tagliapietra, 1994, pp. 84 s. dell'introduzione).
Incompiuto invece è
rimasto il Tractatus super quattuor Evangelia. Redatta tra il 1200 e
il 1202, quest'opera è considerata la più radicale di G. proprio perché in essa
viene portato alle estreme conseguenze il sistema esegetico gioachiniano. I
quattro Vangeli sono infatti considerati in stretta connessione tra
loro e in aperta concordanza, anche quando sembrano contraddirsi. Ma
soprattutto il vero tema del trattato sono le storie intrecciate degli Ebrei,
Greci e Latini, tre popoli che G. confida possano ricongiungersi nella comune
fede, nonché la contrapposizione tra la vita monastica e la vita del clero
secolare, riservando alla prima il compito di guidare la Cristianità a quella
pienezza di vita che sarà il traguardo ultimo dell'età dello Spirito.
Una valenza a sé stante
caratterizza infine il Liber figurarum, che, anche se non totalmente
ascrivibile a G., fu senz'altro da lui ispirato nello scriptorium di
S. Giovanni in Fiore. Quest'opera si rivela particolarmente significativa non
tanto o non solo per il contenuto, quanto per la sua stessa natura di tentativo
di esprimere iconograficamente concetti, simbologie e allegorie presenti nelle
opere più propriamente letterarie, che - è opportuno ricordarlo - non si prestano
a una facile lettura. Il tentativo di rappresentare graficamente ciò che ha
acquisito con l'esegesi, induce e un tempo G. a meglio o più compiutamente
caratterizzare quanto elaborato e nello stesso tempo a rivederne, esplicitarne
e definirne nella costrizione della tavola i contenuti stessi. Questo fa sì che
a sua volta la lettura ne risulti più complessa e controversa di quanto sarebbe
lecito attendersi da una serie di immagini; così come la complessità e
cripticità di alcuni passi se non legittimano, certo giustificano non tanto le
divergenze che permangono tra i moderni lettori quanto piuttosto il
fraintendimento che spesso si è avuto del pensiero gioachimita e,
paradossalmente, la indubbia, anche se contraddittoria, "fortuna" del
pensiero di Gioacchino.
L'aver da una parte posto
la Bibbia in posizione centrale ed esclusiva del proprio lavoro
esegetico e nello stesso tempo l'aver rifiutato la visione agostiniana di un
mondo avviato alla consunzione, introducendo l'età dello Spirito, ha fatto sì
che G. venisse accusato di aver sostanzialmente negato tutta la tradizione
cristocentrica, cioè di un Nuovo Testamento che conclude ed esplicita il
messaggio insito nel Vecchio, posticipando di fatto a un altro momento la plenitudo
historiae. L'aver poi quasi assimilato la storia biblica alla storia dell'agire
della Trinità nel temporale in aperta polemica con Pietro Lombardo, da G.
accusato di essersi fatto sostenitore di una Quaternità astratta e avulsa dal
fatto storico, gli alienarono le simpatie della emergente scolastica, gli
attirarono, nel 1215, i fulmini di una condanna della sua teoria trinitaria da
parte del IV concilio Lateranense e determinarono la successiva ostilità di un
Tommaso d'Aquino.
La supposta negazione del
cristocentrismo portò a sua volta, nella seconda metà del XIV secolo, Gerardo
da Borgo San Donnino a ipotizzare la necessità di una sorta di ulteriore
Testamento, un evangelium aeternum, peculiare dell'età dello Spirito
Santo, che egli individuò nelle stesse opere di G. e che gli sarebbe costata la
dura condanna e l'allontanamento dall'Ordine francescano.
Infine, il parallelismo
tra Antico e Nuovo Testamento associato alla tesi che guida e simbolo della
nuova età sarà l'ordomonachorum, o due non meglio precisati ordines, ha
portato alcune frange francescane, più o meno ortodosse, ad appropriarsi di
siffatto ruolo nonché a far risalire, se non ad attribuire, a G. la credenza
che il 1260 sarebbe stato l'anno di inizio della profetizzata età dello
Spirito.
Tali processi esegetici,
assolutamente estranei a G., sono all'origine di una letteratura più o meno
apocalittico-escatologica, che paradossalmente ha decretato la fortuna di un G.
che nulla aveva a che vedere con il G. storico. G. è stato infatti spesso
citato e a lui hanno detto d'ispirarsi, spesso per ragioni di segno opposto,
diverse correnti di pensiero: lo ammirarono George Sand nel racconto Spiridion e
William Butler Yeats nelle Tables of law; in tempi più recenti N. Cohn (The
pursuit of the millennium, 2a ed., New York 1961, pp. 111-113) lo ha visto
ispiratore di Hitler, mentre E. Bloch (Das Prinzip Hoffnung, I-III, Berlin
1954-59), lo considera quasi un Marx prima di Marx.
Opere: Oltre a rinviare
alla "voce" Ioachim abbas de Flore, non firmata ma scritta da
K.-V. Selge per il Repertorium fontium historiae Medii Aevi, VI, Romae
1990, pp. 261-266, si segnalano qui di seguito le principali edizioni e
traduzioni moderne. Tractatus super quattuor evangelia, a cura di E.
Buonaiuti, in Fonti per la storia d'Italia [Medioevo], LXVII, Roma
1930; De articulis fidei, a cura dello stesso, in Scritti minori di
Gioacchino da Fiore, ibid., LXXVIII, ibid. 1936; C. Baraut, Un
tratado inédito de Ioaquín de Flore: De vita sancti Benedicti et de officio
divino secundum eius doctrinam, in Analecta sacra Tarraconensia, XXIV
(1951), pp. 42-118; B. Hirsch-Reich - M. Reeves, The seven seals in the
writings of Joachim of F., with special reference to the tract De septem
sigillis, in Recherches de théologie ancienne et médiévale, XXI (1954),
pp. 211-247 (edizione del De septem sigillis); Adversus Iudeos, a
cura di A. Frugoni, in Fonti per la storia d'Italia [Medioevo], XCV,
Roma 1957; B. McGinn, Ioachim and the Sibyl, in Cîteaux. Commentarii
Cistercenses, XXIV (1973), pp. 128-138 (edizione del De prophetia ignota); Liber
de concordia Novi ac Veteris Testamenti, a cura di E.R. Daniel, Philadelphia
1983; Enchiridion super Apocalypsim, a cura di E.K. Burger, Toronto 1986;
P. De Leo, G. da F. Aspetti inediti della vita e delle opere, Soveria
Mannelli 1988, con le edizioni dei Dialogi de prescientia Dei et
predestinatione electorum (pp. 67-123), Intelligentia super calathis (pp.
135-148), Sermo de Maria Magdalena et Maria sorore Lazari (pp.
157-163), Professio fidei (pp. 173-175); L. Tondelli - M. Reeves - B.
Hirsch-Reich, Il Libro delle figure dell'abate G. da F., presentazione di
R. Rusconi, Torino 1990; K.-V. Selge, De ultimis tribulationibus, in Florensia,
VII (1993), pp. 7-35; Sull'Apocalisse, trad. italiana a cura di A.
Tagliapietra, Milano 1994; Dialogi de prescientia Dei et predestinatione
electorum, a cura di G.L. Potestà, in Fonti per la storia dell'Italia
medievale, Antiquitates, IV, Roma 1995; M. Kaup, De prophetia ignota.
Eine frühe Schrift Joachims von F., in Monumenta Germaniae Historica.
Studien und Texte, XIX, Hannoverae 1998 (trad. it. Commento a una profezia
ignota, a cura di G.L. Potestà - M. Lanfranchi, Roma 1999); Agli ebrei,
trad. it. a cura di M. Iritano, Catanzaro 1998; Trattati sui quattro
Vangeli, trad. it. a cura di L. Pellegrini, Roma 1999.
Si segnala infine la
recente riproduzione in facsimile del manoscritto 322 della Biblioteca
Antoniana di Padova, che, prodotto nello scriptorium florense,
contiene la maggior parte delle opere di G.: Scriptorium Ioachim abatis Florensis:
opere di Gioacchino da Fiore nel codice 322 della Biblioteca Antoniana di
Padova, Bari 1997.
Fonti e Bibl.: Non è
possibile presentare una rassegna bibliografica degli autori che hanno dedicato
la loro attenzione a G. e ai movimenti che al suo pensiero si sono richiamati
nel corso dei secoli XIII-XX. Per quanto riguarda la letteratura storiografica
si rinvia alle rassegne di F. Russo, Bibliografia gioachimitica, Firenze
1954; Id., Rass. bibliografica gioachimita (1957-1967), in Cîteaux.
Commentarii Cistercenses, XIX (1968), pp. 206-214; V. De Fraja, G. da F.:
bibliografia 1969-1988, in Florensia. Bollettino del Centro Internazionale
di Studi Gioachimiti, II (1988), pp. 7-59, nonché ai lavori che seguono, che
aggiornano le predette rassegne o che rivestono particolare rilevanza per la
conoscenza di G.: H. Grundmann, Studien über Joachim von Floris, Leipzig
1927 (trad. it. a cura di G.L. Potestà: Studi su G. da F., Genova 1989);
B. Töpfer, Das kommende Reich des Friedens. Zur Entwicklung chiliastischer
Zukunftshoffnungen im Hochmittelalter, Berlin 1964; M. Reeves, The
influence of prophecy in the later Middle Ages. A study in Joachimism, Oxford
1969; M. Reeves - B. Hirsch-Reich, The "Figurae" of Joachim of
Fiore. A study in Joachimism, Oxford 1972; M.W. Bloomfield, Recent
scholarship on Joachim of F. and his influence, in Prophecy and
Millenarism. Essays in honour of Marjorie Reeves, Horlow 1980, pp. 21-52; B.
McGinn, Symbolism in the thought of Joachim of F., ibid., pp.
143-164; D.C. West - S. Zindar Swartz, Joachim of Fiore. A study in
spiritual perception and history, Bloomington 1983; B. McGinn, The
Calabrian abbot. Joachim of F. in the history of Western thought, New
York-London 1985; V. De Fraja, Un'antologia gioachimita: il manoscritto
322 della Biblioteca Antoniana di Padova, in Studi medievali, s. 3, XXXII
(1991), pp. 231-258; K.-V. Selge, L'origine delle opere di G. da F.,
in L'attesa delle fine dei tempi nel Medioevo, a cura di O. Capitani - J.
Miethke, Bologna 1990, pp. 87-131; R.E. Lerner, Refrigerio dei santi. G.
da F. el'escatologia medievale, Roma 1995; H. Grundmann, G. da Fiore. Vita
e opere, a cura di G.L. Potestà, Roma 1997 (ripubblica in trad. italiana i
saggi Neue Forschungen über Joachim von F., 1950; Zur Biographie Joachims
von F. und Rainers von Ponza, in Deutsches Archiv für Erforschung des
Mittelalters, 1960; Kirchenfreheit und Kaisermacht um 1190. In der Sicht
Joachims von F., ibid., 1963); Medioevo latino, I (1980) e
successivi ad indicess.v. Ioachim de Flore.
© Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata
SOURCE : https://www.treccani.it/enciclopedia/gioacchino-da-fiore_(Dizionario-Biografico)/
GIOACCHINO DA FIORE
di GGian Luca
Potestà
Federiciana (2005)
Nato verso il 1135, dopo
un periodo di formazione nella Curia regia a Palermo e un viaggio in
Terrasanta, ritornò in Calabria, di cui era originario, e divenne monaco e
abate di Corazzo prima del 1177. Risalgono al 1176 i più antichi appunti
riguardanti la concezione della storia (Genealogia), di particolare interesse
in quanto rivelano la sua precoce abitudine di scandire e illustrare
l'ermeneutica storica attraverso il ricorso a figure e diagrammi (sia inseriti
nel corpo degli scritti, sia allestiti autonomamente e raccolti nel Liber
figurarum). Per mostrare l'intima saldatura esistente fra storia del popolo
d'Israele e storia della Chiesa, G. paragona la prima a un tronco di fico su
cui si trova innestata, all'altezza del re Ozia e del profeta Isaia, la vite
del Nuovo Testamento. Le due storie sono corrispondenti per numero di generazioni.
Nel frattempo l'abate si
adoperava per affiliare Corazzo all'Ordine cistercense. Risultati vani i
tentativi compiuti presso le abbazie della Sambucina e di Casamari,
l'affiliazione si realizzò infine per tramite di Fossanova.
A Casamari (1182-1184
ca.) G. si dedicò allo studio della teologia trinitaria e interpretò un oscuro
testo profetico presso la Curia papale.
Nella successiva fase di
rinnovato conflitto fra l'Impero di Federico I e il papato di Lucio III e di
Urbano III, suggerì alla Chiesa romana una linea arrendevole, venendo per
questo attaccato dall'anziano e influente abate Goffredo di Auxerre, già
segretario di Bernardo di Clairvaux. La risposta di G. è racchiusa in un breve
scritto noto come Intelligentia super calathis ('Interpretazione dei
cestini', in riferimento alla visione di Geremia 24 dei due canestri contenenti
fichi buoni e cattivi). Come i fichi buoni del profeta, anche la Chiesa romana
deve stare in basso e disporsi a una nuova 'cattività babilonese',
sottomettendosi all'Impero e abbandonando piani di resistenza armata destinati
comunque al fallimento. L'Intelligentia propone una strategia politica,
mirante ad attenuare i motivi di conflitto con l'Impero, e insieme una
concezione vicissitudinaria della storia, per cui il conseguimento di
un'autentica libertà presuppone il passaggio attraverso la 'confusione' di
un'umile servitù.
La caduta di Gerusalemme
(1187) dette impulso alla sua visione apocalittica, che dalle vicende in atto
trasse motivi per intensificare gli annunci relativi all'incombere
dell'Anticristo (v.). Contro la concezione tradizionale (legata ai nomi di
Gerolamo, dello PseudoMetodio e di Adsone di Montier-en-Der), che lo collocava
in Oriente, l'abate spiegò a Riccardo Cuor di Leone, mentre era a Messina in
attesa di partire per la crociata (inverno 1190-1191), che l'Anticristo era già
nato in Occidente e di lì a poco si sarebbe manifestato a Roma. Nel Prologo della Concordia
Novi ac Veteris Testamenti, la prima delle tre grandi opere a essere conclusa
(entro il 1196), si presenta come la sentinella chiamata ad avvertire la Chiesa
romana dell'avvicinarsi del nemico. La 'concordia' è un sistema interpretativo
della storia che, ponendo in parallelo serie di avvenimenti pertinenti
rispettivamente alla discendenza di Israele e alla Chiesa, consente di
decifrare alla luce del passato il processo in corso e di prevederne gli esiti
ultimi. Rispetto alla tradizione escatologica improntata dalla ricerca dei
segni terribili dell'Anticristo, G. si caratterizza per la convinzione che,
dopo la venuta di costui, debba dispiegarsi un'età sabatica in terra, di cui
scorge un preannuncio nel passo di Apocalisse 20 riguardante
l'incarcerazione di Satana "per mille anni". In realtà, più che il
celebre passo apocalittico, erano state le speculazioni teologiche ed
ecclesiologiche a spingerlo, fin dalla prima redazione (anni Ottanta) del
grande trattato trinitario successivamente denominato Psalterium decem
cordarum, a riconsiderare in prospettiva ternaria l'originario schema binario
della Genealogia. Mosso dalla duplice esigenza di conferire rilievo alla
Trinità e in particolare all'azione dello Spirito Santo e di valorizzare ruolo
e funzioni dell'ordo dei monaci nella Chiesa e nella società, articolò la
storia in tre grandi epoche: lo stato dei coniugati, attribuito al Padre,
l'epoca dell'Antico Testamento posta sotto la natura e sotto la legge; lo stato
dei chierici, attribuito al Figlio, l'epoca del Nuovo Testamento posta sotto la
grazia; lo stato dei monaci, attribuito allo Spirito, l'epoca
dell'interpretazione spirituale dell'Antico e del Nuovo Testamento posta sotto
una grazia maggiore (ovvero 'più ampia') rispetto a quella dell'epoca di Gesù
Cristo, ancora segnata dalla carnalità nella comprensione del mistero divino
celato nelle Scritture.
Spinto dalle polemiche
monastiche e dalla convinzione dell'imminenza dell'Anticristo e del terzo
stato, lasciò infine il governo di Corazzo e, insieme al compagno Raniero da
Ponza, monaco di Casamari, avviò una nuova forma di vita eremitica sulla Sila,
dando all'insediamento la denominazione simbolica di 'Fiore' (1189-1190). Come
si apprende dalla Vita composta da un monaco anonimo vicinissimo al
"nostro Mosè" (Grundmann, 1997, p. 183), gli inizi furono difficili
per la dichiarata ostilità di alcuni emissari di Tancredi, impadronitosi del
Regno dopo la morte di Guglielmo II. L'abate ottenne infine il favore del
sovrano, espresso in un privilegio, non conservatosi, a sostegno dell'eremo.
Poco dopo scendeva in Italia Enrico VI, per ottenere a Roma la corona imperiale
e per assumere il governo del Regno contro il pretendente normanno (1191). In
tale fase incerta e drammatica per il papato, favorevole a Tancredi ma timoroso
della reazione imperiale, G. fu tra gli alti ecclesiastici del Mezzogiorno
particolarmente aperti alla causa degli Svevi e tra i più pronti a ottenerne il
favore. Dal 1194 prima il sovrano, poi la moglie Costanza e infine il piccolo
Federico II dotarono di privilegi S. Giovanni in Fiore, contribuendo in modo
decisivo al primo sviluppo della nuova congregazione florense (v. Florensi),
riconosciuta da papa Celestino III nel 1196.
Negli ultimi anni l'abate
portò a compimento le opere principali: conclusa la Concordia, nel breve
trattato De ultimis tribulationibus modificò il calendario degli
avvenimenti finali fissato nei capitoli conclusivi di essa; rivide e corresse
lo Psalterium fino alla vigilia della morte; completò infine la terza
grande opera, il Commento all'Apocalisse (Expositio in Apocalypsim),
dopo avervi lavorato per oltre quindici anni e averne fornito abbozzi in forma
di sermoni e di introduzioni (Enchiridion super Apocalypsim, Liber
Introductorius). Numerosi altri scritti, nati prevalentemente dall'attività
sermocinale, sono in effetti semplici 'contenitori' di appunti e abbozzi
(l'esempio più significativo è offerto in questo senso dal De vita et
Regula sancti Benedicti) ovvero testi rimasti incompiuti (Tractatus super
quatuor Evangelia). L'avvento di Innocenzo III segnava peraltro l'affermarsi di
linee teologico-politiche divergenti da quelle lungamente perseguite
dall'abate. Prudentemente, poco prima della morte (1202) stese una lettera
testamentaria, in cui rivendicava la sua intenzione ortodossa, attenuava i
possibili motivi di conflitto con la Chiesa romana, sottomettendo gli scritti e
la propria memoria al giudizio di quest'ultima. Iniziava da quel momento la sua
controversa fortuna. Mentre la cifra teologica venne offuscata dalla condanna
della dottrina trinitaria emessa dal IV concilio lateranense (1215; v.), la
fama di profeta crebbe nel sec. XIII grazie alla vasta letteratura
pseudoepigrafica (v. Profetismo) e all'appropriazione del messaggio da
parte dell'Ordine dei Minori.
Fonti e Bibl.: K.-V.
Selge, Elenco delle opere di Gioacchino da Fiore, "Florensia",
3-4, 1989-1990, pp. 25-35. Successivamente sono stati criticamente pubblicati o
ripubblicati i seguenti testi di G.: Id., Ein Traktat Joachims von Fiore
über die Drangsale der Endzeit: 'De ultimis tribulationibus', ibid., 7,
1993, pp. 7-35; Gioacchino da Fiore, Dialogi de prescientia Dei et
predestinatione electorum, a cura di G.L. Potestà, Roma 1995; M. Kaup, De
prophetia ignota. Eine frühe Schrift Joachims von Fiore, Hannover 1998;
G.L. Potestà, Die Genealogia. Ein frühes Werk Joachims von Fiore und die
Anfänge seines Geschichtsbildes, "Deutsches Archiv für Erforschung des
Mittelalters", 56, 2000, pp. 55-101; Gioacchino da Fiore, Tractatus
super quatuor Evangelia, a cura di F. Santi, Roma 2002. H. Grundmann, Gioacchino
da Fiore. Vita e opere, a cura di G.L. Potestà, ivi 1997 (raccoglie in
traduzione italiana i tre saggi: Neue Forschungen über Joachim von Fiore,
Marburg 1950 [Nuove ricerche su Gioacchino da Fiore, pp. 1-100]; Zur
Biographie Joachims von Fiore und Rainers von Ponza, "Deutsches Archiv für
Erforschung des Mittelalters", 16, 1960, pp. 437-546, poi in Id., Ausgewählte
Aufsätze, II, Stuttgart 1977, pp. 255-360 [Per la biografia di Gioacchino da
Fiore e Raniero da Ponza, pp. 101-202]; Kirchenfreiheit und Kaisermacht um
1190 in der Sicht Joachims von Fiore, "Deutsches Archiv für Erforschung
des Mittelalters", 19, 1963, pp. 353-396, poi in Id., Ausgewählte
Aufsätze, pp. 361-402 [Libertà della Chiesa e potere imperiale intorno al 1190
nella visione di Gioacchino da Fiore, pp. 203-242]); M. Reeves-B.
Hirsch-Reich, The 'Figurae' of Joachim of Fiore, Oxford 1972; M.
Reeves, The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages. A Study in
Joachimism, Notre Dame-London 19932; G.L. Potestà, Gioacchino da Fiore,
Bari 2004. V. De Fraja, Gioacchino da Fiore: bibliografia 1969-1988,
"Florensia", 2, 1988, pp. 7-59; C. Caputano, Gioacchino da
Fiore: bibliografia 1988-1993, ibid., 8-9, 1994-1995, pp. 45-110; M. Rainini, Gioacchino
da Fiore: bibliografia 1994-2001, ibid., 16-17, 2002-2003, pp. 103-163.
© Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata
SOURCE : https://www.treccani.it/enciclopedia/gioacchino-da-fiore_(Federiciana)/
Sito del Centro Studi
Gioachimiti : https://www.centrostudigioachimiti.it/
Pierre DEGHAYE.
«Henri de Lubac et Joachim de Flore » :
http://www.esswe.org/uploads/user-files/A03-03-Deghayte-Henri-de-Lubac-et-Joachim-de-Flore.pdf
Barbara OBRIST. « Image et prophétie au
XIIe siècle : Hugues de Saint-Victor et Joachim de Flore », Mélanges
de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes Année 1986
Volume 98 Numéro
1 pp. 35-63 : http://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5110_1986_num_98_1_2850
Borromean Rings in
Christian Iconography : https://web.archive.org/web/20120414231546/http://www.liv.ac.uk/~spmr02/rings/trinity.html
Voir aussi : http://www.revistamirabilia.com/sites/default/files/pdfs/2012_01_03.pdf
http://www.liv.ac.uk/~spmr02/rings/trinity.html
http://www.centrostudigioachimiti.it/Gioacchino/GF_luoghieng.asp

02.jpg)



_Joaquin_de_Fiore(1135-1202).jpg)

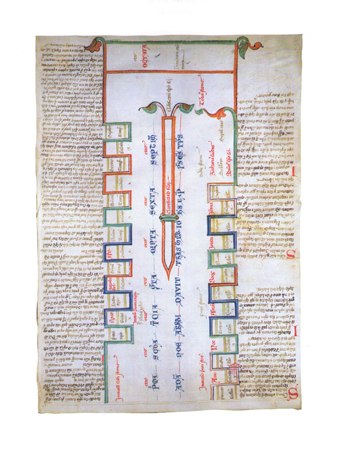
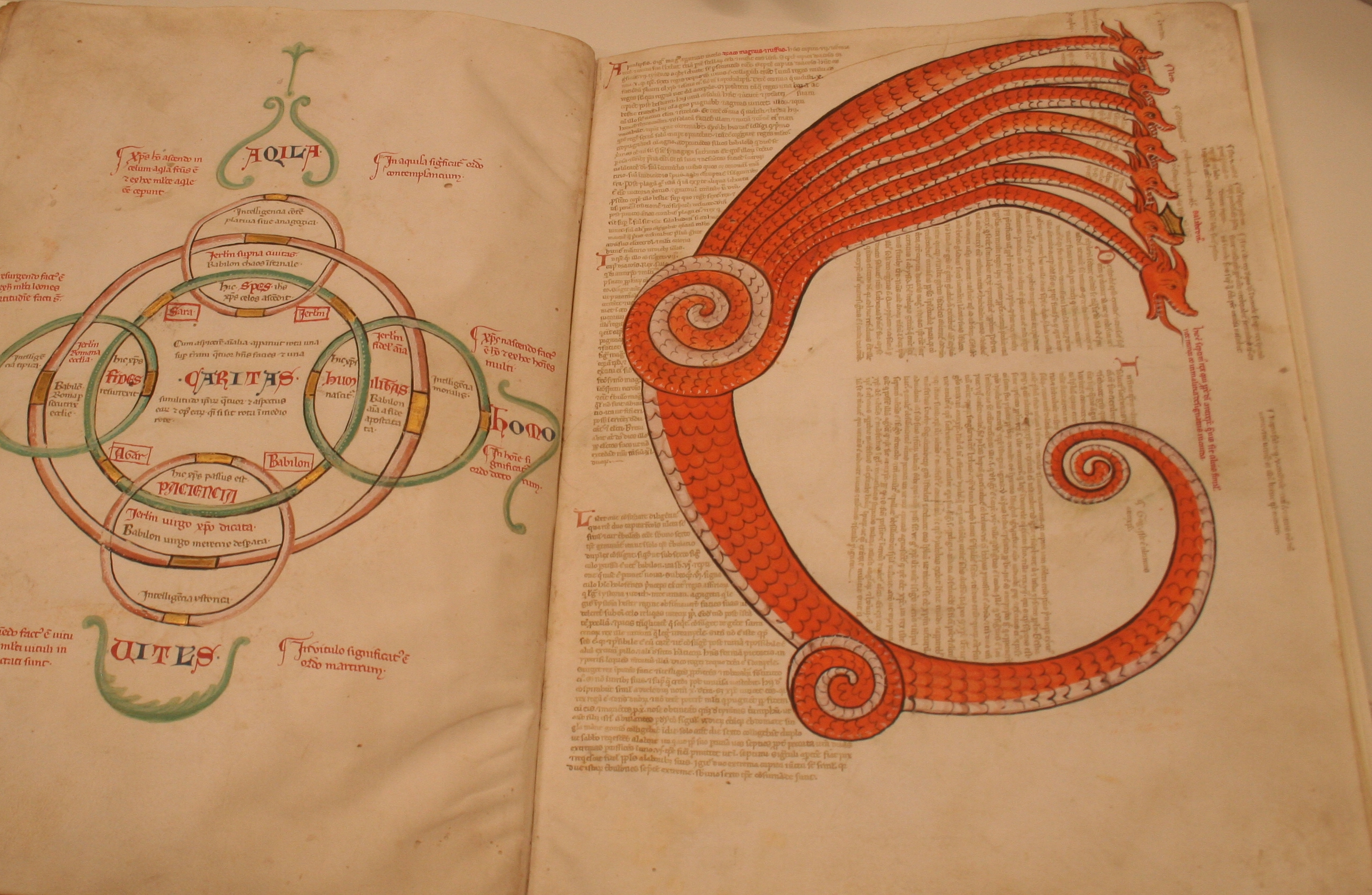
_Joaquin_de_Fiore(1135-1202).jpg)



01.jpg)
04.jpg)